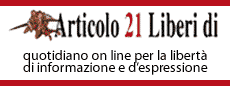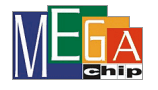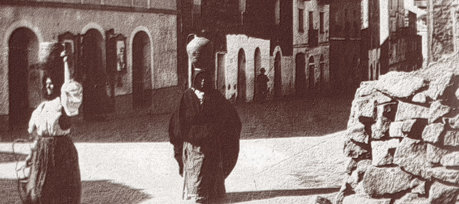Massimo
Ciancimino e Gaspare Spatuzza ricostruiscono nuovi scenari sulla strage.
Quando incominciò la trattativa fra lo Stato e Cosa nostra? Prima di
quanto ipotizzato finora
di Pietro Orsatti
Via D’Amelio, luogo
della strage del 19 luglio 1992 dove persero la vita Paolo Borsellino e
i componenti della sua scorta, da Castel Utveggio si vede proprio bene.
È ormai “verità” processuale (riportata nelle sentenze del
processo Borsellino bis) che il Sisde vi avesse impiantato da tempo una
sede sotto copertura. E il 19 luglio 1992, una classica domenica estiva
palermitana, Castel Utveggio, da quello che è emerso dalle indagini
successive, è in piena attività. Pochi secondi dopo la strage, proprio
da qui parte una telefonata che raggiunge Bruno Contrada, al tempo capo
del Sisde a Palermo. La chiamata arriva dal telefono intestato a Paolo
Borsellino. Si tratta, evidentemente, di un’utenza clonata. Da chi?
Mistero. E ancora. Di solito il castello è deserto la domenica,
figuriamoci a luglio. Ufficialmente era solo la sede di una scuola di
formazione per manager aziendali. Quella domenica, però, nel castello
c’è “movimento”. Tanto movimento. Troppo. E andiamo avanti.
Lorenzo Narracci, al tempo funzionario del Sisde a Palermo, riceve una
telefonata da Contrada 80 secondi dopo l’esplosione dell’autobomba.
Per intenderci, poco più di un minuto dopo l’esplosione il Sisde è
già pienamente operativo, mentre la polizia ancora arranca per capire
cosa sia successo e persino dove. Narracci non è sconosciuto agli
investigatori che stanno seguendo l’inchiesta sulla strage di Capaci,
e risulta infatti titolare di un numero di cellulare annotato su un
biglietto rinvenuto proprio sul luogo dove gli assassini di Falcone
azionarono il telecomando che innescò il tritolo lungo l’autostrada
fra Punta Raisi e Palermo. Su come sia finito il numero di telefono di
un funzionario dei servizi italiani proprio nella casupola utilizzata da
Cosa nostra per dare via all’attentato di Capaci c’è un altro
funzionario della Polizia che, sempre dagli atti processuali, racconta
di essersi perso lui, durante il sopralluogo, il biglietto con il
numero. Comunque una vicenda che allarma, se non altro per la leggerezza
con cui un’utenza di un agente circolasse con tale facilità e
mancanza di riservatezza.
A seguire questa pista è Gioacchino Genchi,
all’epoca dirigente della Polizia di Stato a Palermo con l’incarico
di direttore della zona telecomunicazioni del ministero dell’Interno
per la Sicilia occidentale. Genchi, per chi si occupa di inchieste
giudiziarie, non è uno sconosciuto. Lo scorso anno, per esempio, è
salito alle cronache come l’uomo chiave dell’inchiesta “Why not”
condotta dal pm Luigi De Magistris a Catanzaro. Insomma, quantomeno uno
che di telefoni ne capisce. Il giorno stesso della strage di via
D’Amelio, Genchi compie un sopralluogo sul monte Pellegrino presso il
castello Utveggio insieme al capo della Mobile La Barbera. La sentenza
del processo Borsellino bis riporta, testualmente: «Il dr. Genchi ha
chiarito che l’ipotesi che il commando stragista potesse essere
appostato nel castello Utevggio era stata formulata come ipotesi di
lavoro investigativo che il suo gruppo considerava assai utile per
ulteriori sviluppi; essa tuttavia era stata lasciata cadere da chi
conduceva le indagini al tempo». Elementi, quelli accolti dalla Corte e
presentati dall’investigatore, davvero inquietanti. Utenze clonate,
rete di comunicazioni lungo il percorso per via D’Amelio operativa da
giorni, intrecci fra pezzi di Stato e “altro”. «Nel castello aveva
sede un ente regionale il C.e.r.i.s.d.i., dietro il quale avrebbe
trovato copertura un organo del Sisde - si legge nella sentenza -. La
circostanza era stata negata dal Sisde che aveva così esposto ancor più
gli uomini del gruppo investigativo costituito per indagare sulla strage».
Genchi punta la sua attenzione sul castello per una ragione specifica.
Trascrizione letterale della sua deposizione alla Corte di Caltanissetta:
«Rilevo che il cellulare di Scaduto, un boss di Bagheria condannato
all’ergastolo fra l’altro per l’omicidio di Ignazio Salvo che
aveva tutta una serie di strani contatti con una serie di utenze del
gruppo La Barbera. Cioè, del gruppo degli altofontesi, di cui parlavo
anche in relazione a quei contatti con esponenti dei servizi segreti,
rilevo che questa utenza aveva pure contatti con il C.e.r.i.s.d.i.
Quindi, questo C.e.r.i.s.d.i. mi ritorna un po’ come punto di
triangolazione». Genchi prosegue raccontando di una strana telefonata
che arriva al castello nei giorni che precedono la strage. «C’è pure
una telefonata, se ricordo bene, mi pare… di Scotto al C.e.r.i.s.d.i.
Ovviamente, non so, avrà fatto un corso di eccellenza, perché là
preparano manager, non so, avrà avuto le sue ragioni per telefonare».
Scotto chi è? C’è un certo Pietro Scotto, dipendente della società
di servizi telefonici Elte, che ha un fratello, Gaetano, sospetto
mafioso appartenente alla famiglia di Cosa nostra del rione Acquasanta
di Palermo. è proprio Gaetano a mettersi in contatto con utenze del
C.e.r.i.s.d.i. nei mesi precedenti l’attentato. Una coincidenza? E chi
ha messo in atto l’intercettazione dei telefoni dei familiari di Paolo
Borsellino residenti in via D’Amelio? Comunque, nonostante Genchi
individui da subito tutte queste connessioni, viene trasferito a
indagini ancora in corso, e con lui anche La Barbera.
Andiamo ai giorni che precedono l’attentato. Si
segnala nella sentenza del processo «la testimonianza di un agente Dia
che si era trovato a fare da autista a Borsellino subito dopo
l’interrogatorio di Mutolo, lo aveva trovato sconvolto e gli aveva
sentito pronunciare nel corso di una conversazione telefonica la frase
“Adesso noi abbiamo finito. Adesso la palla passa a voi”. Le
telefonate erano dirette verosimilmente al procuratore Vigna e al
procuratore Tinebra (procuratore di Caltanissetta, ndr) che aveva appena
iniziato a indagare su Capaci». È il primo luglio. Di quella giornata
c’è traccia autografa di Paolo Borsellino. Una pagina di un’agenda,
grigia. Non parliamo di quella rossa, dalla quale il giudice non si
separava mai, e scomparsa sul luogo dell’attentato (nell’agenda
rossa Borsellino aveva iniziato a scrivere tutto ciò che accadeva dal
giorno di Capaci. Come ha affermato Genchi «qualcuno si è fatto
un’assicurazione»). Torniamo all’altra agenda, quella grigia,
fortunatamente ancora in mano ai familiari. Vi è riportato l’incontro
fra il magistrato e il ministro degli Interni. Il primo luglio è il
giorno di insediamento di Nicola Mancino, che però nega di aver avuto
un incontro con il magistrato. Tuttavia proprio nei giorni scorsi,
l’attuale vicepresidente del Csm ha affermato: «Quel giorno ho
stretto tante mani. Non ricordo Borsellino, ma non escludo di poterlo
aver incontrato».
Un nuovo spiraglio lo ha aperto Massimo Ciancimino.
Racconta che la trattativa, quella che portò poi al famoso
“papello” di Totò Riina con le richieste allo Stato da parte di
Cosa nostra, non iniziò mesi dopo la strage di via D’Amelio, ma nei
primi di giugno, ovvero nel periodo in cui il pm stava scavando sui
mandanti ed esecutori dell’omicidio del suo amico e collega Giovanni
Falcone avvenuto a maggio. Sempre secondo Ciancimino, protagonisti di
questa trattativa sarebbero stati il capo dei Ros dei carabinieri Mario
Mori, Vito Ciancimino (e lo stesso Massimo che è colui, per sua stessa
ammissione, che ha il primo contatto con l’Arma), Totò Riina dal suo
covo da latitante e il medico della mafia, il boss Antonino Cinà. Non
solo, Ciancimino racconta che i contatti iniziali con i vertici di Cosa
nostra avvenivano attraverso Cinà ma che il “papello”, ovvero le
proposte di Riina allo Stato, non fu consegnato a Vito Ciancimino dal
medico della mafia, ma da “una persona distinta” il cui nome per ora
è coperto da omissis. Un altro colletto bianco? O un soggetto terzo?
Questo elemento crea il sospetto che una delle
motivazioni alla base dell’accelerazione dei preparativi (se non della
decisione) dell’omicidio Borsellino, sia da cercare nel probabile
rifiuto da parte del giudice di accettare la trattativa. Quasi a fare da
“sponda” e a mettere in discussione le poche verità emerse dai vari
processi sul 19 luglio 1992, è apparso non un nuovo pentito ma un
soggetto dichiarante. Che si autoaccusa di essere colui che ha rubato
per la mafia la 126 utilizzata poi come autobomba a via d’Amelio. Si
tratta di Gaspare Spatuzza, uno dei killer di padre Puglisi, che con le
sue dichiarazioni ha rimesso in discussione alcuni dei fondamenti del
processo, aprendo di conseguenza la possibilità di una revisione. Anche
nelle sue dichiarazioni emerge un “uomo senza nome”. Consegna,
infatti, la 126 ad alcuni mafiosi di sua conoscenza ma alla presenza di
un altro uomo, sconosciuto, che lui ritiene “estraneo”. Un altro
volto invisibile, senza nome, da sommare a quella che comincia a
sembrare una folla di anonimi onnipresenti, amnesie, documenti
scomparsi, trasferimenti affrettati di investigatori a indagini aperte,
archiviazioni, funzionari infedeli, telefoni clonati. Spettatori,
protagonisti, comparse, componenti che si sono dati appuntamento alle
16,58 e 20 secondi del 19 luglio 1992.
23 gennaio 2009
|