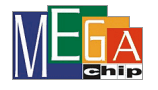Sono trascorsi ormai più di due anni da quando, in un saggio sull’architettura nuorese, dissi peste e corna dell’attuale Piazza Sebastiano Satta. Una successiva meditazione sul medesimo tema mi induce, ora, a ritenere che di quella stessa piazza non dissi allora male abbastanza. Cercherò, quindi, di farlo adesso.
Intendiamoci. Non dissi male di Costantino Nivola, lo scultore che a suo tempo adempì all’incarico di curarne l’arredo ornamentale, così impiantandovi quel tipo di sovrastrutture che, peraltro, a Nuoro non riscossero e non riscuotono l’unanime consenso. Ma Nivola non è responsabile di quella sorta di aborto urbanistico definibile unicamente come un vacuum urbano, creato mediante continuazione di un’attività demolitoria iniziata nell’Ottocento con l’abbattimento di un antico edificio adibito a carcere e completata poi, negli anni Sessanta del secolo scorso, da quegli Amministratori cittadini che ordinarono la demolizione del settecentesco palazzo ove per alquanto tempo visse Menotti Gallisay, nonché di un delizioso palazzetto, questa volta ottocentesco, nel cui interno venivano custoditi gli antichi documenti da trasferire all’Archivio di Stato. Peste e corna, se mai, andavano dette di quegli Amministratori, i quali credevano che, nell’ambito dei centri urbani già edificati, le piazze potessero essere create ex novo semplicemente demolendo un certo numero di case, dotando poi il risultante vacuum di selezionate sovrastrutture.

Le piazze degne di questo nome, però, sono
cosa ben diversa dalla creazione di quel vacuum di cui ho or ora parlato.
Che cosa infatti esse siano, nella realtà, è presto detto: secondo la
più semplice delle tante definizioni possibili (l’una equivalente
all’altra, o di essa complementare) sono i luoghi creati appositamente da
avveduti urbanisti perché in esse i cittadini possano ritrovarsi al fine di
ostentare, gli uni al cospetto e nei confronti degli altri, un’acquisita
coscienza della loro identità collettiva.
E’ chiaro, quindi, che di
Nivola non può essere detto male, essendo lui responsabile solo delle
sovrastrutture, non già della struttura architettonica.
E ciò che caratterizza la piazza, che la rende degna di questo nome,
nonché idonea al bisogno sociale di cui si è detto, è la struttura, non già
la sovrastruttura.
Forse non tutti sanno che cosa sia la struttura architettonica di una piazza: è certo solo che non lo sapevano i sullodati amministratori. Conviene allora, per poter continuare proficuamente il discorso, ricominciare quest’ultimo daccapo e, con la santa pazienza, ripercorrere un iter culturale che sembra smarrito. Occorre, cioè, prendere le mosse dalla più accessibile definizione del termine “piazza”.
-ori.jpg)
Marco Romano, trattando proprio questo
specifico tema, ha di recente (scrivendone in modo ampio sulle pagine de Il
Domenicale del 31 gennaio 2009) dato della piazza una definizione dalla quale
ben possono essere prese le mosse per il proficuo completamento di un discorso
pedagogicamente utile. La seguente:
“spazio libero circondato e delimitato da case abbastanza alte, perché alla
vita collettiva occorre riconoscibilità e intimità”.
Non uno spazio semplicemente
vuoto, quindi, ma un quid consistente nella tangibile proiezione esterna
dell’intimità della vita privata, del vissuto cioè che promana da quelle
abitazioni che con la loro ben curata, prospiciente facciata sono idonee a
creare una sorta di salotto buono da tutti frequentabile.
Ma perché case alte?
La risposta è ovvia.
Oltre un evidente motivo di eleganza, vale la considerazione che ad
affacciarsi sullo spiazzo antistante non sono soltanto le esterne strutture
architettoniche dei palazzi, ma specificamente ciascuna delle abitazioni che
compongono le strutture medesime. E
queste devono essere numerose, ossia tante quante ne occorrono perché sia reso
visibile il simbolo di un’ampia partecipazione collettiva alla vita pubblica
del rione, intrisa di sana, eloquente umanità.
Un’autentica commistione, insomma, di vite individuali e di vita collettiva, quella che solo un considerevole numero di esperienze squisitamente umane riesce a esprimere attraverso un’immagine tutt’altro che anonima. Non a caso, infatti, Marco Romano pubblica, a corredo del proprio enunciato, una significativa foto raffigurante la Piazza del Campo di Siena.
Non mi pare, allora, di dover andare molto
oltre con le enunciazioni teoriche, se non per accennare al tema (non
trascurato, certo, da Marco Romano nel suo qui citato scritto) inerente alla
differenza concettuale tra spazi pubblici e spazi collettivi.
Differenza concettuale, s’è detto; e ciò
perché tra i due termini del raffronto intercorre il divario che separa il
genus dalla species. Laddove è
chiaro che lo spazio collettivo (species) idealmente rientra, bensì (ma senza
esaurirlo), nel più ampio concetto di spazio pubblico (genus); il quale ultimo,
quindi, comprende nella propria gamma anche gli spazi che, non rientrando in
quella species, non dovrebbero mai essere definiti “piazze” (non a caso,
infatti, gli avveduti urbanisti li denominano “piazzali”).
Ed è qui importante
conformarsi a tale distinzione, perché proprio essa ci riconduce al tema
iniziale, quello inerente al caso della Piazza Sebastiano Satta.
La quale, in base a quanto si è detto, non dovrebbe neppure essere
definita “piazza”, trattandosi appunto di un semplice “piazzale”, perché
verso di essa non converge affatto quel coacervo di eloquenti frammenti
di umanità che solo le autentiche abitazioni (per di più orientate con le loro
facciate su tutti i lati dello spazio vuoto) sono capaci di esprimere.
Nel detto spazio, in concreto
ricavato mediante inconsulte demolizioni, solo una piccola parte del complesso
è delimitata da abitazioni; neppure rispondenti, peraltro, a una tipologia
capace di rispecchiare, da sola, quell’etnia che invece, mediante le
sovrastrutture, si è in qualche modo cercato di raffigurare.
Magari, in altro scritto, esprimerò ancora una volta il perché - pur con tutto il rispetto per gli estimatori dell’opera di Costantino Nivola (e tra essi Vittorio Sgarbi) - a me quella sovrastruttura non piace.
Mario Corda
---------------------------------------
PERCHE’
NON MI PIACE LA PIAZZA SEBASTIANO SATTA
di
Mario Corda
Parte 2
Quando fu completato il lavoro di posa in opera delle sovrastrutture , le rocce “al naturale” che ornano la Piazza Sebastiano Satta, i nuoresi, sempre pronti all’intelligente sarcasmo, fecero circolare una spiritosa barzelletta.
Due donne
olianesi, transitando in quel sito, si fermano a contemplare l’opera.
-
Guardate, comare, che bella piazza hanno ricavato.
-
Più bella, comare, sarà a lavoro finito, quando la completeranno mediante
asportazione di quelle rocce.
Le rocce,
inutile dirlo, sono i grandi massi granitici, magnificamente traforati
dall’erosione dell’acqua in chissà quale era geologica, durante la quale
essi palesemente giacevano in un fondo marino.
Divelti, poi, da non so quale plaga dell’Isola, ove la Natura li aveva
collocati (appunto in quella originaria superficie che una successiva era
geologica aveva fatto emergere) e ove facevano bellissima mostra di sé come
autentico monumento naturale, furono trasportati a Nuoro per essere destinati
all’ornamento della piazza, in attuazione del progetto ideato dallo scultore
Costantino Nivola.
Quello
stesso progetto che, una volta realizzato, ha incantato Vittorio Sgarbi
(palesemente d’accordo con la prima delle due donne olianesi della
barzelletta, ma in disaccordo con l’altra) e che a me, invece, francamente non
piace. Pur con tutta la
consapevolezza del diverso peso che potranno avere i due contrastanti giudizi.
In un
saggio sull’architettura nuore di qualche anno fa trovato modo di esternare le
ragioni del perché non apprezzo il risultato estetico di quella singolare,
inusitata progettazione; così come nel precedente scritto sul medesimo tema,
apparso più recentemente in questa rivista on line, ho indicato le
specifiche ragioni per le quali non ho mai apprezzato la
struttura della sullodata piazza
(frutto di due scriteriate demolizioni di edifici, non già
- come dovrebbe essere per una piazza che aspiri ad essere un qualcosa di
più che un semplice, anonimo “slargo destinato all’uso pubblico” -
dell’intelligente progettazione di un urbanista specializzato).
In questa stessa sede, oggi, vorrei appunto chiarire il perché, con
riferimento a quella discussa piazza, non apprezzo neppure il risultato del
progetto ideato dallo scultore Nivola.
La prima
ragione, non di poco conto (a mio avviso), è quella che scaturisce dal rilievo
in base al quale le rocce in questione stavano bene dove stavano, dove la Natura
le aveva collocate. In tutta
modestia, io, per il mio modo di concepire le bellezze naturali e di rispettare
l’avvenuta attuazione del cosiddetto Disegno Intelligente, non
le avrei mai divelte dal luogo ove si trovavano. Non so quale esso fosse (né voglio saperlo, perché so che,
transitando eventualmente in quel luogo, proverei dispiacere nel constatare il
vuoto che è stato creato); ma è certo che le rocce de quibus agitur
costituivano parte integrante di un paesaggio che, in quanto tale, andava
giuridicamente protetto (articolo 9, secondo comma, della Costituzione) e che doveva
essere protetto, ad opera della Pubblica Amministrazione, anche mediante
l’adozione di semplici ma efficaci reprimende, visto che il Ministero
dell’Ambiente non era stato ancora istituito (lo sarà solo più tardi, in
virtù della provvidenziale legge 8 luglio 1986, n.349).
Ma
lasciamo da parte le disquisizioni giuridiche, e occupiamoci di quelle
estetiche, nel cui ambito mi sarà consentito di esternare le mie ragioni del
preannunciato dissenso.
Le rocce
di cui parlo, quando si trovavano al loro posto, ben potevano essere considerate
un quid
appartenente al genere delle bellezze
naturali; sono state, però,
divelte da un’impietosa ruspa e, quindi, trasportate nella piazza perché una
volta compiuta siffatta operazione potessero essere considerate opera
d’arte. Una materiale trasposizione capace (secondo le intenzione) di
attuare l’inusitata verborum
traiectio finalizzata a rendere
equivalenti le espressioni verbali bellezza naturale e opera
d’arte; capace, quindi (sempre
secondo certe intenzioni), di attuare la concettuale identificazione della piacevolezza
sensoriale con la piacevolezza
intellettuale.
Ma è
proprio la possibilità di attuare una siffatta trasformazione che mi sento di
poter negare con forza. Vediamone
il come e il perché.
Non credo,
come non ho mai creduto, che il concetto di opera
d’arte possa andare disgiunto da quello racchiuso nell’espressione verbale messaggio
dell’artista: Inteso,
quest’ultimo, come offerta di un’idea
(scaturita, previa intuizione,
dalla mente dell’artista) a un’indistinta generalità di possibili
destinatari.
Non
un’idea qualunque, dissi una volta in un altro saggio (e mi piace qui
ripeterlo), ma un’idea improntata a un principio di valore (e, in questo, non
mi distaccavo granché dall’enunciato di Charles Morris, il quale concepisce
l’arte come “un luogo d’incontro dei valori”).
Ma aggiunsi che la possibilità di ricezione di quell’idea risiedeva,
principalmente, nel grado di piacevolezza
intellettuale cui è improntata la
forma del messaggio, qualunque sia il mezzo espressivo adoperato dall’artista.
Continuavo, poi (nel saggio), con l’elaborazione di una teoria che
prende le mosse, proprio, dal fatto della concretezza del recepimento del
messaggio, da parte della generalità dei possibili destinatari.
Qui però, per limitarmi a ciò che consente la continuazione del
discorso nella sua specificità, ossia di quello
inerente alla (da me) decisamente negata possibilità di barattare la piacevolezza
sensoriale per piacevolezza
intellettuale, è già sufficiente
fermarsi alla insuperabile constatazione che la diversità semantica è
simmetrica, connaturale a una innegabile differenza di rango ontologico tra i
due catalogati concetti.
*
* *
Non
occorre, certo, imbarcarsi in dotte citazioni che tirino in ballo Gassendi o
Descartes. Sanno tutti, infatti, qual è la differenza, (come si è
accennato) di rango ontologico, tra senso e intelletto.
Sicché non dovrebbe risultare difficile ad alcuno soffermarsi a
considerare che una cosa è la piacevolezza
sensoriale (ossia quella recepita
in modo immediato per mezzo dell’attivazione di uno qualunque dei cinque
sensi), altra cosa è la piacevolezza
intellettuale, intesa come effetto
dell’essenza del bello artistico, recepita appunto dall’intelletto in virtù
di quella consonante intuizione che
accomuna il mittente
e il destinatario.
L’intuizione,
appunto. Ancora una volta,
l’intramontabile Benedetto Croce può aiutarci a capire.
Ma un qualche esempio potrà servire, io credo, a rendere più
accessibile il concetto che ho già avuto occasione di illustrare nell’ultimo
dei citati saggi (e, scusandomi per l’autocitazione, chiarisco che ciò faccio
solo per evitare la pesantezza dei chiarimenti che apparissero indispensabili);
concetto che, qui, vorrei fosse chiaro al lettore.
La vista
di un fiore, di un bel paesaggio o di quant’altro, suscita nell’osservatore
non distratto una gradita piacevolezza; ed è come ovvio, una piacevolezza che
non va oltre la sensorietà,
perché è il senso che immediatamente la trasmette all’intelletto (nil
est in intellectu quod prius non fuerit in sensu).
Ma se
dall’ipotesi della vista di un fiore (o di un paesaggio), passiamo al diverso
caso della vista di un dipinto raffigurante il fiore, o il paesaggio,
trasferiamo con ciò stesso in una diversa dimensione il piacevole recepimento
di quella raffigurazione. Oggetto
di recepimento (se quest’ultimo è facilitato dalla piacevolezza trasfusa
dall’artista nella forma del proprio messaggio), in questo caso, è infatti
l’idea
balenata per intuizione (Croce) nell’intelletto dell’artista alla vista
dell’oggetto poi raffigurato (ossia del fiore o del paesaggio nella loro realtà
appartenente al mondo esterno). La
quale idea può essere quella della bellezza qual è espressa dalla natura, così
come potrebbe essere quella della raffigurazione di un quid
che sia espressione del Disegno
Intelligente, ovvero dell’Eterno, oppure dell’effimero.
Tutto dipende, ovviamente, da quanto la capacità artistica dell’autore
del dipinto è in grado di trasmettere.
Anche a
questo punto non è, però, il caso di andare oltre le enunciazioni teoriche,
parendomi sufficiente, quanto ho detto, a far intendere la sostanziale
differenza tra la piacevolezza
sensoriale, che appunto si prova
(si può provare) nel
contemplare un oggetto del mondo esterno, ossia un oggetto esistente in natura,
e la piacevolezza intellettuale
che si prova nel recepire l’idea
trasfusa dall’artista nella propria opera (trasfusa in forma piacevole; ma di
ciò non è il caso di dire di più, perché si entrerebbe nel campo
dell’accertamento dei requisiti di artisticità della creazione, il quale esula dal tema prefissato).
Un ultimo esempio, però, mi sia almeno concesso: quello attinente alla
differenza tra la sensazione che si prova contemplando (e già questo mi riporta
al tema) una roccia modellata dagli eventi naturali, e l’impegno intellettuale
che si verifica contemplando lo sfondo del dipinto La
Vergine delle rocce, nientemeno che
di Leonardo.
L’immediata
conclusione, sul punto, è che la roccia in sé, “al naturale”, non è e non
può essere considerata un’opera d’arte.
*
* *
Oggi,
tuttavia, non è ancora del tutto tramontata (ma io spero lo sia a breve) la
dottrina (facente capo, in qualche modo, alla teoria estetica che va sotto
l’altisonante, ma forse inappropriato, nome di Ermeneutica) imperniata
sull’enunciato che l’imitatio
naturae può bellamente essere sostituita dalla diretta proposta della stessa natura.
Forse, questo, è il massimo dell’eresia che può essere enunciata in
campo estetico. Ma allora, forse,
non appariva così, se Costantino Nivola ha a suo tempo dimostrato di non
sottrarsi al fascino di quella non controllata novità, allorché per improntare
la Piazza Sebastiano Satta all’idea di una rude natura (quella stessa che
aveva affascinato il Poeta), propose non già una propria creazione artistica
realizzata mediante elaborazione di quell’idea, bensì la collocazione di un
autentico frammento di natura, ossia delle rocce di cui s’è detto.
Così è stato; e, dopo tutto, non può neppure dirsi che l’effetto di
decorazione non possa a taluno apparire piacevole. Ma
si è pur sempre nel campo della decorazione
(che, come qualmente, ha una
propria specifica dignità, pur se soltanto nel discutibile campo della
fuorviante multiculturalità), non già dell’arte.
Un’attenuante,
forse, potrebbe essere concessa ai committenti dell’opera, se furono essi a
richiedere a Nivola quella prestazione specifica; attenuante motivabile con
riferimento al fatto storico che Paolo Portoghesi non aveva ancora pubblicato
quel suo magnifico saggio intitolato Natura e Architettura, del
1999, nel quale sono elargiti magnifici esempi del come i grandi architetti
hanno finora saputo utilizzare le forme naturali (e, specificamente, quelle
caratterizzanti i grandi ammassi lapidei, ovvero le pur spettacolari stalagmiti,
non divelti però dal luogo di origine) per alimentare l’ispirazione tendente
a riprodurle in forma di pregevole creazione artistica.
Il discorso di Portoghesi è, come rivelato dal titolo dell’opera,
palesemente pertinente all’architettura; ma i concetti in esso espressi con
cristallina lucidità ben possono, anche con un minimo di buona volontà, essere
traslati al campo della scultura, specificamente di quella funzionale
all’ornamento delle opere di architettura e di urbanistica.
*
* *
Il fatto,
poi, che ancor oggi non può considerarsi del tutto archiviata la dottrina che,
credendo di poter ricavare fondamento logico dalla teoria estetica denominata Ermeneutica,
impernia i propri assunti sull’enunciato che l’imitatio
naturae possa essere impunemente
sostituita dalla diretta esposizione di un frammento di materia “al
naturale”,
non
induce di certo ad attardarsi nella confutazione del suo presunto fondamento.
A ciò, infatti, ha già provveduto la storica esasperazione di essa,
quella ad esempio posta in essere da Piero Manzoni (autore di un contenitore, un
barattolo per l’esattezza, con un’etichetta recante la scritta “m.
di autore”. Un’esasperazione che
supera, in quella direzione, anche i noti pannelli di Alberto Burri raffiguranti
(ma è solo la didascalia dei titoli a farcelo intendere) un degrado del quale
va facendo giustizia una risorgente dignitas
hominis capace di schiacciare certe importate ideologie.
Tornando al caso di Nivola, resta solo da ribadire che un manufatto urbano, nel caso concreto una piazza, può anche essere decorato da un frammento di materia “al naturale”, esemplificativamente un elemento integrante il paesaggio extraurbano (sempre che lo consenta, previa valutazione, il Ministero dell’Ambiente), divelto dal luogo di origine. Ma nessuno potrà con fondamento logico asserire che quel pezzo di natura, che è semplicemente tale, per tutti, finché rimane nel luogo di origine, possa essere da taluno considerato “opera d’arte” solo perché violentemente divelto e, quindi, impiantato in una ambientazione urbana. Sarebbe, invero, come ritenere che quell’ontologica trasformazione sia opera di un’inanimata ruspa
Mario CORDA, nominato uditore giudiziario con D.M. 28 settembre 1955, ha svolto. funzioni di giudice del Tribunale di Nuoro, pretore di Bono e di Macomer.