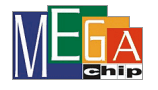Un nutrito coacervo di concomitanti circostanze giustifica il
convincimento, per la verità non piacevole, che i nuoresi non abbiano saputo
apprezzare adeguatamente il romanzo autobiografico scritto dalla loro (nostra)
concittadina Mariangela Maccioni, pubblicato postumo nel 1995 per i tipi
dell’editrice NEMAPRESS di Alghero col titolo Il mio romanzo.
Il libro in questione è, già di per sé, opera di pregio; sicché lo
scarso apprezzamento (mi auguro sia soltanto supposto) potrebbe avere avuto
origine o dal fatto che il racconto è rimasto incompiuto (per la morte
dell’Autrice, avvenuta prematuramente nel 1958), ovvero dal fatto che, nella
ricostruzione delle vicende selezionate ai fini della narrazione autobiografica,
la città di Nuoro, patria della stessa Autrice, sia rimasta decisamente
nell’ombra, non essendo assurta nemmeno al ridotto livello del deuteragonismo.
Sia rimasta, cioè, in posizione appartata, tanto che neppure sembra fare
da cornice alle su accennate vicende, quasi che queste ultime non appaiano
ricollegabili a una specifica etnia, come se avessero avuto svolgimento in un
luogo che neppure varrebbe la pena di denominare.
Il che farebbe addirittura perdere interesse all’immedesimazione nel
racconto, forse perché ai miei concittadini nuoresi
- i quali oltretutto (a sentire i librai) non avrebbero mai dimostrato di
essere accaniti lettori - ben poco
sembrerebbe interessare la narrativa o la saggistica che non abbiano ad oggetto
la cosiddetta nuoresità. Ricordo
che una volta, conversando col l’amico scrittore Gianni Pititu, osservai
(anche se quella volta solo per incidens)
che un mio libro (nel quale m’ero cimentato elaborando un’originale
tesi di filosofia estetica) non aveva avuto a Nuoro neppure un’ombra di
successo, Il giudizio del Pititu fu
a dir poco tranchant: “ai nuoresi interessano unicamente i libri che
parlano di Nuoro. Gli altri non li
leggono proprio”. Forse il
giudizio fu eccessivamente drastico, o forse soltanto provocatorio.
Ma resta il fatto che le vendite di libri (sempre a sentire i librai),
rapportate al numero degli abitanti della città, sembrano proprio dimostrare
una scarsa attitudine alla lettura della carta stampata.
La quale è peraltro, incontestabilmente, un quid assolutamente
diverso dalla fugace leggibilità della schermata on line.
Certo è, comunque, che se le ragioni dello scarso apprezzamento
dell’opera della Maccioni sono quelle ch’io ho ipotizzato, vale certamente
la pena di accennare, qui, alla loro palese inconsistenza.
*
* *
Che un romanzo possa rimanere incompiuto, per la prematura morte
dell’autore, è circostanza che non vale, di per sé, a escludere la positiva
valutazione di quanto è stato scritto. Il
capolavoro sattiano, Il giorno del giudizio, ne è la prova tangibile.
Coloro
che conoscono le vicissitudini della vita di Mariangela Maccioni
- condotta nella maturità anagrafica all’insegna del dichiarato
antifascismo, in un periodo storico nel quale anche il semplice sospetto di
antifascismo conduceva dritto dritto al carcere o al confino di polizia -
potrebbero addurre (a giustificazione del loro disinteresse) il fatto che
l’interruzione del racconto, al punto dell’avvenuto compimento dei fatti
accaduti alla famiglia dell’Autrice nell’epoca immediatamente successiva
alla prima guerra mondiale, abbia precluso la possibilità dell’esplicazione
di un messaggio letterario ricollegabile appunto ai valori dell’antifascismo.
Un messaggio letterario, cioè, parallelo a quello già espresso in
versione saggistica dalla stessa Maccioni col libro Memorie politiche
(edito nel 1988 a cura del marito della Maccioni, Raffaello Marchi, per i tipi
dell’editrice Della Torre), reso ancora più esplicito negli scritti
introduttivi dello stesso Marchi, opportunamente completati da Luisa Selis
Delogu.
Vale,
però, osservare in proposito che la valutazione dell’opera letteraria ha
scarso significato se condotta sui binari della semplice supposizione di quanto
lo scrittore avrebbe potuto dare se fosse sopravvissuto.
Il racconto compendiato ne Il mio romanzo va, in verità,
considerato per quello che è, non per quello che avrebbe ipoteticamente potuto
essere; e ciò tenendo conto soprattutto del fatto che già, in esso, è
condensato quanto è sufficiente per qualificarlo come opera di narrativa la
quale trascende la semplice esposizione dei fatti, pur dimensionati secondo la
loro rilevanza ai fini del percorso autobiografico.
In realtà, da esso traspare un messaggio di chiarissimo significato,
rapportabile alla dimensione di una vita umana votata all’interiorità, alla
riflessione circa il valore etico degli affetti familiari, alla constatazione
dell’ineluttabilità di un destino il quale fattualmente finisce per
distruggere l’idillio familiare che pareva potesse durare indefinitamente.
Messaggio, questo, che la scorrevolezza di un elegante linguaggio
improntato opportunamente alla piacevolezza intellettuale rende percepibile a
chi abbia teoretica facoltà di intendere e che, in ogni caso, è reso ben
esplicito dalle pregevoli prefazione e postfazione, rispettivamente
di Ignazio Delogu e Luisa Selis Delogu.

Casa
Natale di Mariangela Maccioni, in Vicolo Barisone,
abitata dalla scrittrice fino agli anni Trenta del secolo
scorso, recentemente restaurata
La circostanza, poi, che nell’opera mancherebbe l’esaltazione della nuoresità,
tanto cara ai nostri concittadini, è cosa letterariamente irrilevante, prima
ancora che concretamente inesatta.
In verità, la dimensione microcosmica della Nuoro di allora, pur in
fattuale declino nell’epoca in cui la Maccioni si accinse alla narrazione, ma
tuttavia ancora percepibile a sprazzi, aleggia in una diffusa penombra
ravvisabile in quella inesplicabile coscienza dell’appartenere, volenti o
nolenti, a una misteriosa realtà di ardua e in ogni caso incerta definizione.
Tanto ardua, quest’ultima, che non viene neppure tentata, nemmeno col
facilitante ausilio dell’immagine letteraria.
E’, comunque, una dimensione pervasa di tristezza, di angoscia, di
incertezze, di pianto. Un mondo
infestato dal male e, perciò, dalla malinconia e dal dolore.
La promessa di vita naufraga nel mare della delusione e del fatalismo.
Domina su tutto un presentimento di morte; e la morte arriva inesorabile,
presagita o ricercata. Solo il
rifugio nella fede religiosa, talvolta simboleggiata da confortanti immagini
floreali, potrebbe allontanare l’assillo di una dolorosa fine della vita
terrena. Ma la fede non è un dono
elargito a tutti. Non lo è in
particolare per Giacinto, il quale comincia a perderla dopo la lettura del libro
scritto dal professore Paoli, il suo insegnante di scienze (un Odifreddi ante
litteram), pretenziosamente intitolato Fisiocosmos; uno zibaldone che
si cimenta tra scienza e filosofia e che si prefigge di
negare scientificamene la vita ultraterrena.
E sarà proprio la perdita della fede, cominciata appunto con quella
lettura, a indurre Giacinto a ricercare la morte.
*
* *
Oggi
l’opera della Maccioni, che peraltro non ebbe a suo tempo una cospicua
tiratura, è del tutto introvabile nelle librerie (tanto da essere sfuggita, nel
1998, alla pur attenta Paola Pittalis, eminente studiosa della letteratura
sarda); ed è un vero peccato, poiché si tratta di un’opera letteraria che dà
lustro all’intera Sardegna e che a pieno titolo meriterebbe il culturale traghettamento
(l’espressione è di Nicola Valle) oltre il Tirreno.
La speranza, comunque, è che l’editrice Il Maestrale,
benemerita in questo campo, provveda quanto prima alla ristampa.
Testo di: MARIO CORDA