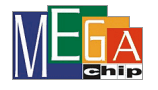Sembrerà assurdo ma è così. Ecco perché dietro la falsa apparenza dei reportage di stampo etnografico che hanno invaso le sale nella prima metà degli anni ‘60, ipocritamente spacciati come attenti studi di usi e costumi a rischio di estinzione (uno dei più celebri titolava “Addio ultimo uomo”), si nascondeva in realtà la deplorevole intenzione di mostrare a un pubblico cattolicamente represso e in vena di prurigine corpi nudi e violenze di ogni tipo su uomini e animali.
Se da una parte si metteva in luce la natura incorrotta di un mondo dove i figli andavano a cacciare con i padri e il sostentamento del popolo era affidato alle risorse del territorio, dall’altra non si mancava di sottolineare la barbarie di certe usanze (spellature dei defunti, amputazioni delle mani dei traditori, cannibalismi), il tutto all’insegna di un moralismo assai fastidioso e dal discutibile punto di vista dell’occidentale “civilizzato” che si augura che il “buon selvaggio” possa presto accedere al suo stesso stato di benessere.
Erano gli anni di “Svezia inferno e paradiso”, un titolo emblematico non tanto di un modo di vedere i Paesi scandinavi quanto di raffigurare l’italiano medio (lo stesso Alberto Sordi – e chi è stato più “italiano medio” di lui? – in “Il diavolo” di Gian Luigi Polidoro [1963] recitava la parte di un uomo in viaggio d’affari che scopriva in Svezia un mondo di donne allegre e disinibite, prive di alcun senso del peccato).
E chi non andava al nord, preferiva abbandonare il freddo continentale per il caldo dei Paesi tropicali. Ecco spiegata l’attrattiva sul pubblico di film come “Mondo cane” (1962) e la nascita del filone “esotico” all’interno del quale furoreggiavano bellezze come quelle di Zeudi Araya (“La ragazza dalla pelle di luna”, per citare uno dei titoli più emblematici) e Laura Gemser (l’indimenticata “Emanuelle nera”).
Cosa c’entra tutto questo con “Barbagia – La società del malessere” di Carlo Lizzani?
C’entra, c’entra. Il film, girato nel 1969, gode fama di “analisi delle cause del fenomeno del banditismo in Sardegna” (a partire dal saggio omonimo di Giuseppe Fiori).
In realtà, visto oggi, fa abbastanza sorridere per l’ingenuità con cui si descrive il mondo dei latitanti e persino arrabbiare per la leggerezza con cui si finge curiosità nell’accostarvisi, come a voler veramente capire le radici di un problema, quando è palese l’intenzione di ribadire al riguardo una serie di tesi precostituite.
Particolarmente sgradevole la voce fuori campo del narratore (presumibilmente quella di Lizzani stesso che nel film interpreta un reporter – lo si vede brevemente all’inizio) che, proprio come accadeva nei “mondo-movies” di cui sopra, parla di un popolo, quello barbaricino, quasi primitivo, come isolato dal resto della civiltà, e dedito a perseguire un tipo di vita legato a codici antiquati.
Va detto che nemmeno il sardo è mai riuscito più di tanto a guardare con oggettività al fenomeno del banditismo, da sempre oscillante tra rigetto e mitizzazione, e sono pochi i film davvero validi sull’argomento, in primis “Banditi a Orgosolo” di De Seta e “Pelle di bandito” di Livi.
Risibile la caratterizzazione del latitante che si fa pagare le visite dei turisti in mezzo alle montagne in “I protagonisti” di Fondato, dove la prova sopra le righe di Lou Castel fa il paio con quella esagitata e frenetica di un giovanissimo Mario Girotti (il futuro Terence Hill) in “Barbagia”. Forse Lizzani riteneva logico spiegare che un omicida che nutre propositi di evasione fa flessioni, salti e capriole nel cortile della prigione. Personalmente, mi sembra ridicolo. Dubito che Graziano Mesina si sia tenuto in allenamento con i piegamenti o che una tale messa in scena possa giovare a una migliore caratterizzazione del personaggio.
Decisamente meglio, ma dovranno passare vent’anni, ha fatto Cabiddu con “Disamistade” nella rappresentazione del conflitto tra l’anelito alla vendetta e la volontà di infrangere un’inutile catena di delitti. La Barbagia sarà pure un mondo a sé ma gli uomini che la popolano non sono blocchi di granito uno identico all’altro.
Lizzani questo non l’ha capito.
Alessandro Stellino