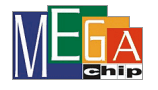"Pappa pessa de babbo doo". Per la Sardegna antica il sospetto dell' antropofagia, o cannibalismo rituale, nasce da un asso di Timeo, ripreso da pochi altri storici, che afferma che i sardi uccidevano i loro vecchi, che morivano con uno strano sogghigno, che lo storico chiama Sardanios ghelos (la stessa espressione è spiegata da altri storici greci con gli effetti di un' erba velenosa non identificata) e da qualche frase superstite nel parlato attuale, soprattutto dal modo di dire dei Cagliaritani " Pappa pessa de babbu duo" mangia carne di tuo padre. L'uccisione dei vecchi è ricordata da molte storie che si narrano in tanti paesi, dove addirittura viene indicato ancora il luogo dove i vecchi venivano fatti precipitare (su bocchitorju o su strampu) e si conserva il ricordo delle acabbadoras, donne incaricate di dare il colpo di grazia. Che ancora i nuragici praticassero il cannibalismo rituale a me sembra davvero poco plausibile. I greci, e non solo loro, avevano la simpatica abitudine di attribuire a tutti i popoli che non conoscevano le abitudini che a loro apparivano più disgustose. Credo, però, che anche i sardi abbiano nel loro passato questo rito, come tutti i popoli della terra, greci compresi, e che lo ricordino in molti atti, a cominciare dal cerimoniale seguito nell'uccisione del maiale domestico.
L'uccisione de su mannale è tra le cerimonie più belle e affascinanti che mi rivengono spesso alla memoria. In tutta l'Europa avviene con cerimoniali elaborati che vengono seguiti scrupolosamente, segno evidente della pregnanza di significato che viene ad essa attribuita. Che sia il ricordo di un rito antichissimo appare evidente anche a un esame superficiale: il cerimoniale non si può spiegare se si crede che si sta semplicemente uccidendo un maiale. Per uccidere un maiale non ci vuole e non c'è mai voluta molta gente. Bastava e basta un macellaio esperto per uccidere un animale talmente grasso da non reggersi in piedi, stordendo lo col dorso della scure (s' occiu 'e sa istraie - l' occhio della scure) e poi accoltellandolo, o semplicemente accoltellandolo di sorpresa, come fanno ancora i macellai quando non hanno la pistola, e come fanno ancora i pastori. Non mi risulta, d'altronde, che si uccidano altri animali allo stesso modo. Lo stesso toro, molto più grosso e pericoloso, veniva abbattuto col dorso della scure della fronte e poi scannato.
Il maiale di casa non era, però, un animale qualunque, era un animale di casa, prigioniero, ma cresciuto in famiglia, conosciuto da tutti, donne e bambini, che lo controllavano tutti i giorni, per dargli da mangiare e per pulire il porcile, e tutti l'avevano visto crescere, giorno dopo giorno, e ne conoscevano il carattere, dal giorno in cui, alla prima maturità, appena castrato, era arrivato a casa.
Un rito collettivo.
Uccidere su mannale non era tanto diverso dall'uccidere un prigioniero umano, e un uomo non si uccide così, un qualsiasi mattino, da parte del primo che ci pensa e va e lo ammazza, ma ci vuole gente, e molta, perché uno solo non ha il coraggio di prendere la decisione, è una responsabilità che deve essere collettiva e l'esecuzione deve avvenire in una data e con una modalità stabilite. Su mannale si uccideva come si uccidevano gli uomini e come se si trattasse di un uomo.
Al mio paese il giorno di Sant'Andrea. I bambini portavano le frasche dalla campagna giorni prima e aspettavano con ansia e timore. Anche il maiale aspettava perché dal giorno prima era digiuno. All'alba arrivavano i parenti e gli amici della famiglia, ognuno con il suo coltello. Qualcuno portava la scala a pioli. L'uomo che doveva ucciderlo portava il coltello per scannare e quelli per radere, e erano attrezzi che usava solo per quello scopo e che riponeva con cura per tutto il resto dell'anno. L'uomo era sempre lo stesso per tutte le famiglie del parentado e donne e bambini avevano paura di lui anche quando si trattava di un parente al quale erano affezionati. Entrava nel recinto e ne faceva uscire il maiale, che resisteva, nascondendosi in ogni angolo, perché si accorgeva, dalla presenza di gente sconosciuta e dal digiuno prolungato, della novità. Appena usciva dal recinto, veniva acchiappato per le zampe posteriori e fatto cadere, ma, a volte, occorreva rincorrerlo per il cortile, gli venivano legate le zampe accoppiate, le posteriori con le anteriori, gli si legava il grugno con una cordicella o con del fil di ferro, e l'uomo gli premeva il muso verso il basso e lo pungeva, cercando il punto giusto nella gola distesa, facendo in modo da non toccargli il cuore, perché non morisse in fretta, ma si agitasse a lungo, così da fare tutto il sangue.
Il primo getto di sangue veniva subito raccolto e rimescolato in un recipiente, perché non si coagulasse, per fame un sanguinaccio dolce da cuocere con zucchero e uva passa dentro un budello, o per darlo da bere agli uomini zuccherato. L'uomo premeva nella ferita uno straccio, o un vero e proprio tappo, di legno o di sughero, perché non si perdesse il sangue restante, e accendeva le frasche, mentre il maiale ancora si lamentava. Qualcuno gli strappava le setole, sas thuddas, per fame pennelli o per darle al ciabattino che le avrebbe usate come puntali per lo spago.
Spostando le frasche accese con una lunga paletta o con un bastone, si abbrustoliva il maiale.
La comunione del fegato.
Durante questa operazione ai bambini venivano date le unghiette, la coda e le punte delle orecchie. Poi il maiale veniva lavato. L'uccisore radeva la cotenna con un coltello lungo affilatissimo, mentre altri la raschiavano con coltelli o con ciottoli. Uno dei miei zii sfotteva il maiale mentre gli puliva le orecchie "la di ias vijonavas cras sas uriccias gasi nettas!" (Te le sognavi le orecchie così pulite!). Dopodiché lo si legava per dei fori praticati nelle articolazioni delle zampe posteriori alla scala a pioli, veniva issato e aperto, a partire dalla zona genitale. Quando gli si staccava la verga, tutti si facevano beffa del maiale con commenti salaci. L'uomo dava la vescica ai bambini perché la gonfiassero, soffiandoci dentro, poi estraeva le budella, poggiando il tutto in su iaiu, un recipiente di legno rettangolare, divideva gli intestini e li dava ai bambini perché li pulissero, toglieva la cistifellea, controllava il fegato e ne distribuiva a tutti un pezzo.
Lo mangiavano tutti, grandi e bambini, chi con sale, chi schietto. I bambini che lo rifiutavano venivano scherniti, così tutti facevano almeno finta di assaggiarlo. Alcuni assaggiavano crudo anche il cervello. Quando era squartato, ma sarebbe meglio dire dimezzato, gli uomini lo pesavano, con su cantàre, misurando lo spessore del lardo e il colore della carne, commentando e apprezzando la capacità dell'allevatore e la bontà della razza, trasportavano le metà (Era una prova di forza per gli uomini più prestanti) in una stanza e le poggiavano sopra tavoli sulle quali l'uomo preparava la carne, circondato dalle donne che concordavano con lui le parti da destinare alle varie lavorazioni. Tagliava prima i pezzi per il sugo, animelle e pezzi grassi, poi la carne per la salsiccia, i guanciali, i prosciutti, le pancette, e rimaneva la colonna da dividere in ispinos da distribuire a parenti e amici.
Gli elementi del rito.
Non credo che il cerimoniale fosse identico in tutti i paesi, qualche particolare variava addirittura da un vicinato a un altro nello stesso paese, ma che si trattasse di un rito, di qualcosa che rompeva il quotidiano, di una solennità era evidente per tutti e dappertutto e gli aspetti sostanziali erano immutabili. Alcuni di questi, che allora ci sembravano scontati, oggi appaiono non solo inutili ma senza senso per le nostre abitudini attuali:
a) Ci dovevano essere parenti e amici, grandi e piccoli. I bambini venivano chiaramente invogliati e preparati ad assistere e a partecipare all'uccisione. Era grave e anomalo che un bambino, per quanto recalcitrante e impaurito, venisse dispensato. Lo si incoraggiava in tutti i modi, magari deridendolo o sgridandolo, ma doveva almeno assistere.
b) Era necessario lottare col maiale, legarlo, per poterlo accoltellare quando era ancora cosciente, e doveva morire lentamente. Le ultime occasioni nelle quali ho assistito personalmente all'uccisione del maiale, mio zio, che era l'uccisore ufficiale per il parentado, aveva adottato il metodo più rapido di stordirlo con il dorso della scure prima di accoltellarlo. Molti lo criticavano per questo e lui stesso le prime volte era imbarazzato. La maggioranza dei miei compaesani rifiutava il metodo e molti amici avevano protestato, quando gliene avevo parlato: non si poteva uccidere così il maiale di casa, non era un maiale qualsiasi. I due metodi erano evidentemente da sempre conosciuti ma distinti. È notevole che a Orani non si chiama tolu il dorso della scure (è s' occiu, da cui isocciada che significa colpo inferto col dorso della scure), eppure si dice intolau per dire ucciso e istolau per stordito, impazzito.
c) Gli attrezzi per uccidere il maiale erano sempre gli stessi. Ziu Peppe conservava il coltello per uccidere il maiale con estrema attenzione e cura e non lo usava per altro scopo, così come sa lametta, la lama lunga per radere, era consumata, letteralmente sventrata dall'uso. Qualcuno conservava da un anno all'altro le funicelle per legarlo. Mi pare di ricordare che il fabbro desse agli attrezzi da usare con il maiale una particolare tempera e che si usassero formule particolari per consacrarli, ma non ne sono certo.
d) A uccidere e preparare il maiale era sempre la stessa persona. Negli ultimi tempi i vecchi esperti lasciavano provare qualche ragazzo di casa o qualcuno, ragazzo o meno, che intendeva cimentarsi, ma ho i miei dubbi che questo fosse possibile nel passato. Nei miei ricordi più lontani l'unico che maneggiasse il coltello per uccidere era ziu Peppe.
e) Non si usava una qualsiasi legna da ardere, per il maiale, ma s'usciadina, un arbusto particolare del quale non so il nome in italiano.
f) Si beveva il sangue del maiale perché dava forza. Quando ero piccolo io l'usanza non era più tanto diffusa e molti miei coetanei addirittura la negano, ma io ricordo con certezza che zia Rosaria, la sorella di mio padre, zuccherava il sangue in una tazza e lo faceva bere a me e al figlio, incoraggiandoci con quella spiegazione: saremmo diventati forti.
g) Se ne mangiava il fegato crudo perché dava coraggio. Ancora oggi moltissimi lo mangiano, alcuni solo le punte più molli, altri tutte le parti. lo non sopportavo il sapore del fegato cotto ma andavo matto per quello crudo, ancora caldo e sanguinolento, e ancora oggi non resisto alla tentazione di mangiarlo.
h) Se ne distribuivano parti a parenti e amici, sos ispinos. Ricordo che la cosa non ci trovava troppo concordi. Ai bambini pareva salsiccia sprecata tutta quella buona carne da dare a cani e corvi. Ci si rispondeva che gli altri ci avrebbero restituito il favore, tanto che ho pensato fino a non molto tempo fa che l'usanza avesse lo scopo quasi di sostituire il frigorifero, distribuendo la carne in eccesso.
i) Del maiale non si sprecava niente. L'affermazione veniva fatta con convinzione, come per il pane. Era quasi empio sciupare parti del maiale, dalle interiora alle setole. Anche le ossa venivano consumate, ridotte a gelatina. Non si può non ricordare come uccidevano i prigionieri i pellirosse americani, in particolare i Tupinambà, osservati nei secoli scorsi da missionari e studiosi europei. I nemici catturati, quando non venivano uccisi subito, come avveniva ai più vecchi e alle donne che non si potevano dare come spose, venivano portati al villaggio affidati alle donne che li trascinavano legati nella piazza centrale e li bastonavano, insultandoli e gridando i nomi dei loro parenti morti nello scontro, poi li accoglievano nella loro comunità, facendoli sposare con le vedove loro sorelle, e vivevano in amicizia fino al momento fissato in cui li uccidevano e li mangiavano. I prigionieri erano orgogliosi della loro morte. Rinfacciavano ai nemici di aver anche essi mangiato molti di loro e affermavano che i loro parenti li avrebbero vendicati e avrebbero mangiato molti di loro.
Ma si pensi anche a come si svolgevano le esecuzioni legali fino a poco tempo fa anche in tutta Europa: nella piazza centrale, davanti a una folla eccitata, con un rituale meticolosamente crudele.
Si può uccidere un animale da soli, ma per uccidere un uomo occorre la gente, perché nessuno sia responsabile. È tutto il vicinato che lo ha deciso, o tutto il parentado, e tutti devono fare la loro parte, legandolo, abbrustolendolo, raschiandolo e mangiandone un pezzo, o almeno assistendo. Chi non assiste all'uccisione o non assaggia s'ispinu, non partecipa dell'uccisione, non se ne prende la sua parte. Uno solo uccide, il boia o il prete o l'anziano, ma l'uccisione è di tutti, perché chi uccide vuole che ci siano tutti, che sia esplicito il consenso di tutti.
Su mannale e il banchetto funebre.
Nelle cerimonie funebri vere e proprie, quelle che riguardano gli uomini, l'usanza del banchetto rituale è ricordata quasi dappertutto nel pasto che parenti e vicini preparano e portano alla famiglia del morto con un' abbondanza spropositata: è vero che l'uso viene giustificato col fatto che il cordoglio impedisce ai parenti stretti di badare alle necessità quotidiane, ma è una spiegazione insufficiente, perché si accumulava una quantità di cibo quasi indecente e contribuivano con piatti abbondanti anche famiglie che stentavano a preparare normalmente due pasti.
A Orani agli amici in visita ancora oggi si offre il caffè con i biscotti teneri (era un oltraggio al morto e un insulto ai parenti rifiutare fino a poco tempo fa), altrove si offre il vino, sempre accompagnandolo con l'espressione "pro s'anima" (per l'anima), quando non "a nde viver su mortu" (berci il morto). "Si beve il morto" in quasi tutti i paesi sardi. Di ritorno dalle condoglianze, i compaesani si spargono nei bar "a nde viver su mortu ".
Un vero e proprio banchetto veniva offerto a Oniferi, a quanto pare. Si racconta che il postino oranese, che allora consegnava la posta anche ad Oniferi, capitato un giorno in una casa piena di gente attorno alla tavola apparecchiata e invitato a sedersi a mangiare con loro, alzò il bicchiere per brindare "A nde iu manicare chin saiude" (Che lo possiate mangiare con salute) pensando di trovarsi a una festa per il mannale, e poi scoprì che si trattava del funerale del padrone di casa.
Il parallelo tra il cerimoniale dell'uccisione del maiale domestico e il funerale umano è così stringente da non poter essere considerato un caso. Come non accostare il trasporto del cadavere umano con la scaletta a pioli, sorta di barella, con il maiale legato alla scala e rizzato? Così come non è senza significato che il cadavere veniva sempre lavato e rasato. Mentre oggi, infatti, che si lavi il cadavere è cosa più che naturale in una società ossessionata dalle norme igieniche e ricca d'acqua e di detersivi, non altrettanto si può dire per il passato, quando si lavavano e si radevano soltanto i morti, mentre i vivi non si lavavano e non venivano lavati neanche appena nati. Eppure i morti venivano sempre lavati. Si tenga presente che anche i pellirosse Tupinambà affidavano a individui scelti anzitempo il compito di lavare e fare a pezzi i prigionieri. A Lodè dicono ancora "Chi ti iaven sas pragas de mortu!" (Che ti lavino le grinze da morto!).
Sembrerebbe quasi che in entrambi i casi, dell'animale e dell'uomo, si prepari il corpo perché sia mangiato.
Già Freud, in Totem e tabù, legava l'incubo antichissimo dei vampiri e del lupo mannaro, i morti viventi che per rimanere in vita devono sbranare i vivi e berne il sangue, al rimorso successivo all'uccisione del padre, al cannibalismo rituale. La credenza è atte stata dappertutto, praticamente, oggi e nel passato, dai racconti di Apuleio nelle Metamorfosi sulle streghe tessali alle testimonianze raccolte ancora oggi. Viene da pensare che l'umanità, usa a mangiare i morti per assorbirne lo spirito vitale, vivesse poi nell'incubo che essi tornassero a reclamare il proprio sangue e il proprio corpo per tornare in vita. L'usanza, diffusa in varie epoche e presso vari popoli, di legare i morti, di seppellirli sotto cumuli di sassi, di circondare il luogo della sepoltura con simboli che li tenessero lontani, si potrebbe spiegare con i riti antropofagi e con l'orrore e la paura conseguenti.
Sa chena ' e sas animas. Orrore e paura che spiegano la cena dei morti, sa chena , e sas animas. Tutte le famiglie preparavano la cena per i morti, perché erano convinte che i morti sarebbero tornati a cercare vino e pane, sangue e carne, e i vivi speravano che si accontentassero dei loro sostituti e si tenevano attentamente nascosti, evitando di farsi vedere, per non essere da loro rapiti. Mi madre la preparava finché era in vita mio nonno, il quale si sarebbe sentito angosciato se non fosse stato certo che sas animas avrebbero trovato il loro pasto. Ne rideva, ma ho sempre avuto l'impressione che, in fondo, continuasse a crederci, come doveva crederci quando la preparava la madre e i suoi fratelli la consumavano al rientro e ridevano delle sorelle credulone.
Il ritorno periodico dei morti nelle case dei vivi era così certo nella cultura sarda che non occorre davvero pensare all'influenza della fede cristiana nella resurrezione della carne, anche se il fondo culturale sembra comune. Tutti avevano visto morti. A tutti era capitato di sentirsi almeno chiamare da un morto. Nella famiglia di mamma ho sempre sentito raccontare che uno dei miei zii, da ragazzo, vedeva i morti. Così come si narrava di una donna che si era alzata nottetempo ai rintocchi della campana della chiesa, si era recata in chiesa, in cumbentu, l'aveva trovata affollata di gente che non conosceva e, solo quando era tornata a casa e aveva sentito nuovamente la campana, aveva capito di essere andata alla messa dei morti4, a mezzanotte, la notte di san Giovanni. Ma storie così se ne potevano raccogliere centinaia.
La processione dei defunti, con il loro carro, è ancora così spesso affermata, quando non c'è addirittura qualcuno che afferma di avervi assistito, che io sono personalmente convinto che è al centro dei riti sardi, e non solo sardi, del carnevale. Nel carnevale di sono sempre un carro, una processione, le grandi bevute, le grandi abbuffate e una grande confusione sessuale. Nel carnevale sardo c'è anche Carrasecare mortu, Zorgi o Zoigi morto, ricoperto di salsicce che vengono mangiate, che orina vino che viene bevuto, e l'irrompere nel mondo di una vita diversa, contrapposta, quello che è chiamato il mondo rovesciato.
Da noi figure e usanze del carnevale sono simili a quelle dei defunti.
Tutti gli studiosi sardi partono, nell'analisi delle maschere barbaricine, mamuthones, thurpos, merduies, da un famoso saggio di Raffaello Marchi sul Boe muliache e l'essere fantastico di Nule e concordano più o meno con lui sulla loro derivazione dalla paura dei pastori di imbestialirsi col lungo contatto con le bestie. Questa paura verrebbe quasi esorcizzata ridicolizzandola nella pantomima carnevalesca. Ma a me non pare proprio che le pantomime di cui si parla abbiano alcunché di allegro o di ridicolo. Certamente non ne rideva nessuno fino a non molto tempo fa. I mamuthones di Mamoiada hanno il diritto di mangiare e bere in qualsiasi casa entrino e guai a chi si fa prendere allaccio dai loro terribili guardiani (anche se oggi le ragazze ridono quando l'issoccadare le imprigiona!) Ma lo stesso diritto è riconosciuto ai merduies di Ottana, ai thurpos di Orotelli, a su tintinnatu5 della Baronia, e a sas animeddas, di Orani e di molti altri paesi! È caratteristica comune di tutte queste figure il diritto di trovare cibo e vino e la capacità e la voglia di rapire o uccidere chi li vede. È la folla dei morti. Potrebbe essere tutta umana, anche quando ha maschere animalesche, ma è più probabilmente mista di uomini e di animali, perché, comunque, per gli antichi erano anime di morti, da loro uccisi e mangiati. Non è necessario pensare che il rito dell'uccisione e del pasto riguardasse in origine gli uomini, poi sostituiti dagli animali. Si può anzi credere che l'uomo sia arrivato a uccidere e mangiare prima gli animali che i suoi stessi simili, quando fu in grado di costruire le armi per abbatterli e per squartarli, quando, cioè, divenne carnivoro.
Le preghiere in cui i popoli cacciatori chiedono perdono alle loro vittime, e sono preghiere anche le pitture rupestri del paleolitico che rappresentano scene di caccia, nascono dalla convinzione che l'orso, il lupo, il toro, il maiale sono comunque anime e che il loro spirito sopravviverà e deve essere placato. Nel rito dei mamuthones, dei thurpos sembra di vedere una distinzione di ruoli e di status che forse è proprio quella tra uomini e animali. Gli uomini continuano a essere pastori e mandriani, anche dopo morti, e guidano ancora le loro mandrie e le loro greggi morte, i merdules addirittura castrano e ferrano i loro animali, tutti continuano le loro occupazioni, mentre vengono a chiedere ai vivi quello che è loro dovuto: il sangue e la carne che i vivi hanno mangiato. Sas animeddas, i bambini mascherati che recano una zucca scavata e intagliata a forma di viso umano, o meglio di teschio, con le cavità vuote degli occhi e della bocca illuminate dall' interno da una candela accesa, sono dichiaratamente, anche nel loro nome, i morti che chiedono il loro cibo. Molti li temevano, quando sciamavano per il paese male illuminato con il loro teschio in mano, anche se negli ultimi tempi i più li accoglievano con tenerezza, con su mortumortu, fagotto di frutta secca, già preparato per loro.
Su pane 'e sas animas e s'ispino. Legato alla stessa cultura è su pane de sas animas, che si prepara quando muore qualcuno di casa e si distribuisce a parenti, amici, vicini, come si fa con sos ispinos del maiale. Oggi lo distribuiscono i ragazzi. Al ragazzo che lo reca chi lo riceve, come chi riceve s'ispinu, deve dare s'ustrina, in denaro o in natura, poco o molto, secondo le disponibilità, ma obbligatoriamente, come una ricevuta, come una prova che ha accettato e che riconosce il suo debito. Prima lo si distribuiva nottetempo, di nascosto. Donne con il viso nascosto dallo scialle lo lasciavano davanti alla porta degli amici, dei parenti e, fatto notevole, dei nemici, de sos a dirma, bussavano e scappavano.
Il pane dei morti, su pane de sas animas, è così evidentemente la rappresentazione del corpo del defunt06, che mia madre lo accetta e lo ha sempre accettato con una forte ripulsione e non lo rifiuta solo per il rispetto fermissimo per la parentela del morto e per le usanze che considera sacre. Ricordo che io ho sempre riso di questa sua reazione che non capivo e che le obiettavo che il pane lo avevano fatto i vivi. La stessa ripulsione la manifestava per su pane' e vintichimbe, il pane rituale che si distribuiva a Gonare, il 25 marzo, cosa che mi aveva meravigliato, finché non mi aveva detto: "Est semper pane de mortos" (È sempre pane di morti) perché si incaricava della sua confezione e distribuzione sempre qualcuno che aveva avuto un morto in famiglia. Evidentemente, per lei in forma non più conscia, ma per gli antichi in modo conscio, il pane era ed è il corpo del morto. Come per un buon cristiano il pane dell' agape era ed è il corpo di Cristo e il vino era ed è il suo sangue. Gli antropologi conoscono popoli che, a tutt' oggi, mangiano i propri morti e impastano con i pezzi meno appetibili dei loro corpi un pane speciale che poi distribuiscono nel villaggio.
Il pane e s'ispinu del maiale sono davvero la stessa cosa.
La famosa espressione cagliaritana pappa pessa de babbu duo (mangia carne di tuo padre), alla base di tante polemiche sull' antropofagia rituale dei sardi antichi, si inserisce in questo quadro, che è lo stesso, mi pare, nel quale rientra la comunione cristiana, nell' ostia, il pane, che è la carne di Cristo, nel vino che è il suo sangue, (nelle comunità agricole, ovviamente, il cibo più diffuso, il pane, è identificato con quello che diventerà, mangiandolo, la carne, così come il vino è identificato col sangue perché, bevendolo, diventerà sangue r, e che tutti devono mangiare e bere per divenire fratelli, perché, mangiando la stessa carne e bevendo lo stesso vino, si è tutti composti della stessa sostanza. Quando pensiamo che diveniamo più amici perché beviamo e mangiamo assieme a qualcuno, siamo ancora convinti, inconsapevolmente, che siamo ciò che mangiamo e beviamo, convinzione antichissima, ancora diffusa. La violenta reazione di sdegno di molti sardi al rifiuto da parte dell' ospite di bere un bicchiere di vino come per il vino versato con la mano rovesciata o con la mano sinistra ha origine evidentemente in una parte del rituale funerario che oggi non capiamo e trova il suo riscontro nelle motivazioni che i greci avanzavano per spiegare la sacralità dell'ospite: ha mangiato alla mia mensa, è composto delle mie stesse sostanze. La stessa concezione spiega, forse, il divieto della commensalità tra le caste indiane e tra i bianchi e i neri nel Sud degli Stati Uniti, come anche tra padroni e servi nella nostra stessa società, fino a non molto tempo fa.
Si ricorda, o si ricordava, nel cerimoniale dell'uccisione del maiale domestico l'uccisione dei prigionieri, quella degli anziani genitori e il cannibalismo rituale dei nuragici, o già i nuragici ripetevano in quello stesso cerimoniale un atto del quale il significato si era smarrito anche per loro? lo propendo per quest'ultima ipotesi. Se i sardi avessero praticato il cannibalismo al tempo dei romani, quella linguaccia di Cicerone, che disprezzava i sardi mastrucati perché avevano avuto l'impudenza di querelare il suo cliente che li aveva derubati, non avrebbe perso l'occasione per ricordarlo. I sardi avevano raggiunto certamente uno stadio culturale molto più simile a quello dell' area sudamericana e poi degli etruschi che a quello delle tribù nigeriane attuali. Il cannibalismo rituale era stato abbandonato già da tempo nelle grandi correnti religiose del Mediterraneo ed erano rimasti solo i sacrifici degli animali. La lingua e i costumi conservavano, e in parte ancora conservano, gli esiti di riti e credenze che si erano già cancellati anche dalla memoria o erano stati rimossi per un sopraggiunto orrore per il rito in conseguenza di nuove credenze. Si dice ancora oggi per minacciare qualcuno "Gli mangio il fegato" così come si dice "Melo mangerei" per qualcuno che ci piace particolarmente, o "Melo berrei come un bicchiere d'acqua". Della prima espressione si sono avute anche traduzioni nella realtà anche in tempi non lontani, con episodi di cannibalismo legati all' odio e alla ferocia criminale, ma, generalmente, il sardo preferisce il vino, il pane e la carne e i frutti del latte dei suoi animali.
NOTE
1. Rimanendo inteso che io non scopro niente e che tutti i fenomeni che qui accenno sono già stati in passato variamente presentati e interpretati, io mi limito a prospettare una delle tante spiegazioni possibili, non la più ricorrente. Non è questa la sede per una bibliografia esauriente sull'argomento, né io sarei in grado di redigerla, vista la natura molto dilettantesca dei miei studi. In ogni caso, utili notizie chi vuole può trovare nell'Enciclopedia dell'Einaudi, nel II Volume, alla voce Cannibalismo, se non vuole ricorrere a testi più specifici, come gli studi di Ernesto De Martino e altri.
2. La mia fonte per questa notizia è stato un ingegnere milanese in vacanza in Sardegna nel mio stesso campeggio. A motivo del suo lavoro si è trovato presente a una cerimonia funebre in Nigeria e mi ha assicurato di aver dovuto mangiare lui stesso la manina di una scimmia.
3. Ernesto De Martino in Sud e Magia riferisce di molti luoghi dove l'espressione è usata. Bere il morto è modo di dire comune dove sopravvive il banchetto funebre.
4. La messa dei morti era nota già a Ernesto De Martino che in Sud e Magia ne riferisce numerosi esempi, per altro simili a quello narrato a Orani, da lui studiati in Lucania.
5. Su Tintinnatu appare nella voce Siniscola del Dizionario del Regno di Sardegna del Casalis, nelle voci sarde a cura dell' Angius. Nella stessa voce appare su voe muliache, che probabilmente ha ispirato a Raffaello Marchi la sua ricostruzione delle maschere barbaricine.
6. Nella voce del Dizionario del Casalis già citata, l'Angius riferisce dell'usanza dei siniscolesi di recarsi a Lodè presso parenti e amici a chiedere su Petticoccone (corrispondente de su mortu mortu de sas animeddas di Orani) , che vuoI dire evidentemente chiedere pane, e tornare con un regalo dei 10deini che questi chiamano Fetta Modde, carne tenera. Pane e carne sono identificati nel linguaggio, in espressioni che si riferiscono, peraltro, a insiemi di cibi che non comprendono né carne né pane.
17. Si può anche pensare che l'identificazione, del pane con la carne e del vino con il sangue, nasca dall' abbandono del cannibalismo e dalla inumazione del cadavere dopo l'introduzione delle pratiche agricole, quando forse il debito che si aveva con gli animali si trasferì alla Terra, alla quale bisognava restituire chi da Lei era stato nutrito, le sue stesse sostanze, cioè. Mentre per i cacciatori sono la carne e il sangue dell'animale mangiato che diventano carne e sangue dei viventi, per gli agricoltori carne e sangue derivano dal grano e dalla vite. Per i cacciatori il padre divino è un animale e gli animali sono fratelli, per gli agricoltori e gli allevatori la grande madre terra è la genitrice comune di uomini e animali, ma solo gli uomini mangiano il pane e bevono il vino. Uccidere e mangiare gli animali smette di atterrirli, ma il pane e il vino continuano a essere sacri, perché corpo della grande madre e di tutti gli uomini. Non è sicuramente un caso che nelle società pastorali semitiche nasca il tabù del sangue delle vittime sacrificate (Il divieto di bere il sangue era addirittura contenuto con forza nelle tavole della legge mosaica) e sia considerata immonda la carne suina: sono tabù derivati dal rifiuto di diventare fratelli degli animali bevendone il sangue, contraendo quindi un debito con loro, mentre del maiale non si può mangiare nulla, perché non si nutre di sola erba ma di qualsiasi cibo, cadaveri umani compresi.