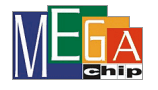Purtroppo, oggi, un’osservazione, anche solo macroscopica, della realtà mi costringe a considerazioni di altro genere nella valutazione del sistema.
Ne propongo alcune. Un numero sempre maggiore di persone, raccontano le statistiche, vive in condizioni di assoluta marginalità sociale, piomba nello sconforto della disoccupazione, o vive in condizioni di fragilissimo precariato lavorativo; l’anarchia crescente dei metodi di produzione provoca una enorme e progressiva sperequazione nella distribuzione della ricchezza, sia a livello di stati che di singoli, e provoca un dissesto nella compagine sociale, lacerandone il tessuto connettivo anche all’interno di gruppi ristretti; i sistemi- partito (usati per lo più come taxi per condurre al potere) non esistono più nelle forme tradizionali (iscrizione, partecipazione, militanza), di quelli è rimasto solo l’apparato vuoto di base partecipativa, con l’inevitabile iato tra chi gestisce, organizza la struttura e il suo funzionamento e la volontà generale; le iniziative di protesta denunciano mancanza di spirito di classe e sono quindi sempre meno organizzate e più spontaneistiche e legate ad istanze individualistiche; i più diffusi mezzi di comunicazione (è noto quanto il ruolo dell’informazione pubblica sia fondamentale per la garanzia della democrazia!), sono legati a differenti gruppi di potere, pertanto informano, ma ancor più drammaticamente formano, secondo direttrici ora demagogiche ora qualunquiste ora di paternalistica sufficienza, quando non di evidente faziosità, anche se tutti in nome e per conto di un presunto ordine democratico da salvaguardare (da che cosa? viene da chiedersi. Forse, proprio da loro!).
La linea di demarcazione tra interesse pubblico e privato è sempre meno netta ed evidente. Si confondono compiti, ruoli, competenze e tutto si traduce in un generale magma in cui è difficile distinguere quando l’interesse collettivo entra in collusione con gli affari di singoli o gruppi. Se pensiamo che una percentuale minima, non più del 1%, indica la direzione al restante 99% dell’umanità, ne fissa le tendenze e le modalità esistenziali, esercita l’egemonia culturale, guida i comportamenti economici, influenza pesantemente il modo di pensare, omologa persino il nostro sentire rispetto agli eventi e agli altri, non mi pare azzardato sostenere che la democrazia oggi come forma di governo ha fallito totalmente il compito nei confronti della sua presunta grande idea civilizzatrice.
La democrazia, pensata come un insieme di istituzioni il cui compito doveva essere quello di legittimare l’esercizio del potere politico, fornendo risposte sul piano del costante miglioramento della qualità di vita della popolazione, su quello del controllo, per assicurare la mancanza di abuso di potere, e sull’offerta ai cittadini della possibilità di esprimere le loro opinioni sapendo di incidere sull’esercizio stesso del potere, ha mostrato non solo la sua debolezza, ma la sua incapacità a rispondere anche solo in minima parte alla sua essenza.
La crisi nasce proprio dalla delegittimazione dell’idea di democrazia che il popolo, cosciente dell’assoluta impossibilità ad esercitare il controllo sul potere e della uguale impraticabilità ad esprimere incisivamente il proprio pensiero, del fatto che il suo consenso è stato troppe volte usato per legittimare un nuovo progressivo scippo del diritto all’autogoverno consapevole, attua attraverso differenti modi (allontanamento dai luoghi della politica, diminuzione di affluenza alle urne, rifugio in associazioni alternative a quelle pubbliche...).
La risposta che il sistema ha saputo dare alla sfida della gente ad entrare con più vigore nei processi democratici continua ad essere data, per i più fortunati, sul piano economico dei consumi ( panem, se va bene, et circenses), non certo su quello delle idee e della possibilità di esprimerle. Non possono stupire allora la delega disinteressata, l’apatia nei confronti dell’impegno, l’indifferenza verso la vigilanza, il controllo del potere e la sorte stessa della democrazia.
Pertanto, considerata la diffusa convinzione che la politica, i partiti e la democrazia stessa, come sono stati concepiti e percepiti fino ad oggi, non funzionino più, il problema consiste nella prospettiva futura. Non serve rifugiarsi nella nostalgia di un mitico passato (del cui maggior rigore e migliori correttezza e funzionalità c’è molto da discutere), come pure sono inutili e dannosi il rifiuto e la negazione tout court del presente. Rifugiarsi nel localismo sembra la soluzione più accettate praticata per difendere la possibilità di “contare” (anche se un sospetto dovrebbe far stare all’erta: come mai tutti, di qualunque parte o classe indistintamente lo cavalcano?).
L’autogoverno regionale e locale sembra una risposta all’esclusione dai grandi poteri, ma è un concetto ambiguo, solo apparentemente influente. Quali le difficoltà a vederli come la giusta soluzione? Riflettiamoci. Innanzitutto questo comporta: la necessità di riconoscersi in un gruppo identitario omogeneo quando il mondo, volenti o nolenti, sta andando in direzione opposta; il rischio di frammentazioni sempre maggiori; la difficoltà a tollerare pensieri divergenti insieme a battaglie (di mercato o di idee) per l’affermazione di sé contro gli altri (ma, la democrazia non è l’esatto contrario? cioè, il riconoscimento dell’eterogeneità e, in essa, dell’affermazione di uguali diritti e opportunità per tutti i cittadini?); infine, e non certo ultima, l’insufficiente coscienza del leggero peso che le decisioni locali hanno nelle dinamiche politiche generali che sono poi quelle che determinano il nostro modo di vivere, di pensare e di sentire.
Per capire, bisogna sempre vigilare, ci si deve chiedere a chi giova la ricomposizione di entità locali, dai confini certi e chiusi, alla ricerca delle proprie lontane matrici storiche e culturali (ma quanto si deve tornare indietro per arrivare alle famose “ radici”?).
Speriamo non a nuove oligarchie di potere che escludono ancora una volta la maggioranza! Ammettendo pure comunque che questa sia l’unica strada percorribile attualmente, alcuni rischi sono assolutamente da non correre, almeno cercando di trarre insegnamento dal passato: credere che la specialità dell’individuo garantisca la buona gestione della cosa pubblica e non viceversa, cioè che la specialità della posizione pubblica occupata deve essere garantita e salvaguardata da dialettica, regole e controlli (la prima è infatti una posizione di soggezione, la seconda è l’applicazione della democrazia); pensare che il consenso popolare, per quanto diffuso e radicato in una figura forte e carismatica, legittimi posizioni di rendita politica per tempi lunghi e consenta di tralasciare il dovere di continuo coinvolgimento o di eludere le richieste di partecipazione e di espressione che provengono dalla società civile; affidarsi agli “specialisti” che spesso curano più i loro interessi che quelli pubblici (diffidare sempre e di tutto è un esercizio di controllo critico che chi gestisce il potere non solo non deve aver paura di praticare, ma ha il dovere di attuare).
L’unico modo di non far morire l’idea di democrazia, quella delle poleis e della forza della rappresentanza, sta nel cercare nuove forme di coinvolgimento allargato e collettivo di tutti (non mi pare così difficile oggi con la diffusione della comunicazione globale!), non certo in un nuovo acritico affidamento.