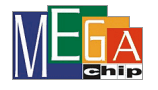La casa natale di Grazia Deledda, ad esempio, nonché quella di Francesco Ciusa, di Sebastiano Satta, di Gian Pietro Chironi sono tipici esemplari di costruzioni inquadrabili appunto in quell’anonimo ambientale che fortunatamente s’è conservato, al pari delle ancor più anonime case di San Pietro che ostentano il “faccia a vista” dei contones granitici, mai intonacati perché l’intonaco avrebbe rappresentato un’inutile ostentazione, in abitazioni che neppure ambivano ad apparire “di pretesa”.
Senza dubbio importanti, queste costruzioni, non perché dalla loro struttura possa trasparire alcunché di artisticamente pregevole, ma per il loro valore documentario, per la testimonianza di un vivere per certi versi primitivo che non ha mai inteso concedere nulla al “fatto visivo” appartenente “alla strada o alla piazza”, cioè a qualcosa “fatta per il pubblico”1. Per descrivere quelle particolari case del rione San Pietro, le parole più efficaci sono però senz’altro quelle di Salvatore Satta (2): “Le case sono grandi perché servi e pastori vivono insieme, mangiano nello stesso tagliere, si scaldano allo stesso fuoco, e questo rende i servi più servi, e i padroni più padroni”. Le case, insomma, raccontano di una società per certi versi primitiva.
Ma non v’è in esse, nella linearità delle sopraelevazioni o nella spiovenza dei tetti, ovvero nella collocazione delle porte o delle finestre (le cornici e i cornicioni sono cosa sconosciuta) alcunché di catalogabile nell’almanacco di storia dell’arte.
L’arte comincia però ad affacciarsi nell’interno delle piccole chiese settecentesche. Non all’esterno, di certo, perché sarebbe uno spreco concedere qualcosa alla strada o alla piazza. Anche la divinità tirava al risparmio. E se i muri esterni sono intonacati, ciò avveniva non per ragioni estetiche, ma perché la realizzazione di essi era “in pietrame di pezzatura irregolare legato con malta di calce (3) e, perciò, necessitante di una protezione. Senz’altro meno solide, allora, delle costruzioni padronali in contones granitici; perché i prinzipales pensavano prima alla loro dimora, e soltanto dopo contribuivano con scarse oblazioni alla costruzione delle chiese.
L’arte, come detto, comincia ad affacciarsi solo all’interno delle chiesette; e assume una standardizzata forma che caratterizza l’alzata dell’altare sovrastante la mensa (quella in cui sono inseriti il tabernacolo e la nicchia), resa caratteristica da una finta concavità verticale, palesemente simboleggiante l’invito a una accogliente trascendenza. Concavità illusoriamente accentuata da stilizzate colonnine, talvolta a tortiglioni, che contornano appunto quell’alzata e che rivelano un intento doverosamente decorativo (la decorazione era un tributo dovuto alla divinità).
È un’arte barocca minore, sommessamente comparsa in questa zona interna della Sardegna, portatavi da quegli avari Spagnoli che, invece, nei confronti di Cagliari, dell’Oristanese, di Alghero e di Sassari avevano abbondato nell’esportazione di uno sfarzoso barocco molto simile a quello “coloniale”. Quello nuorese, insomma, è un barocco di rango inferiore che non si eleva al di sopra del decorativismo minore; e poiché è apparentemente ispirato alle minuziose creazioni dell’argenteria viene denominato plateresco.
Peraltro, anche il rosone e la cornice del portone della chiesa delle Grazie sono timide espressioni artistiche; segni di un’arte che, tuttavia, dal punto di vista architettonico, non esprimerà a Nuoro alcun’altra manifestazione per quasi due secoli. Essi sono simboli di quell’eclettismo sardo che sommessamente tenta di accomunare il romanico, il gotico, il barocco: un eclettismo che sembra voler recuperare il tempo perduto, quasi ostentando rammarico o volontà di rivincita, per essere stato il villaggio medievale (Nuoro) completamente trascurato dai costruttori delle chiese bizantine prima e romanico pisane dopo.
Anche le coeve pitture murarie che ornano l’interno della chiesa delle Grazie (4) sono destinate a rimanere muta (e poi occultata) testimonianza, per quasi due secoli, di un’isolata parentesi artistica. Il barbaricus non trova, evidentemente, i mezzi per avvicinarsi all’arte.
* * *
Un risveglio estetico si manifesterà, infatti, solo verso la metà del secolo XIX, quando il vescovo Giovanni Maria Bua deciderà di edificare, al posto di una vecchissima chiesa cattedrale, addirittura pericolante per i segni del tempo, una nuova chiesa, un monumento che si caratterizzi per la grandiosità.
Di quell’antica chiesa cattedrale (che sorgeva, grosso modo, ove ora è lo spiazzo antistante l’odierna) sappiamo poco. Risulta, però, ch’era sovrastata da una cupola, certamente di ben ridotte dimensioni, se per la sua demolizione fu sufficiente il lavoro di soli sei operai (5). Che vi fossero all’interno vere e proprie opere d’arte non lo rilevo da alcuno scritto. Vi erano, bensì, dei “dipinti in completa rovina (6); ma non sappiamo se si trattasse di vere e proprie raffigurazioni pittoriche, o di segni esprimenti mera decoratività (7). In ogni caso non v’era nulla di paragonabile ai magnifici affreschi della storica cattedrale di Saltelli (8), da cui l’episcopato era trasmigrato a Cagliari, per poi approdare a Nuoro, dopo che Alessandro VI, nel 1496, aveva soppresso la diocesi galtellinense (9).
Il vescovo Bua intendeva erigere una chiesa monumentale che, “nella sua forma ed eleganza deve corrispondere al primario suo destino di Casa del Signore (10). Chiamò, quindi, uno degli architetti che andavano per la maggiore in Sardegna, precisamente il frate sassarese Antonio Cano, già segnalatosi per avere ristrutturato in forme neoclassiche il convento eretto dagli Scolopi, in Oristano; ma era non meno celebre per avere realizzato, in Sassari (con la collaborazione di Giovanni Cominotti, che aveva già realizzato a Nuoro il palazzo del Seminario, e Felice Orsolini), il palazzo San Sebastiano e, in Sorso, le cupole della chiesa parrocchiale di San Pantaleo (11).
Accettato l’incarico, il frate architetto progettò la nuova cattedrale in forme neoclassiche, e subito si diede inizio ai lavori: la vicenda della costruzione, cartaceamente iniziata nel 1835, continuò appunto con l’inizio dei lavori, l’anno successivo (12), sotto la direzione dello stesso Cano, a opera dell’Impresa Vittorio Fogu di Sassari (13). L’architetto, però, non concluse i lavori, perché morì nel 1840, cadendo da un’impalcatura. Gli stessi lavori, comunque, si conclusero nel 1853, anno in cui la Chiesa fu aperta al culto (14).
* * *
Nella prima metà dell’Ottocento – così com’era stato nei secoli precedenti (da quando gli Spagnoli, attuando la loro politica coloniale del divide et impera, avevano reso effettiva la contrapposizione tra il Nord e il Sud dell’Isola) e sarà ancora per oltre un secolo – Nuoro gravitava su Sassari, anche culturalmente.
Sicché rientrò nell’ambito di una regola, non scritta ma tuttavia scrupolosamente osservata, che la committenza di un’opera architettonica da impostare secondo i canoni della monumentalità rivolgesse la propria attenzione a un architetto sassarese. Uno di quelli che, per apprendere l’arte delle costruzioni, aveva varcato il Tirreno; così come appunto aveva fatto il Cano che, fra i primi, fece quello che poco più tardi farà Salvatore Calvia de Mores (allievo a Torino, di Alessandro Antonelli). Ma già determinante era stata, in Sardegna, l’opera del piemontese Gaetano Cima, formatosi a Roma nell’Accademia di San Luca e quindi trasferitosi a Cagliari. E proprio nell’Accademia di San Luca, allora illuminata dalla genialità di Antonio Canova, aveva mosso i primi passi Antonio Cano, il quale ebbe così modo di recepire i canoni di quella tendenza artistica che va sotto il nome di “neoclassicismo”.
* * *
L’annosa vicenda della costruzione della cattedrale nuorese è ampiamente documentata negli archivi della curia vescovile; e sarebbe veramente interessante, e perciò auspicabile, la pubblicazione integrale dei relativi documenti, come peraltro è stato già auspicato (15), perché l’alterno ritmo dei lavori, contrassegnato da vicissitudini burocratiche, si caratterizzò per un’appassionata partecipazione dei nuoresi, i quali per la prima volta vedevano sorgere un edificio di valenza monumentale (16).
Quella partecipazione, come peraltro tutte le partecipazioni popolari, subì alti e bassi, correlati appunto al ritmo alterno dei lavori. Si giunse persino a contestare il Cano, ritenendolo non all’altezza dell’opera, adducendosi, a fini probatori, che le chiese di Oristano e Sorso, da lui progettate, “erano crollate” (17).
La contestazione toccò il culmine quando investì l’Impresa costruttrice la quale aveva innalzato la facciata senza apporvi le quattro colonne granitiche ch’erano previste dal progetto. Il costruttore giustificò il proprio operato adducendo di “non essere riuscito ad avere una squadra di scalpellini”(18); ma la contestazione servì, quantomeno, ad imporre un più sollecito completamento dell’opera.
La “squadra” fu reclutata e le colonne granitiche furono apposte alla facciata della chiesa, testimoni di quel momento storico che aveva trovato un primo teorizzatore in Johann Joachim Winckelmann, il quale, con la sua Geschichte der Kunst des Altertums (1764) aveva scorto nell’età di Pericle il momento culminante di un’arte che, manifestatasi attraverso la semplicità e la grandezza (presupponente una sintesi di libertà e di moralità), postulava quel “bello ideale” ch’era la sublimazione del bello naturale.
L’età dell’Atene classica, appunto, in cui pensiero e arte trovano sintesi nell’equilibrio morale che l’età illuministica non aveva ancora saputo recuperare appieno. E quando quel recupero avverrà, l’atteggiamento degli autori di esso sarà denominato “neoclassico”, anche e soprattutto perché prende l’avvio da uno studio attento delle opere dell’antichità classica e si concreta in una riflessione che finisce per postulare la rielaborazione di esse (19). * * * Il neoclassicismo, nel campo dell’architettura, era arrivato in Sardegna quasi inosservato, inizialmente, poiché per tutto l’Ottocento la dominante architettonica era quella di stampo neorinascimentale, pur se il Rinascimento, quello storicamente circoscritto, non aveva svolto (in quel campo, appunto) un ruolo incisivamente determinante (20). Ma quando i giovani, potenziali artisti cominciarono a varcare sistematicamente il Tirreno, per assimilare altre culture, ecco che l’esigenza di “tenersi aggiornati”, cioè al passo coi tempi, impose l’introduzione delle nuove tematiche, forse in ritardo rispetto al Continente italiano, ma non tanto da apparire evidente a chi non fosse stato spinto dalla fisima dell’immediato uniformarsi alle avanguardie.
Fu così che lo stile architettonico neoclassico si diffuse in Sardegna intorno agli anni Trenta e Quaranta del XIX secolo. Gaetano Cima (piemontese di nascita e, come detto, trapiantato a Cagliari in quanto docente di architettura nell’Università) edifica il convento di San Francesco a Oristano (1838), la chiesa parrocchiale di Guasile (1839) e l’ospedale civile di Cagliari (1842). Salvatore Calvia, come detto, nativo di Mores e già allievo a Torino di Alessandro Antonelli, erige il campanile che ha reso celebre la chiesa parrocchiale del suo paese (1871) e, inoltre, introduce a Ozieri le “altane” che ornano i palazzi del centro storico, conferendo ad essi una parvenza neoclassica. Ma è soprattutto per opera del Cano che quello stile trova affermazione in Sardegna, principalmente per l’opera monumentale che è appunto la cattedrale di Nuoro.
Il Cano conosceva alla perfezione i postulati della nuova scuola, improntati alla linearità e alla semplicità architettonica. Sapeva bene, però, che la loro applicazione rigida (dalla quale sarebbe potuto scaturire il risultato di una fabbrica modellata a foggia di un paganeggiante tempio greco) andava sapientemente coniugata col presumibile gusto di intransigenti committenti che, pur senza dichiararlo espressamente, potevano in ipotesi essere legati ai canoni di un decorativismo inteso come doveroso tributo alla Divinità (non va, infatti, dimenticato che il barocco era nato a Roma nell’ambito di un programma culturale che si prefiggeva, principalmente, la glorificazione della Chiesa).
Alla linearità sovrappose, perciò, quel tanto di decorazione che avrebbe dovuto scongiurare il pericolo di far apparire i suoi canoni architettonici come l’irruzione di una eretica dottrina iconoclasta. Decorazione più evidente nell’interno, ma anche riscontrabile nella facciata delineata da due slanciati campanili e ornata da quattro enormi semicolonne granitiche sormontate da capitelli dorici; e altresì nel timpano, sotto il quale attira ancor oggi l’attenzione la “sibillina” scritta DEIPARAE VIRGINI A NIVE SACRUM (21). All’interno, come detto, la misurata coniugazione della neoclassica impostazione lineare con elementi decorativi tardobarocchi tratti dalla tradizione delle monumentali basiliche crea quel singolare effetto di solennità che solo la misteriosità delle commistioni stilistiche riesce a concretare.
Forse, una parte di quell’effetto è oggi scomparso, perché purtroppo v’è stata una recente manomissione che sembra proprio finalizzata a farlo scomparire.
Sono bensì rimasti i finti capitelli corinzi che sormontano le modanature verticali: ma è stata demolita la monumentale edicola marmorea (tardo barocca, appunto) sovrastante il ciborio dell’altare maggiore (22), già costituita da una copertura a forma di cupola sorretta da sei snelle colonnine neogotiche, vanamente vigilata da due angeli marmorei.
Dell’edicola non v’è più traccia; mentre i due angeli, puniti forse per non avere vigilato abbastanza, sono stati confinati nel presbiterio, entro nicchie che li nascondono alla vista dei fedeli e dei visitatori.
Anche la balaustra delimitante l’altare è stata ridotta di dimensione, così rompendo quell’armonia compositiva alla quale i nuoresi s’erano abituati, tanto da considerarla uno degli elementi artistici qualificanti. Si disse che l’intervento aveva ricondotto l’altare maggiore all’originaria forma disegnata dall’architetto Galfrè, alterata da un intervento del 1932. Ma i sostenitori di tale assunto, fondato su circostanze finora ignorate, dovrebbero quantomeno darne prova mediante pubblicazione dei relativi documenti.
Il discorso sulla discutibile e discussa validità dell’intervento, perciò, potrà proseguire soltanto dopo che quella pubblicazione sia avvenuta. Ma già va anticipato che la demolizione di opere murarie costituenti stratificazione storica non è mai giustificabile, se non nei casi in cui la stratificazione medesima integri un deturpamento dell’opera originaria, ovvero ne vada di mezzo la staticità di quest’ultima, proprio a causa dell’improvvida aggiunta.
Ma nessuna di queste ipotesi riguarda quell’opera complessa che è l’altare maggiore della cattedrale di Nuoro.
1) Traggo queste espressioni da GIULIO CARLO ARGAN, L’arte barocca, Roma, Newton Compton (Skira), 1989.
2) Il giorno del Giudizio, Cap II.
3) L’espressione è di FEDERICA DINI, La Chiesa delle Grazie e le sue pitture murali, Nuoro, Solinas, 2001, pag. 31. In quel medesimo contesto la chiesa delle Grazie, che è un probante esempio della nostra architettura secentesca, è catalogata come “edificio che presenta i caratteri stilistici tipici dell’eclettico sardo del XVII secolo”.
4) Una dettagliata descrizione critica, accompagnata dai risultati di una profonda riflessione filologica, è nel citato saggio di FEDERICA DINI.
5) ELETTRIO CORDA, Storia di Nuoro, Milano, Rusconi, 1987, pag. 122. FEDERICA DINI, op.cit., pag. 95, riporta in immagine fotostatica la planimetria del progetto di Antonio Cano, in cui è posta in chiara evidenza cromatica l’ubicazione della vecchia cattedrale, denominata Santa Maria Maggiore.
6) ELETTRIO CORDA, op.loc.cit.
7) Del tipo di quelli, molto rudimentali e ingenui, affiorati pur in minima parte, nella Chiesa della Madonna di Valverde.
8) Sugli affreschi nell’antica cattedrale di Galtellì la letteratura è ormai ampia. Ai relativi studi aveva dato l’avvio lo scritto di GIANNI PITITU, Splendono gli affreschi, l’Arte come richiamo rutistico, in L’Unione Sarda, 25 marzo 1994. Aveva quindi fatto seguito, nel 1995, il convegno di studi organizzato in Orosei dal Centro Studi G.Guiso, nell’ambito del quale assunse particolare rilevanza la relazione di RENATA SERRA, dal titolo Gli affreschi della cattedrale di San Pietro di Galtellì. Nell’impossibilità, in questa sede, di citare tutti gli scritti relativi all’argomento, pare tuttavia utile ricordare l’ampio excursus storico filologico della stessa RENATA SERRA, dal titolo Storia della salvezza nella pittura e nelle sculture romaniche in Sardegna, in AA.VV., Studi in onore di Ottorino Pietro Alberti, Cagliari, Della Torre, 1998, pag. 121 s. Si veda anche, per i riferimenti storici, il mio Gli affreschi dell’antica cattedrale di Galtellì. La storia attraverso le pitture murarie, antologicamente inserito nel (sempre mio) Filosofia estetica e critica dell’arte, Rho, Edicom, 1998, pag. 225 s., nonché in AA.VV., Studi in onore di Ottorino Pietro Alberti, cit., pag. 115 s.
9) La diocesi di Galtellì fu dapprima trasferita a Cagliari, nel 1496 (per incorporazione), poi a Nuoro, nel 1779, come nuova istituzione (vescovo Giovanni Antonio Serra Urru). Per le relative vicende, v. SALVATORE BUSSU, Nuoro e il senato del vescovo, Nuoro, Solinas, 2001; nonché OTTORINO ALBERTI, Il Cristo di Galtellì, Roma, Lateranense, 1967.
10) Lettera del vescovo Bua al Viceré, in data 8 ottobre 1836, riportata in GIACOMINO ZIROTTU, Nuoro. Dal villaggio neolitico alla città del 900, Nuoro, Solinas, pag. 104.
11) VICO MOSSA, Vicende dell’architettura in Sardegna, Sassari, Delfino, 1994, pag. 133.
12) GIACOMINO ZIROTTU, op. loc. cit.
13) ELETTRIO CORDA, op.cit., pag. 125.
14) GIACOMINO ZIROTTU, op.cit., pag. 105. Dopo la morte del Cano, i lavori continuarono sotto la direzione dell’architetto Giacomo Galfrè e dell’ingegnere Antonio Orunesu, i quali divennero “rivali” in quanto “sponsorizzati”, rispettivamente, dalle opposte fazioni che avevano spaccato il rissoso Capitolo dei canonici (v. SALVATORE BUSSU, op. cit., pag. 341).
15) SALVATORE BUSSU, op. cit., pag. 358.
16) ELETTRIO CORDA, op. loc. ult. cit.
17) Traggo la notizia da GIACOMINO ZIROTTU (op. cit., pag. 105); ma non rinvengo precisi riscontri degli asseriti “crolli”.
18) ELETTRIO CORDA, op. cit., pag. 126.
19) I termini “neoclassico” e “neoclassicismo” vengono qui adoperati tenendo conto del significato più restrittivo ch’essi storicamente assumono; ossia per indicare quella fioritura (letteraria e) artistica che può essere circoscritta al periodo immediatamente successivo allo scoppio della Rivoluzione Francese (cioè immediatamente successivo al 1789) e che, grosso modo, termina con l’inizio della Restaurazione (1816), a sua volta coincidente con l’inizio della polemica tra classicisti e romantici. Occorre, peraltro, chiarire che sarebbe sempre erroneo cedere alla tentazione di denominare “neoclassiche” certe (per taluni versi analoghe) tendenze in ipotesi rinascimentali (l’esempio sarebbe quello di Raffaello), che pure concedono molto all’arte dell’antichità classica; perché con siffatto uso metastorico o semplicemente categoriale del termine si perverrebbe solo a una confusione concettuale. È ben vero, peraltro, che non è dato rinvenire nella storia (letteraria e) artistica la fine di alcun “movimento” riferibile a una data certa posto che qualunque tendenza (letteraria o) artistica presenta sempre quegli strascichi che inducono alla classificazione categoriale “in ritardo”. Il che andava qui chiarito perché, in base a non scritte regole che governano l’iter culturale tipico dell’insularità, anche il neoclassicismo arrivò in Sardegna, e particolarmente a Nuoro, come tendenza artistica “in ritardo”, pur se assolutamente valida.
20) VICO MOSSA, op. cit., pag. 155 s.
21) Quella scritta che fa dire a SALVATORE SATTA (Il giorno del giudizio, Cap. II) “che neppure i preti riuscivano a tradurre”. Certamente ironica la constatazione sattiana (Salvatore Satta era un fine latinista), suggerita forse dalla circostanza a un primo impatto potrebbe essersi indotti ad attribuire al sostantivo sacrum quell’italianeggiante valore aggettivale che lascerebbe sospeso (incompiuto) l’intero periodo. Scritta che ha attirato l’attenzione di FRANCO FLORIS (Il Capoluogo), il quale coglie l’occasione della narrata “passeggiata scolastica” transitante attraverso la piazza della cattedrale per descrivere un’estemporanea esercitazione didattica: “Tuttavia non lasciavano cadere l’occasione senza che le prime classi discettassero sulla corretta traduzione della scritta (Deiparae Virgini a nive sacrum) campeggiante sul frontone della chiesa”. Ma questa è anche un’occasione per continuare nella lettura e gustare l’efficace descrizione (garbatamente ironica) della chiesa: “Non solamente la più grande della diocesi e del circondario – e ora della provincia, ma anche l’unica ad avere due campanili, raccordati da un timpano entro il quale da una grande cifra al centro, VM – a lettere elaboratamente sovrapposte, si dipartivano rilevati a intonaco tanti disuguali segmenti significanti raggi di luce spirituale sprigionanti con chiara evidenza da quelle divine iniziali: essendo infatti il tempio dedicato alla Vergine Maria, il cui riferimento alla neve, per altro, costituiva niente più che un attributo locale di limitata casualità meteorologica” (Cap. Elette virtù).
22) Altare progettato dall’architetto piemontese trapiantato a Nuoro Giacomo Galfrè. Altare che sarebbe stato ritoccato nel 1932: cfr. SALVATORE BUSSU, op. cit., pag. 365.