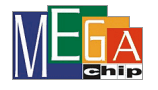A questo punto, resta solo da chiedersi il perché.
Perché, oggi, in questa fase
così cruciale e drammatica della guerra in Iraq, è scoppiato il bubbone delle
torture? Perché quello che, con evidenza, tutti sapevano e alcuni denunciavano
da mesi se non da anni, americani, inglesi, italiani, Croce rossa, Amnesty
international e chi più ne ha più ne metta, è balzato alla ribalta in maniera
così dirompente? Perché l'orrore di pratiche consolidate e gestite dall'alto,
generalizzate e programmate dagli strateghi della "lotta al
terrorismo", trova solo ora tanto risalto sui media di tutto il mondo? Sono
queste le domande che i bravi democratici di tutti i colori, colpiti brutalmente
allo stomaco da questa tragica esposizione delle nudità del re, devono
cominciare a porsi. E nessuno creda di convincerci, come ci ripetono
ossessionanti e insopportabili, i difensori d'ufficio della superiore civiltà
occidentale, che lo "scandalo" è venuto alla luce per la buona
coscienza di qualcuno e che una grande democrazia è tale proprio perché capace
di denunciare, condannare ed "elaborare" le sue colpe e le sue infamie
quasi fossero le scorie inevitabili di un fine ultimo nobile e generoso.
Poche storie! questa Grande Democrazia, spalleggiata da meschini e piagnucolanti
alleati, non ha commesso un passo falso, non è stata tradita da alcune pecore
nere gettate prontamente in pasto alla pubblica esecrazione, ma ha
coscientemente pianificato, teorizzato e organizzato il sistema di vessazioni e
torture venuto oggi alla luce, ha preso gli uomini e i metodi operanti nelle
tragiche prigioni d'America e li ha trapiantati ovunque si rendesse necessario
affogare nel terrore la capacità di resistenza delle genti cadute sotto il suo
controllo militare. Oggi si parla di Abu Ghraib, ma ci siamo forse scordati di
Kali Jangi, di Bagram, di Diego Garcia e... di Guantanamo?
Sappiamo e andiamo dicendo da tempo, che la guerra in Iraq, e non solo in Iraq,
è al tempo stesso un gigantesco business economico e l'episodio di un più
vasto disegno strategico volto a imporre l'egemonia statunitense a livello
globale. Lasciando da parte le trite facezie sulla volontà di portare libertà
e benessere al popolo iracheno, è chiaro che la posta in gioco è vitale: il
rilancio dell'economia americana con la ricostruzione e gli stanziamenti
all'industria bellica, il possesso di preziosissime fonti di energia non
sufficientemente sfruttate, il controllo di vie di transito che non possono
essere lasciate al "nemico", l'installazione di basi militari in zone
sempre più strategiche, l'affermazione apodittica del diritto del più forte
contro il cosiddetto diritto internazionale. In poche parole, gli Stati Uniti
stanno giocando il loro futuro anche nei deserti mediorientali. E di questo
l'establishment americano ne è perfettamente consapevole. Quindi non si possono
fare errori.
La gestione dell'intervento in Iraq è un cumulo di errori, la disastrosa
dimostrazione dell'inadeguatezza, a medio e lungo termine, della arrogante e
aggressiva politica dei neoconservatori guidati da Cheney e Rumsfeld. Incapacità
di controllare il territorio, deterioramento dei rapporti con le componenti
inizialmente non ostili, progressivo sfaldamento della tenuta della coalizione,
elevato numero delle perdite, prevedibile impossibilità delle imprese
"ricostruttrici" di svolgere il loro lavoro. Davvero un bel pasticcio,
e infatti, sul finire di aprile, è arrivato il primo segnale, con due fra le
maggiori multinazionali chiamate a rimettere in piedi l'Iraq, Siemens e General
Electric, che hanno abbandonato la partita. Ed esattamente due giorni dopo sono
state tirate fuori dal cassetto, e hanno cominciato a girare, le prime foto
delle torture di Abu Ghraib. Non credo che sia un caso.
Appare evidente, ormai, che in Iraq le cose non possono andare avanti così, e
che si impone un cambio nella conduzione di tutta la campagna. Com'è facile
immaginare, altre lobby e altre stanze del potere economico e militare,
preoccupate per i loro interessi, hanno studiato strategie alternative a quelle
della fallimentare gestione di Bush e accoliti. Il gioco si fa duro, siamo in
guerra, e in guerra tutto è permesso: anche nelle guerre intestine. Ecco,
dunque, portato su un piatto d'argento, lo "scandalo" capace, se non
di scalzare l'attuale amministrazione, di condizionarne, almeno, il
comportamento, imponendo un decisivo, e più "democratico", cambio di
rotta. Un avvertimento pesante agli strateghi del Pentagono, apparentemente
onnipotenti ma evidentemente sotto tutela e ricatto dei potentati economici, un
avvertimento con il quale, costi quel che costi, si possano riprendere le fila
di un progetto imperialistico, ancora unanimemente condiviso nei fini ma non più
negli strumenti. E la pervicacia con la quale l'impresentabile Rumsfeld si
aggrappa alla poltrona, accompagnata all'accorta regia con la quale sono
centellinate le immagini della vergogna, la dicono lunga sulla durezza dello
scontro.
Indubbiamente il prezzo pagato sull'altare dell'immagine è particolarmente
salato, come salate saranno le cambiali che porteranno all'incasso amici e
nemici fuori e dentro gli Stati Uniti. Ma non tutto il male viene per nuocere e
gli effetti di questa sindrome esibizionista (come alcuni l'hanno acutamente
definita) con la quale l'America ci mostra la propria perversa potenza, potranno
avere, nel lungo periodo, ottime ricadute. Questa apparente catarsi collettiva,
con la quale un intero paese crede di ricostruirsi una coscienza vergine, e
celebra la propria presunta superiorità morale dimostrando al mondo di saper
riconoscere e rimediare ai propri errori, non diventa altro, infatti, che il
prodromo di nuovi conflitti. Conflitti, ancora una volta, giustificati e
accettabili, perché, come si sa, l'America è una grande democrazia.
Massimo Ortalli