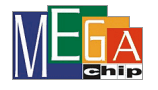Sembra proprio di sì.
A cominciare da “Cainà” di Gennaro Righelli (1922) fino a “Banditi a Orgosolo” (1963) di Vittorio De Seta, il mondo del cinema ha guardato all’isola saccheggiando l’immaginario deleddiano.
Il film di De Seta segna un punto di svolta, perché negli anni Sessanta e Settanta l’interesse nei confronti della Sardegna si è spostato sul fenomeno del banditismo e il cinema testimonia un’attenzione sociologica e antropologica. De Seta non si è lascito schiacciare dal fatto di cronaca e si è sinceramente avvicinato all’ambiente sardo mantenendo una posizione di osservatore neutrale, offrendo alla realtà sarda un momento per autorappresentarsi e per mettersi a confronto con l’immagine di sé, creando in questo senso valore identitario.
I due estremi, “Cainà” e “Banditi a Orgosolo” sono esempi di cinema sardo realizzato da autori non sardi che dimostrano come la distanza, la non appartenenza, siano elementi che possono giocare un ruolo positivo nella costruzione di un’immagine autentica.
Abbiamo appena introdotto questa nuova espressione: “cinema sardo”.
Saltiamo in un sol colpo decenni di storia del cinema e arriviamo ai giorni nostri, al recentissimo “nuovo cinema sardo”.
Da non pochi anni l’interesse del cinema nei confronti del mondo sardo muove direttamente da alcuni registi sardi: Gianfranco Cabiddu, Antonello Grimaldi, Giovanni Columbu, Enrico Pau, Piero Sanna, Salvatore Mereu, Enrico Pitzianti. Cominciamo subito col dire che questa espressione “cinema sardo” deve essere ridimensionata.
Perché quando diciamo “cinema sardo” non diciamo una cosa equivalente a “cinema italiano”, “cinema francese” e così via, ma diciamo (o vorremmo dire - o perlopiù abbiamo la presunzione di dire) qualcosa di simile o vicino a un cinema oggettivato in termini identitari, laddove cinema italiano definisce, con una facile semplificazione, una dimensione geografica e linguistica.
Quasi che il cinema sardo fosse comunque, al di là delle intenzioni degli autori, come corpo fenomenologico consolidato, la punta espressiva di una sorta di manifesto programmatico se non geneticamente almeno antropologicamente assunto, assimilato e codificato. In realtà non esiste un “cinema sardo” di questa fatta, ma esiste un cinema che racconta il desiderio di raccontarsi dei sardi, o meglio, il bisogno di comunicare di alcuni autori nati in Sardegna che cercano e trovano nell’isola i soggetti per le loro opere e che innescano dinamiche di appartenenza in quanto riflessioni sull’identità.
Rispetto a “Cainà” la differenza è sostanziale: in quel cinema sardo c’era il tentativo di mettere i sardi davanti all’immagine di sé stessi mentre l’autore ne stava di fatto fuori. In questo nuovo cinema sardo è inevitabile il coinvolgimento diretto, immediato, degli autori, che non sono solo soggetti narranti, ma fanno parte di quell’oggetto narrato di cui ci parlano.
Ecco che si parla di “nuovo cinema sardo” perché improvvisamente, in questi ultimi due anni, alcuni autori nati nell’isola hanno raccontato storie sarde ambientate in Sardegna e si sono fatti notare all’esterno.
Sono quattro i film di cui in questi ultimi due anni si è fatto un gran parlare: “Pesi leggeri” di Enrico Pau, “Arcipelaghi” di Giovanni Columbu, “La destinazione” di Piero Sanna e “Ballo a tre passi” di Salvatore Mereu.
Certo sarebbe fuori della realtà e segno di presunzione parlare di una “nouvelle vague” sarda. Non esistono elementi nemmeno per dire che ci sono indizi di un possibile sviluppo in questo senso. Bisogna invece dire che se è vero che c’è una grande voglia dei sardi di raccontare la propria terra questa voglia si realizza grazie ai contributi dello stato italiano. Non possiamo restare indifferenti a questo aspetto fondamentale, che porta a sottolineare il fatto che questi film si comprendono e devono essere compresi - comunque se non prima di tutto - all’interno di una politica culturale e di una produzione cinematografica nazionale.
Poi a noi piace soffermarci maggiormente sul come l’immagine di questa identità si trasforma e prende forma nell’identità di un immaginario, facendosi concetto.
Non appaia forzata questa introduzione del concetto nel discorso, perché non si tratta di una astratta divagazione filosofica. Tra cinema e filosofia c’è un nesso vivo e profondo proprio grazie al rapporto vivo che c’è tra l’immagine e il concetto.
Lo diceva Deleuze, filosofo sì, ma in grado di mette a nudo il rapporto archeologico che l’immagine mantiene con l’identità collettiva.
C’è nel concetto un rapporto con l’immagine e nell’immagine un rapporto con il concetto tale che il cinema produce identità in quanto produce immaginario. Perché il nodo cinema-filosofia va direttamente al cuore del problema dell’immagine delle società moderne? Perché il cinema, per la maniera specifica con la quale si rapporta con l’immagine, ovvero come costruttore di immagini di pensiero, è produttore di sistemi di conoscenza. In che modo entra in gioco l’immaginario? Noi siamo abituati a pensare che l’immaginario coincida con l’irreale. Quando diciamo che una cosa è immaginaria vorremmo dire che è irreale. Invece l’immaginario va inteso - ci dice Deleuze - come “luogo di sovrapposizioni di reale e irreale, tra un’immagine attuale e un’immagine virtuale, il virtuale diviene attuale e viceversa”.
L’immaginario è il terreno in cui avviene questo scambio, in cui non è possibile distinguere quale sia l’esatta posizione dell’attuale e del virtuale.
Questo significa che l’immaginario costruito dal cinema sardo è alimentato da questa doppia natura dell’identità, virtuale e reale ad un tempo.v È un’identità che affonda nel passato, ma che viene proiettata in una dimensione che irrealizza quel passato per farla diventare attuale e che nello stesso momento in cui la sentiamo attuale ne emerge il peso, il profondo sedimentato.
Un recente articolo di Gianni Olla pubblicato dalla rivista “Nae”, intitolato “I tabù dell’immaginario culturale sardo”, rende conto delle reazioni del pubblico alla visione dei recenti film sardi e sostiene che “nel comune spettatore la riconoscibilità regionale si è sovrapposta quasi automaticamente al gradimento”, per cui le reazioni contrastanti oscillano tra chi sostiene che quelle differenti immagini di Sardegna esistono ancora oppure non esistono più. È vero che è un annosa questione: basti ricordare le violente reazioni al film “Padre padrone” dei fratelli Taviani, tra le quali una molto famosa di Michelangelo Pira che contestava l’esistenza di quella Sardegna. Le polemiche sottolineano una vivacità forte, perché i sardi ci tengono a valutare l’immagine che il cinema offre di loro, in quanto in quell’immagine è pregnante la sostanza identitaria.
Ma le reazioni contrastanti e le polemiche scaturiscono dalla natura problematica di questo immaginario che è l’identità, proiettando nella soggettività dello spettatore il corpo a corpo instancabile e irrisolvibile dell’attuale e del virtuale, espressione concettuale di quella sovrapposizione estetica e perennemente conflittuale di riconoscibilità e gradimento.
Queste sovrapposizioni sono vissute e sentite creativamente dai registi sardi in forma complessa e articolata e i due poli, immagine e identità, sono tenuti scissi anche in forza dell’antinomia tradizione/modernità.
Articolata e non semplicistica, perché per i registi sardi l’identità non sta semplicisticamente dalla parte della tradizione così come l’immagine non sta tout court dalla parte della modernità. La questione è più nodosa.
È questa complessità che spinge gli autori ad essere coraggiosi nella scelta degli attori, nella scelta dei luoghi, nel voler riprendere il discorso della lingua, nel valorizzare il dialetto, lo slang metropolitano, nel risolvere per la sottotitolatura che mantiene ferma la presenza linguistica come tratto determinante del racconto cinematografico.
Paradossalmente la scelta moderna di questi registi consiste nell’ignorare quelle soluzioni che verrebbero incontro alle esigenze di un pubblico considerato neutro e amorfo. Sono infatti scelte che fanno discutere e che spesso dividono gli spettatori, ma che costituiscono un dato stilistico importante e che i critici cinematografici d’oltremare hanno tutti valorizzato.
Questi elementi sono riscontrabili anche fuori dell’isola: si vedano i successi e la riuscita in Italia di film a carattere locale. È vero infatti che in un’epoca di prorompente globalizzazione i migliori risultati estetici e culturali si riconoscono laddove trovano espressione realtà locali e circoscritte.
Numerosi sono i film che raccontano storie e figure la cui identità è, principalmente, di tipo regionale e dialettale, senza che ciò comporti una minore resa estetica. Il cinema “sardo” è sintonizzato su questa lunghezza d’onda: dare cornice locale alla storia, far respirare l’aria, le pietre, la natura, la lingua, la cultura che costituisce la nostra contemporaneità: in questo contesto immagine e identità si sovrappongono alla grande.
Eppure quello che fa grande un film è il fatto che in questo sovrapporsi i due elementi contrastino senza risultare egemoni. Prendiamo il film di Mereu.
La sua riuscita estetica e spettacolare è dovuta proprio al fatto che il film esce fuori dall’angusta cornice di un cinema impropriamente definibile come “sardo”. Si può parlare di un cinema “sardo” che riesce a coniugare immagine e identità quanto più si allontana da un’esteriore e superficiale rappresentazione della sardità, cancellando la vocazione introversa e pericolosa del gretto e ideologico nazionalismo che anima alcune tendenze politico-culturali retrive che si agitano nell’isola e sostenendo invece una estroversione culturale, capace di dialogare e scambiare forme e contenuti della diversità.