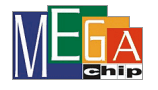Era incuneata tra due strade, e la facciata, di pochi metri di larghezza, era prospiciente la piazza S. Carlo, quasi di fronte alla Chiesa.”.
Sono, quelle qui riportate, parole tratte dalla nota autobiografica di Francesco Ciusa, da lui stesso denominata Pagine per una autobiografia, pubblicate con Introduzione di Mario Ciusa Romagna nel monografico libro d’arte Francesco Ciusa, curato da Rossana Bossaglia per le edizioni ILISSO (Nuoro 1990), con contributi di Mario Ciusa Romagna e di Maria Elvira Ciusa.
La casa descritta, la casa natale di Francesco Ciusa, appunto, esiste ancora, fortunatamente; ma è in stato di totale rovina. E nessuno sembra volersi dare carico di quello squalificante degrado.
Non può, tuttavia, dirsi che l’Amministrazione pubblica ignori chi sia Francesco Ciusa. Sarebbe bella, peraltro. Quando ha restaurato la chiesa di Santu Caralu ha pensato bene di tumularvi, all’interno, le spoglie di Francesco Ciusa, opportunamente guardate da una copia bronzea del capolavoro La madre dell’ucciso, e di collocare, all’esterno, nella piccola facciata, una lapide commemorativa.
Ma della vicina casa natale pare proprio essersi dimenticata. E questo è grave, perché se la memoria non ritornasse al più presto, quella costruzione crollerebbe interamente.
Il tetto è già crollato, i muri sono ormai pericolanti (ma sono certamente recuperabili con la tecnica della c.d. “rete elettrosaldata”). Si ha l’impressione - spiacevole, peraltro - che il comune di Nuoro non concepisca nemmeno il recupero delle antiche costruzioni se, prima, non abbia stabilito quale destinazione utile dovrebbe essere attribuita all’edificio restaurando. E questo è un errore, almeno nel caso concreto, perché una destinazione fissa sarebbe difficile da programmare, data l’angustia dei locali, e perché, nel frattempo, il costo del restauro aumenterebbe in proporzione all’aumento dell’ulteriore degrado.
A parte, però, l’aspetto economico, andrebbe ricordato che il recupero architettonico della casa natale dei cittadini illustri è qualcosa che vale di per sé, come fatto culturale che prescinde da ogni e qualunque considerazione pratica di vantaggio economico: è come se si erigesse un monumento commemorativo.
Non senza considerare, peraltro, che la destinazione migliore, in casi di questo tipo, è la semplice predisposizione ad ospitare - quando la ristrettezza degli spazi non consenta neppure manifestazioni artistiche e culturali non abbisognevoli di locali ampi - tutto quanto sia idoneo a tenere viva la memoria di chi in quella casa ebbe i natali. Insomma, pensi il comune al restauro (meglio ancora se ci pensasse un istituto di credito); la destinazione sarebbe problema da risolvere in seguito, secondo le circostanze.
Oltretutto, realizzando tale recupero, Nuoro potrebbe anche farsi così perdonare l’inqualificabile colpa di avere abbandonato all’ira funesta dei vandali di turno il monumento a Sebastiano Satta che Francesco Ciusa aveva realizzato nel 1934 e che l’Amministrazione municipale di allora eresse, come suggerito dallo stesso artista (1), nella sommità del colle di S. Onofrio.
Il bozzetto del monumento a Sebastiano Satta è andato irrimediabilmente perduto (a me, però, piace sperare che lo stesso monumento sia ricostruibile, con l’ausilio della documentazione fotografica), così come perdute sono andate le opere che Ciusa custodiva nel proprio studio-laboratorio cagliaritano, distrutto poi dai bombardamenti del 1943. Triste destino, per uno scultore non eccessivamente fecondo, vissuto in un periodo di obiettiva crisi della scultura (2), per di più in un ambiente in cui l’indigenza riduceva le capacità della pur ipotetica committenza (3).
Voglio, però, essere ancora più rigoroso. I nuoresi di allora capirono solo in parte Francesco Ciusa, così come non gli perdonarono di essere emigrato da Nuoro, dopo che vi si era ristabilito, al termine della parentesi sassarese seguita alla frequentazione dell’Accademia fiorentina. I nuoresi, apertamente, non gradivano che i loro migliori concittadini emigrassero da Nuoro: sia pure in dimensione microcosmica, Nuoro era considerata il centro dell’Universo, sicché era scarsamente apprezzato chi andava cercando il “meglio” extra moenia.
Forse questa era, inizialmente, l’idea anche di Francesco Ciusa quando, lasciata l’Accademia fiorentina, era ritornato in Sardegna in cerca di motivi ispiratori e, dopo trascorso un anno a Sassari, aveva fatto rientro appunto a Nuoro, considerata evidentemente, Terra Promessa per uno come lui che ricercava sperate fonti di ispirazione su cui fondare proponibili modelli di quell’esasperato verismo che, nel campo della scultura, aveva avuto iniziatore e vate il napoletano Achille D’Orsi. Nasce così, in quel contesto, l’idea de La madre dell’ucciso che poi, nella biennale veneziana del 1907, avrà il giusto e meritato riconoscimento.
Ma quella fonte di ispirazione si inaridisce subito dopo. E ciò per quanto con acutezza dice Rossana Bossaglia, allorché osserva che “la condizione delle arti nella Nuoro del primo Novecento non è certo entusiasmante. Ciusa non trova modelli a cui rifarsi nella ricerca di un linguaggio plastico antiaccademico e rispondente alla nuova realtà socio-culturale sarda”(4). Quella fonte di ispirazione, etichettabile appunto come vocazione al verismo, si inaridisce anche perché nel frattempo è maturata in Ciusa una tendenza diversa, a seguito della decantata assimilazione delle esperienze apprese direttamente o indirettamente negli anni fiorentini: la tendenza al simbolismo.
Il verismo non lo appaga ulteriormente nella scelta del linguaggio espressivo. Ciusa infatti ricerca un mezzo comunicativo che non è più quello verista (limitato nella potenzialità perché mira prevalentemente alla rappresentazione del fenomeno): ricerca un linguaggio che invece consenta, attraverso l’uso dell’analogia, e quindi del simbolo, di svincolare la comunicazione artistica dalle pastoie del convenzionale, per indirizzarla così verso l’essenza più recondita della realtà, verso la scoperta delle corrispondenze e dei legami tra le idee, i segni, le cose.
Un linguaggio che, pur indicato, in un contesto culturale di ampio respiro, come generica chiave di lettura dell’autentica realtà noumenica, avvolta peraltro di allettanti misteri, non poteva non apparire ai nuoresi di allora (culturalmente ancorati alla sebastiansattiana espressività verista), un qualcosa di difficile comprensione.
Figuriamoci allora, quanto poteva apparire astruso (o comunque fuori dell’apprezzato convenzionale) ai portavoce di quelle strutture che avrebbero dovuto impersonare la contrattualità di una potenziale (di fatto improbabile) committenza (5). Era insomma, per Nuoro, un linguaggio del tutto nuovo; quello stesso che, non unicamente in campo letterario (anche se, in questo, il risultato poteva apparire più evidente), si mostrava, ma solo a chi si fosse posto in posizione di avanguardia, come il più adatto a stabilire, per mezzo dell’arte, il magico punto di contatto tra la filosofia e la vita, attraverso il continuo confronto tra l’apparenza fenomenica e il dato sostanziale della realtà.
Col trasferimento di Ciusa a Cagliari (1908), avviene allora quella progressiva trasformazione del linguaggio plastico; la quale, appunto nella ristrettezza culturale nuorese di allora, non poteva purtroppo trovare spazio. Ciusa ricerca una libertà espressiva che si manifesta attraverso il ragionato, graduale abbandono del verismo e mira palesemente ad approdare a questi risultati che possono scaturire solo dall’adozione dei nuovi canoni simbolistici. Ma anche a Cagliari quel linguaggio non sembra granché capito e, comunque, apprezzato. Si continua infatti, come a Nuoro, a esaltare quanto Ciusa poteva avere tratto dal verismo di Sebastiano Satta, ossia, in pratica, ad apprezzare solo il verismo de La madre dell’ucciso; quasi fosse del tutto inesistente o insignificante l’evoluzione ch’era andata verificandosi.
Ma che radici aveva avuto il linguaggio verista?
Credo si possa dire che il verismo era nato in Ciusa come una delle tante “possibilità”, frutto di un apprendimento accademico più che di una diretta esperienza (dell’esempio del ricordato Achille D’Orsi, in ipotesi). Sicché quando egli rientra a Nuoro e intraprende la frequentazione di Sebastiano Satta (6), quella scelta trova un confortevole riscontro, tanto da apparire come la sola via da praticare.
In Satta, Ciusa trova ciò che occorre perché possa essere legittimamente reso esplicito quanto in lui già interiormente albergava in fase di larvale aspirazione: da un lato, la spinta verso la dinamica partecipazione sociale politica; ideologica, quale matrice di crescita culturale; dall’altro, l’ancoraggio alla statica tradizione sardo-barbaricina, conservatrice per vocazione (7).
La contraddizione è evidente, ma Sebastiano Satta ritiene di poterla superare quando “trasforma” le gesta dei banditi sardi “in aperta coscienza politica e sociale” (8). È una contraddizione che, comunque, non spaventa affatto Francesco Ciusa, il quale a sua volta ne ricerca il superamento nella creazione compositiva de La madre dell’ucciso, nella quale il verismo esasperato, condotto secondo l’indicazione datane appunto da Achille D’Orsi, “si avvalora di aperti spiriti socialisti” (9).
Ma nella linea evolutiva dell’arte di Francesco Ciusa questa parentesi si chiude rapidamente, perché il verismo non lo appaga più. La coscienza di dover ricercare un linguaggio svincolato dalla scontata convenzionalità lo spinge appunto verso il simbolismo. Quando, nel 1910 (dopo che il trasferimento a Cagliari è avvenuto), compone l’illustrazione grafica che ornerà la copertina dei Canti barbaricini di Sebastiano Satta, il passo è già compiuto . (10) L’ulteriore quesito concerne il perché della propensione al simbolismo.
Nell’adattamento dell’iniziale manifesto, il simbolismo poteva apparire trasferito, dalla letteratura e dal teatro alle arti figurative, come una reazione a certe teorie scientiste, una vera e propria ribellione all’imitatio naturae, volta alla ricerca di quella libertà espressiva che sembra non tener più conto neppure della capacità ricettiva dell’ipotetico fruitore dell’opera. Era, peraltro, quella stessa incomprensione che generalmente si verifica quando il gusto estetico subisce un inevitabile mutamento evolutivo.
Francesco Ciusa aderisce all’ideame manifesto della tendenza simbolista, ideologicamente collegata col decadentismo; ma purtroppo non ha in Sardegna esempi di riferimento.
Dai suoi maestri Adolfo De Carolis e Domenico Trentacoste non aveva potuto trarre, ratione temporum, esempi di quella evoluzione di tendenza che assimila simbolismo e decadentismo, per condurre poi, all’apice di un’ulteriorità talvolta negata, ai fasti, pur temporalmente effimeri, dell’Art Nouveau. Anche perché il simbolismo decadentista, nel campo delle arti figurative, non ha avuto una considerevole espansione, almeno in Italia, ove sembrerebbe essersi passati, quasi per saltum, dal verismo di Stanislao Lista, di Achille D’Orsi e di Vincenzo Gemito al “futurismo” di Medardo Rosso (transitato per l’esperienza impressionista, in reciproci scambi di influenze, con Auguste Rodin) e del bergsoniano Umberto Boccioni.
Probabilmente, però, Francesco Ciusa aveva potuto vedere qualche opera di Leonardo Bistolfi, improntata allo spiritualismo luministico di fine Ottocento, logica premessa dell’ulteriore scrittura simbolista e decadentista (11). Qualche esempio l’aveva certamente visto e meditato se, poi, giunge a quella esclusività di linguaggio simbolista che caratterizza opere quali Il bacio (12), Vibrazione di violino, Monumento ai Caduti (Iglesias), L’adolescente: opere che datano dagli inizi a oltre la metà degli anni Venti.
Il canone della poetica simbolista è da Francesco Ciusa recèpito toto corde, almeno in questa fase della creatività che lo caratterizza; ma anche il Simbolismo finisce per essere superato, poiché il suo naturale, quasi obbligato sbocco è quello dell’Art Nouveau, o Liberty che dir si voglia. Anche Ciusa approderà infine al Liberty; ma prima ancora di riscontrare quest’ultimo passaggio evolutivo vanno poste in risalto alcune caratteristiche (dell’impostazione simbolista, appunto) che aiutano, proprio, a comprendere la ragione di quel successivo passaggio e, purtroppo, dell’ingiustificato, conseguente declino di popolarità, in una Nuoro tutt’altro che aperta a certe tematiche evolutive.
Ma, si sa, nemo propheta in patria. La prima di tali caratteristiche è quella della sublimazione del vero: nelle arti figurative (e perciò anche nella scultura) all’immagine del reale si sovrappone l’immagine dell’idea del reale. E già questa è un’operazione che determina l’assottigliamento del numero dei destinatari-fruitori del messaggio, con la relativa perdita di quelli ancorati all’idea del “racconto” come sola, possibile configurazione del reale. Si verifica, insomma, almeno nel momento iniziale, una sorta di incomprensione tra il mittente e l’ipotetico destinatario del messaggio.
Ma v’è un’altra ragione, strettamente collegata alla prima e certamente non meno decisiva, che sembra avere allontanato i nuoresi (quelli di allora, s’intende, che non spesero una sola parola di condanna, quando fu fatto scempio del monumento a Sebastiano Satta) da quello stesso messaggio. Ed è, come or ora ho introduttivamente accennato, che nel canone simbolistico v’è poco o nullo spazio per il segno narrante.
Il “racconto” è un ingrediente tipico e tipizzante del verismo, in quanto privilegiato strumento di ricostruzione ed esaltazione del “vero”. Nella cultura nuorese barbaricina il racconto è il principale strumento di comunicazione, purché sia un racconto di fatti realmente accaduti, una ricostruzione di vita vissuta (13). Sicché una volta esclusa - secondo la logica dei canoni simbolistici - ogni possibilità di indulgere al racconto, ecco che quello stesso linguaggio può apparire di difficile comprensione. Salvatore Satta riuscirà, letterariamente, a conciliare elementi di inequivoco significato simbolico, qual è ad esempio l’allegoria della morte, che per una non enunciata regola del contrappasso simboleggia il valore della vita, con la cristallizzazione della durata del tempo, che in termini di filosofia bergsoniana è la coscienza della durata del presente e che si materializza nel “racconto” dell’esperienza della vita vissuta. Ma tra la cultura assimilata da Francesco Ciusa e quella vissuta da Salvatore Satta intercorrono, temporalmente, non meno di dieci lustri di differenza. È quello dell’evoluzione culturale, ai giorni d’oggi, un moto geometricamente accelerato.
Certo è che nell’evoluzione artistica della esperienza di Francesco Ciusa il racconto finisce per scomparire (14). Ritornerà in parte, ma per accenni non facilmente percepibili, in opere come Il fromboliere, del 1939 (15), oltre che nel già ricordato Monumento al Poeta Sebastiano Satta (16); ma col definitivo passaggio al Liberty ogni traccia di racconto scompare definitivamente. Ed è questa una ragione per la quale la sua arte di quella stagione creativa poté apparire, a molti dei nuoresi di allora, non facilmente leggibile.
A parte, però, queste incursioni parzialmente passatiste, è proprio negli anni Trenta che il linguaggio simbolista trova in Francesco Ciusa il punto di massima espressione. Opere come La famiglia (1930), Torso di Vittoria e Cristo deposto (entrambe del 1932), Prua di Sardegna (1934), Madonna del combattente (1936-38) non lasciano dubbi al riguardo, pur se nell’ultima di esse traspare una ritardata, residuale traccia veristica.
Gli esemplari di opere che rivelano la tendenza al Liberty, manifestatasi nell’ultima fase dell’attività creativa, sono assolutamente scarsi. Sono opere risalenti agli anni Quaranta, peraltro in palese ritardo rispetto a una cultura europea che già aveva superato quella fugace parentesi (17), da quando aveva preso a guardare al cubismo di Duchamp-Villon, Manolo, Gargallo, Laurens, Lipchitz, Archipenko, Picasso e Braque, dilagato (in Europa, appunto) anche a seguito della teorizzazione fattane da Guillaume Apollinaire. Teorizzazione accolta peraltro con molte riserve in Italia (il riferimento è fatto qui alla scultura, non già alla pittura), figuriamoci in Sardegna. E in quest’Isola appunto, assediata dal mare e allora anche dal fascismo, viveva Francesco Ciusa in una solitudine culturale nel cui ambito l’epoca del cubismo e del funzionalismo sarebbero apparse, se conosciute, come un qualcosa di avveniristico distante ancora anni luce.
Il Liberty, comunque, era in qualche modo arrivato, pur in notevole ritardo, anche in Sardegna e a Nuoro. Era, però, limitato all’architettura e agli oggetti e mobili di arredamento, ma Francesco Ciusa ne aveva ben intuito la chiave di espressività, sicché aveva potuto trasfonderlo, pur limitatamente, nel linguaggio della sua arte. Così, infatti, è rivelato dalla scultura lignea Il falconiere, del 1948.
Nel linguaggio della scultura, il Liberty è per molti versi una derivazione dal Simbolismo; non sempre, peraltro, da esso facilmente distinguibile. Direi anche che l’adesione di Francesco Ciusa al Liberty poteva ritenersi preannunciata dalla stilizzazione caratterizzante il Cristo deposto, del 1932, nonché la Medaglia dedicata a Giulio Dolcetta (l’ingegnere che tra l’altro aveva realizzato il centro urbano di Arborea), del 1933. Nel retro di questa incisione, in modo particolare, la stilizzazione lineare pare dissolversi compositivamente in armoniche volute che, appunto, sembrano anticipare la or ora rilevata predilezione verso quell’oggettistica arredamentale che, quando fuoriesce da certa stereotipata linearità, caratteristica evidente di una scontata produzione seriale, riesce il più delle volte ad attingere agli autentici valori dell’arte.
Non sappiamo, purtroppo, quali opere di ultimissima creazione siano andate perdute con la distruzione dello studio-laboratorio di Cagliari. Possiamo però supporre che il discorso in chiave Liberty non si fosse fermato a quei soli riscontri che possono, oggi, essere documentariamente portati all’evidenza.
Per concludere, vorrei solo aggiungere che il breve excurcus qui tracciato non ha certo la pretesa di esaurire una vastissima tematica, quella appunto inerente al percorso evolutivo di un artista dalla personalità complessa, qual è Francesco Ciusa. Del resto, già nelle citate opere e studi di Rossana Bossaglia, Mario Ciusa Romagna, Maria Elvira Ciusa, Antonietta Ciusa Mascolo è ben contenuto quanto possa occorrere a chi intenda approdare a ulteriori approfondimenti. E proprio alla lettura di quelle opere e studi vorrei rimandare il volenteroso lettore.
A me è sufficiente dire che, quanto ho scritto, ha la sola pretesa di ricordare a certi smemorati amministratori che un artista come Francesco Ciusa merita certamente che sia a lui innalzato un monumento lapideo (quell’altro, aere perennius, l’ha già innalzato Sebastiano Satta); e questo, almeno fino a quando un valente scultore non ritenga di proporre un valido bozzetto, non potrà essere altro che il restauro della casa natale. Che poi quest’ultima possa essere destinata a museo delle opere del nostro artista - inizialmente presenti in immagine fotografica, poi, chissà, in riedizioni bronzee e di tutto ciò che sarà possibile realizzare - è cosa quantomai auspicabile.
Quel che conta, al momento, è il primo passo.
1) Si veda, in proposito, quanto riferito da ANTONIETTA CIUSA MASCOLO, figlia dell’artista, nel saggio Francesco Ciusa, mio padre, Nuoro, Il Maestrale, 1999, pag. 132. L’originario bozzetto fu realizzato “attraverso un simbolico movimento ascensionale di linee e piani che davano un senso dinamico a tutta la libertà di una mente creativa”. Ma l’indigenza dell’Amministrazione municipale (di allora) comportò una realizzazione del monumento soltanto parziale, consistita nell’innalzamento della “sola parte centrale di esso”. Una foto dell’originario bozzetto (versione integrale) è riprodotta a pag. 131 dell’opera citata; mentre la foto del monumento poi eretto effettivamente nel colle di S. Onofrio è riprodotta tanto nella successiva pag. 146, quanto nell’inserto fotografico (foto n. 84) dell’opera di ROSSANA BOSSAGLIA, MARIO CIUSA ROMAGNA, MARIA ELVIRA CIUSA, Francesco Ciusa, Nuoro, Ilisso, 1990. In quest’ultima opera sono fotograficamente riprodotti anche alcuni significativi “particolari” dell’originario bozzetto (foto da 76 a 85).
2) Quella stessa generale crisi del messaggio artistico scultoreo che nel 1945 (quattro anni prima della morte di Francesco Ciusa) aveva ispirato ad ARTURO MARTINI il saggio Scultura lingua morta (riedito nel 1983 con analogo titolo da Jaca Book). Per quanto possa valere, un’interpretazione della querelle di Martini, sostanzialmente tendente, comunque, al “recupero” di un mezzo espressivo artisticamente sempre valido, ho cercato di dare nel mio Filosofia estetica e critica dell’arte, Rho, Gruppo Edicom, 1998, pag. 219 s. Può, peraltro, essere utile ricordare quanto, di Arturo Martini, ha scritto GIULIO CARLO ARGAN, in Il primo Novecento - L’arte moderna, Firenze Sansoni, 2001, pag. 140: “Martini sarebbe stato uno dei più grandi scultori moderni se non avesse ceduto alla mediocrità morale della cultura del tempo, paurosa di tutto ciò che faceva problema ed esigeva una riflessione critica”. Di quella stessa crisi (della crisi, cioè che investiva tutta la cultura italiana e si ripercuoteva ancor più in Sardegna) fu indubbiamente vittima anche Francesco Ciusa.
3) Significativa, in proposito, la lettera di Grazia Deledda al marito (del 5 agosto 1906), nella quale, dopo aver informato che il pittore Ballero “ha cose molto belle, ma disgraziatamente non vende nulla”, aggiungeva che in situazione analoga versava Francesco Ciusa. Se mi fosse consentita un’ ulteriore autocitazione, ricorderei che un’osservazione parimenti sconsolante avevo fatto a suo tempo (nel mio Corso Garibaldi, Nuoro, Il Maestrale, 1994, pag. 157 s.) per quanto riguardava le non floride condizioni del pur dignitosissimo Pittore autodidatta, il nuorese Francesco Congiu Pes (un “morto di fame”, lo qualificherà più tardi Salvatore Satta ne Il giorno del giudizio). Avevo in quell’occasione osservato che “il mecenatismo non era a Nuoro una moneta corrente”.
4) Op. cit., pag. 28.
5) Il linguaggio poetico simbolistico viene, pur timidamente, recepito da Grazia Deledda. Un esempio è in Cenere, del quale romanzo ROSSANA BOSSAGLIA (op. cit., pag. 14) rileva, appunto, gli “accentuati tratti simbolisti”. Non distante da tale conclusione è VITTORIO SPINAZZOLA che, nell’Introduzione a Cenere (in edizione Mondadori, 1961-73, pag. XV), sottolinea “l’appartenenza all’area culturale del decadentismo novecentesco”. Decadentismo e Simbolismo sono infatti, se mi si passa l’espressione, le due facce di quell’unica medaglia che a fin de siecle nasce dall’anticonformistica ribellione alle regole convenzionali della letteratura e dell’arte, grosso modo facente capo al proselitismo iniziatico della rivista Le Décadent, nonché all’opera poetica di Beaudelaire e di Mallarmé, seguite dagli apporti di Rimbaud e Verlaine, fino a estendersi all’intera Europa. Vale peraltro osservare, per quanto attiene alla Deledda, la discorde voce (non meno autorevole, tuttavia) di CARMELO CAPPUCCIO (Storia della letteratura italiana, Firenze, Sansoni, 1977, pag. 659), il quale insiste nella tesi che la Deledda, “aderente alla tecnica oggettiva del verismo”, vanamente sembrerebbe “volersi sollevare a significati e valori universali”, poiché finisce per restare pur sempre ancorata “alla rievocazione del suo ambiente regionale, visto in un alone favoloso di vita rude e primitiva”. Ma nell’opera postuma Parlare di sé (Firenze, SISMEL, 2002, pag. 107), lo stesso AUTORE sembra in parte ricredersi, perché all’enunciazione che la narrativa della Deledda “sembra riallacciarsi ai veristi e ai provinciali dell’Ottocento” fa seguire l’acuta osservazione che il senso di fatalità caratterizzante la stessa narrativa “avvicina l’opera della Deledda ai temi essenziali della letteratura europea che domineranno nei decenni successivi”. E i temi essenziali sono quelli che lo stesso Cappuccio (nell’opera per prima citata) aveva indicato come caratteristici e peculiari di un’”epoca in cui ormai al realismo si sostituivano correnti mistiche, simboliste e idealiste, e una più complessa ricerca psicologica”.
6) Sul rapporto di amicizia e affinità culturale tra Francesco Ciusa e Sebastiano Satta si veda ANTONIETTA CIUSA MASCOLO, op. cit., pag. 82.
7) Su questa tematica si veda GIOVANNI PIRODDA, Prefazione ai Canti di Sebastiano Satta, Nuoro, Ilisso, 1996, pag. 17 s.
8) Cfr. MARIO CIUSA ROMAGNA, Prefazione ai Canti di Sebastiano Satta, Milano, Mondadori, 1980 (4^ ed.), pag. 30.
9) Così FORTUNATO BELLONZI, Architettura, pittura, scultura dal Neoclassicismo al Liberty, Roma, Quasar, 1979, pag. 143.
10) Vedila in ROSSANA BOSSAGLIA, Francesco Ciusa, cit., pag. 14.
11) È forse il caso di sottolineare, per evitare equivoci, che il Decadentismo, quale tendenza (se non scuola) artistico-letteraria, non ha nell’attuale definizione quell’originario quid di negativo; non lo ha oggi, dopo la stratificazione storica che ha relegato in secondo piano, almeno nell’odierna cultura letteraria italiana, quella sostanziale deminutio che, certamente da noi, aveva tratto spunto da un generico, accomunante giudizio non del tutto positivo espresso dai portavoce della cultura idealista, poco propensa ad accettare il nuovo, meno magnificante rapporto dell’uomo con la realtà universale (cfr. E. GUIDETTI, a cura di, Il decadentismo, Roma, Ed. Riuniti, 1976, passim, nonché C. CAPPUCCIO, Storia della letteratura italiana, cit., pag. 705 s.).
12) Nella citata opera Francesco Ciusa (di ROSSANA BOSSAGLIA, MARIO CIUSA ROMAGNA e MARIA ELVIRA CIUSA), nella didascalia relativa alla raffigurazione fotografica de Il bacio si parla espressamente di una delle opere di Francesco Ciusa “più vicina alla lezione di Bistolfi”. Come riferimento specifico, indicherei, di Bistolfi, Il sogno, del 1901 (nel Cimitero Monumentale di Milano), nonché il Monumento a Segantini, del 1906 (un’edizione del quale è nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna, a Roma).
13) Un’illuminante teorizzazione, in proposito, l’ha fatta RAFFAELE PIRODDI nel romanzo Il paese dei “Contos”, nel quale la vis comunicativa del racconto (il riferimento specifico è fatto all’etnia barbaricina dorgalese, del tutto simile, però, a quella nuorese) è basata su due presupposti: l’ancoraggio a un preciso contesto locale; l’inequivoca riferibilità a personaggi reali e conosciuti (“… le storie di personaggi generici e irreali, come quelli delle barzellette, avrebbe lasciato tutti più o meno indifferenti”: Cap. II). Questa stessa teorizzazione Raffaele Piroddi ha, con pari efficacia, espresso anche nel “testo” del “Libro fotografico La mia Sardegna, realizzato (nel 1996) in collaborazione con ANGELO MEREU. Un probante esempio dell’importanza, anche letteraria, del “racconto” nella cultura nuorese è offerto dal meritato successo dell’opera dialettale di Giovanni Maria Canu che, con lo pseudonimo di Ziu Mimiu Canu ha dato alle stampe (anche se solo per diffonderlo tra i suoi amici e, perciò, fuori commercio) un simpatico florilegio di originali storie vere dal titolo Zente nugoresa - Birtudes, brullas e issollorios (Gente nuorese, Pregi, difetti, scherzi e facezie). Le storie sono raccontate in purissima lingua sarda (dialetto nuorese) e si segnalano, proprio, perché da esse traspare l’importanza che nella cultura nuorese riveste il racconto finalizzato alla valorizzazione della memoria. Nella Presentazione, Costantino Congeddu, con lo pseudonimo di Cincinu (il quale Congeddu è, peraltro, autore di un’ottima traduzione in sardo-nuorese del Il giorno del giudizio di Salvatore Satta: lavoro che, per quanto ne so, attende ancora di essere pubblicato), enuncia la “filosofia” di quei racconti. Ne riporto un significativo brano, traducendolo letteralmente: “A noi che leggiamo pare di vedere quei personaggi, molti li abbiamo addirittura conosciuti, e di vederli in circostanze così vive e vere che ci coinvolgono come se stessimo vivendole ancor oggi”.
14) In chiave di figuratività scultorea il “racconto” è quello che, in termini più significativi (e, forse, più appropriati) si identifica con la imitatio naturae. L’imitatio che i nuoresi avevano certamente apprezzato ne La madre dell’ucciso, perché vedevano in essa un racconto di vita barbaricina che rievocava quella stessa antichità nuragica racchiusa nel bronzetto nuragico divenuto di diffusa conoscenza proprio a causa della evidente similitudine. Rievoca in proposito MARIO CIUSA ROMAGNA, nell’Introduzione ai sebastiansattiani Canti in lode di Francesco Ciusa (nei Canti, cit.), “una grande rispondenza non solo nella forma, ma anche nella sostanza, come se l’antico anonimo scultore ed il Ciusa fossero i due capi d’uno stesso filo storico”.
15) Il fromboliere fu ideato (e probabilmente anche modellato nella versione definitiva) a Orgosolo, ove Francesco Ciusa si era trasferito (dopo che già aveva spostato da Cagliari a Oristano la propria residenza) in cerca di una specifica ispirazione. Collocherei quell’opera nel periodo “simbolista”; ma la specifica fonte di ispirazione lo aveva per forza di cose indotto a un’ulteriore ricerca del racconto di quella realtà barbaricina materializzata, quindi, nella fierezza e nell’atteggiamento di gran dispitto (visibili ictu oculi nell’accentuata grinta del tratto fisionomico); nell’espressione del volto di un David che si accinge all’impari lotta senza timori di sorta e con ferrea volontà di vincere. Il misto di allegoria e di verismo, comunque, non diminuisce, anzi esalta, la validità di un messaggio artistico che si discosta palesemente da qualunque altro, ipoteticamente improntato ai canoni dell’arte fine a se stessa.
16) Nel Monumento al Poeta Sebastiano Satta, pur d’impronta marcatamente simbolista, è tuttavia palese l’omaggio al verismo sebastiansattiano, reso evidente dalla scelta degli stessi soggetti che si ritrovano nelle liriche Ortobene, La greggia, Cani da battaglia, Murrazzanu.
17) Nel campo della scultura, lo stile Liberty non è agevolmente definibile, se non in negativo, come opposizione ai residui di quell’eccletismo neorinascimentale e neobarocco che aveva, comunque, influenzato la compostezza creativa delle opere di fine Ottocento, incluse quelle improntate a un simbolismo di transizione, ancora influenzato dai residui di validità del canone verista. In positivo, comunque, un’identificazione può essere fatta con riguardo all’insistita sinuosità delle linee, allusivamente ispirate a motivi floreali o, comunque, a un’asimmetrica bidimensionalità, neppure sempre conciliabile (a parte i casi del bassorilievo) con la tradizionale figuratività del tridimensionalismo scultoreo.