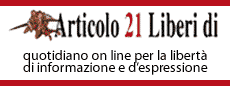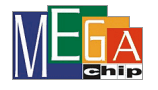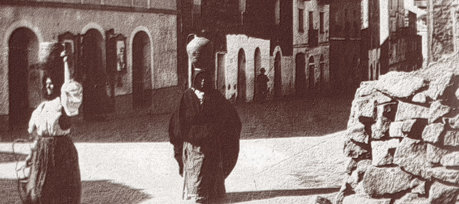Dieci, quindici, vent’anni fa era impensabile che un manicomio potesse essere distrutto.
Magari i manicomi torneranno ad essere chiusi e più chiusi di prima, io non lo so, ma a ogni modo noi abbiamo dimostrato che si può assistere la persona folle in un altro modo”.
Questa frase, sintesi estrema delle ragioni di una ideologia e di una pratica straordinarie è posta ad epigrafe del volume “Conferenze brasiliane” di Franco Basaglia, curato da Franca Ongaro Basaglia e da Maria Grazia Giannichedda, edito da Raffaello Cortina qualche anno fa, documento di straordinaria importanza sia perché è stata una delle ultime riflessioni pubbliche (Basaglia muore nel 1980), sia perché rappresenta quasi il suo testamento intellettuale (il momento di leggerlo o rileggerlo mi sembra assolutamente tempestivo perché illuminante rispetto al dibattito in corso in questo periodo, e, come si evince dall’epigrafe, quasi profetico). “Mai più manicomi e camicie di forza” è stata, infatti, la parola d’ordine che il 13 maggio scorso, esattamente 25 anni dopo la promulgazione della legge Basaglia ( 13 maggio 1978 ), ha percorso la manifestazione promossa dalla Funzione Pubblica Cgil per festeggiare il venticinquesimo anno dalla fine dell’internamento nei manicomi dei malati di mente e per fugare ogni tentativo di ripristino della logica della segregazione e dei manicomi come luoghi di emarginazione sociale e repressione dove il malato perde la sua essenza di cittadino e di soggetto di diritto.
Le camicie di forza certo non sono più contemplate come mezzo di contenzione, ma se le proposte di legge di abrogazione della 180 dovessero passare, rischiano di ritornare sotto forma di altri mezzi di contenzione che, se non sono le camicie di forza (politicamente poco corrette per la nostra società così ipocritamente attenta alla forma delle cose e così poco attenta al sentire delle persone vere) , sono però comunque meccanismi di esclusione sociale ( forse non destinati solo ai malati psichiatrici, ma allargati magari anche agli anziani non autonomi, ai disabili privi di sostegno, ai tossicodipendenti etc...) in strutture che, anziché rinforzare la capacità di riconoscersi, superare le debolezze ed i limiti, riabilitare insomma alla vita, allontanano, nascondono, tolgono il diritto alla parola e alle relazioni.
Forse, prima di legittimare nuovamente l’apertura (pardon la chiusura) dei manicomi, con la giustificazione del fallimento della organizzazione della 180 e della considerazione utopica della cultura della convivenza tra “normali” e “diversi”, sarebbe meglio leggere qualche libro in più e sull’importanza della relazione e della comunicazione tra medico e paziente e sulle storie di chi soffre, di chi si sente lontano da sé e dal mondo.
Ho già citato, l’umanissimo ed interessantissimo saggio di Basaglia, che, in modo coinvolgente e convincente, insiste “sulla logica del cambiamento” più che sulle tecniche del cambiamento”, intendendo con ciò sottolineare la necessità di affiancare al cambiamento delle strutture sociali anche la pratica individuale che deve tendere a superare i rapporti di oppressione con l’accettazione del vivere la contraddizione e il conflitto.
Un’altra lettura interessante ed altrettanto illuminante dei luoghi della sofferenza psichica potrebbe essere il libro di Nereide Rudas (fondatrice della Clinica Psichiatrica dell’Università di Cagliari) “Storie senza”, edito da Carocci nel settembre del 2001.
Che cosa mancasse a queste storie perché l’autrice le definisse “senza”, non saprei dire, a me hanno emozionato molto e sono sembrate in verità storie di forti presenze.
Forti sono, infatti, tutte le narrazioni e con esse le protagoniste e i protagonisti: Donna Cleto con il suo romanzo familiare nutrito dalla “grande bugia” genealogica e dall’ossessiva ricerca che la sostiene, la Principessa collezionista “poetessa dei resti” “collezionista a rovescio” che si aggira con il suo sacco dal contenuto sconosciuto, luogo poetico di realizzazione della fantasia e del desiderio; Suor Silente suora di clausura, semplicemente dimenticata in Manicomio e caparbiamente orientata a riconquistare lo spazio claustrale spettantele; la pianista Aristea tutta compresa nelle combinazioni armoniche degli accordi, possibili però soltanto con il supporto del suo precettore Gilbert, la cui partenza decreterà l’inizio del declino delle facoltà di dominio razionale della vita ed il passaggio all’alienazione dominata da astrusi calcoli sul tempo trascorso insieme al presunto amante, colui che aveva dato senso all’esistere, ed il cui conteggio dà ora senso al tempo presente; ed altre ancora.
Le storie continuano nell’universo popolato da altri personaggi nei quali la realtà e il desiderio, l’immaginazione e l’accadere, la verità e la simulazione, la logica e la fantasia hanno confini poco demarcati, determinano un vivere sospeso, per alcuni aspetti poetico, talvolta tragico, altre terribilmente impenetrabile, come ad esempio nel caso della silenziosa Innocente con il suo mondo popolato da bambini immaginari, dalla pantofola nera da cui non si separa mai, il ripetitivo gioco matematico dei fiammiferi che diventerà poi, per profetica intuizione, gioco tragico di morte.
Il confine tra normalità ed anormalità si fa ancora più sottile nella storia della malata di diagnosi, il rapporto tra medico e paziente indefinito ed incompiuto come nel frammento di Giovanni D, l’intreccio tra pubblico e privato strettissimo come nel racconto del rapporto di Denise e Zlata, la possibilità di integrazione nel rispetto del sentire differente tragicamente lontano nella storia di Drim, “che non era il nome di un campanello, né di un ombrello a scatto, ma quello d’un uomo che dormiva e sognava in un giardino” (definizione assolutamente perfetta nella sua sintesi poetica e simbolica) e l’amore per l’umanità intera dissolto definitivamente nel fumo dei camini di Auschwitz, come si intuisce dalla toccante lettura della lettera dell’ebrea internata. Storia a sé è invece quella di Lucente, sia nella forma del racconto, quasi teatrale (un interrogatorio del Giudice ai diversi testimoni per la ricostruzione dei fatti), sia per la lunghezza stessa (è il più lungo di tutti), sia infine per l’argomento, il rifiuto della maternità, tema così tabù nella nostra società incapace di affrontare i temi più profondi, i suoi buchi neri, il paese oscuro dell’anima. Il tema della maternità o del rapporto madre-figlia, sono tematiche che ritornano sotto diverse forme in tutto il libro, ma se in Lucente la relazione di maternità o meglio di dismaternità (questo è il titolo del racconto) genera quasi orrore in chi abbia l’incapacità a confrontarsi con i grovigli dell’inconscio, nelle figure di Diadora e Basilia, accudenti e materne tate, invece si ritrova compensato quel bisogno di nutrimento affettivo che è espresso nel dono totale di sé fino all’annullamento e alla morte, quando la protagonista, Basilia, reputi cessato il tempo della cura. Bellissimo al proposito quanto si chiede la voce narrante, Nereide Rudas, alla fine del racconto: “Ci sarà per quelli che nasceranno dopo di noi un cielo materno più vicino? Ci sarà una terra senza le dolci tate che vanno a morire?”
Tutte queste vicende, questi personaggi, queste patologie, ruotano intorno alle difficoltà di costruzione delle relazioni, familiari o amorose, quasi a ricordarci quale sia l’unico vero segno di definizione dell’umano e attraverso che cosa può passare il suo recupero se si sia perso.
Le storie di quel variegato popolo di personaggi reali e fantastici (“poeti del residuo” li chiama l’autrice dimostrando sensibilità umana e poetica) sembrano rispondere ad un bisogno profondamente sentito di restituire dignità di esistenza a persone che il mondo tende a dimenticare, ad una necessità di dare voce a chi non sa farla sentire, ad una sensibilità che vive la pratica medica non solo con professionalità e competenza ma con l’umanità che mai dovrebbe passare in secondo piano.
La soglia tra normalità e anormalità, così difficile da tracciare e persino a volte da individuare, indica per ciascuno il luogo, o il non-luogo, d’affermazione della propria unicità e diversità, della meticolosa ricerca d’eccezionalità per sfidare l’insignificanza, il non senso ad esserci.
Il tormento esasperato di queste anime, la disarmonia con se stessi e con il mondo, il precario equilibrio tra immaginazione e vita quotidiana, l’inganno dell’amore e della vita non sono, però, solo un problema dei protagonisti di questi o di altri racconti, ma forse appartengono un po’ a tutti noi. Allora, probabilmente, piuttosto che chiamarci fuori dalla responsabilità di quanto accade a singole persone o ad interi popoli o risolvere i problemi soffocandoli, allontanandoli e chiudendoli in luoghi poco visibili affinché non ci disturbino neanche, è meglio porci interrogativi su cui meditare, gestire le crisi che le difficoltà presentano, avere un atteggiamento etico di comprensione, leggere i mondi “altri” dal nostro con ospitalità intellettuale ed affettiva.
La salute psicologica, fisica, o in qualsiasi altra accezione si voglia leggere il termine, è anche questo o forse è soprattutto questo.