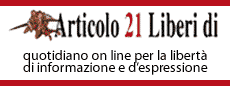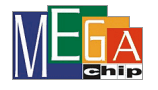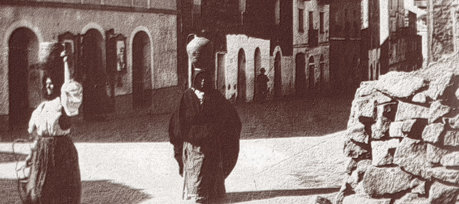Quante città utopiche sono state immaginate in letteratura, filosofia, cinema, pittura, e quante città reali, nel corso dei secoli, sono state progettate e realizzate da professionisti dell'architettura, dell'Urbanistica, dell'ambiente, tutte, razionali e funzionali, monumentali e contorte, naturali e comunitarie, meravigliose o degradate per l'incuria, rappresentano la storia di quel luogo specifico, consentono di delinearne la fisiognomica storica, di scoprire cioè i lineamenti della storia passata attraverso le particolarità architettoniche e ornamentali, di seguire i passaggi e le stratificazioni culturali, ci permettono insomma di leggerlo e capirlo attraverso quelle tracce che per Benjamin rappresentavano " il cristallo dell'accadere totale" e per Bloch i "geroglifici" di una intera epoca.
Quanto dibattito artistico e politico negli anni '60\70 intorno all'utopismo delle città in cammino, alla trasformazione degli edifici in paesaggi e degli spazi in misure flessibili e sobrie, intorno all'Urbanistica ed all'architettura interpreti delle possibilità espressive e poetiche del vivere in armonia con gli altri e con il mondo! Tutte utopie, è vero! Altre logiche hanno prevalso e sembrano ancora voler imporsi, ma a noi, oggi, spetta la responsabilità di accettare o cambiare!
La rappresentazione della città è come un sottile filo di narrazione che si può spezzare o rinsaldare: può restituire il senso dell'abitare e del vivere attraverso una vera e propria operazione culturale, un nuovo disegno ed una nuova composizione di rapporti, ritmi, colori, ombre e luci, oppure essere ancora una volta un'occasione persa per la comunità attuale, ma anche per quelle future.
È necessario saper individuare la percezione soggettiva del luogo e insieme l'identità, la sua natura profonda, quel " genius loci" che, come sottolineava sempre professor Maltese nelle sue affascinanti lezioni all'università, è indipendente dal cambiamento posteriore, è l'anima stessa del luogo, frutto contemporaneamente di presenze stratificate e di assenze. La riconoscibilità di un luogo sta nella capacità di renderlo universale ed eterno.
Ciò avviene se si è abili nel tradurre il linguaggio momentaneo del progetto e della creazione di quel luogo in dialettica tra passato, presente e futuro, tra artefici e pubblico.
Tutto ciò che si presenta agli occhi e all'anima, come pure tutto ciò che è assente, deve diventare modello di un nuovo racconto che, sia nelle sue vecchie contraddizioni sia nelle nuove ipotesi costruttive del vivere, minimalista o virtuosista nella qualità progettuale, deve farsi indispensabilmente interprete dell'umano, deve essere capace di tessere il filo della memoria in armonia con il recupero del passato, la razionalizzazione del degradato, la salvaguardia dell'ambiente naturale, il rispetto dello storico anche minimo, per costruire una nuova forma narrativa per un futuro non solo possibile, ma amichevole, ospitale ed ecocompatibile.
È chiaro che non è semplice coniugare le necessità impellenti di sopravvivenza con i bisogni di crescita e soddisfazione culturale, le esigenze di un vivere più "umano" secondo i cicli biologici e naturali, con quelle reali quotidiane e lavorative misurate ed attuate su ritmi assolutamente artificiali, ed è ancora più difficile trovare possibili corrispondenze, nodi d'intreccio, tra il modo di produrre dell'ecosistema equilibrato e non inquinante, con l'ambiente di produzione artificiale creato dall'uomo, finora eco-distruttivo, e, infine fondere tutto ciò in una visione armonica della città. In ciò sta proprio la sfida, ed è una sfida di quelle che non possono assolutamente essere perse.
Avranno Nuoro e i suoi abitanti l'opportunità di vedere interpretati i loro desideri e le loro aspirazioni? Di poter vivere, cioè, in una città non solo capace di dare forma alle occasioni, di individuare e cogliere le possibilità di sviluppo e rafforzamento in rapporto al territorio, per essere accogliente ed impedire quindi ai propri figli di emigrare, in una città cioè, che, nel rispetto della propria identità, della sua fisionomia tipica, sia anche dinamica ed aperta al nuovo?
Ancora, avranno la possibilità di vivere in una città di cui persino andare orgogliosi: bella nei colori e nelle forme, armoniosa nelle geometrie e nei volumi, tutti orchestrati in una melodia per lo sguardo, educante per i riferimenti colti alla tradizione, alla storia, al contesto naturale, riconosciuta e riconoscibile? Utopie? Certo, ma senza il coraggio di osare e sognare, l'orizzonte prospettico è asfittico, non esiste futuro per nessuno.
È consequenziale allora cercare altri orizzonti! Agli estensori del piano urbanistico e a chi politicamente si assume le responsabilità dell'accoglimento, spetta, è evidente, il non facile ma storico compito, da una parte di capire, conoscere, saper leggere e decodificare i segni del luogo, costruendo un mosaico interpretativo dal disegno leggibile e condiviso, dall'altra di sapere anche avere visioni, tracciare scenari, elaborare modelli intellettuali e culturali nuovi che ci facciano uscire dal provincialismo.
Spetta soprattutto, però, il dovere di ricordare che la città appartiene ad ognuno di noi, ma anche a chi ci ha preceduto e a chi ci seguirà. Pochi atti hanno, infatti, maggior valenza politica, sociale e culturale dell'organizzazione di un luogo del vivere.
Auguri!