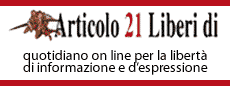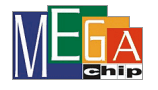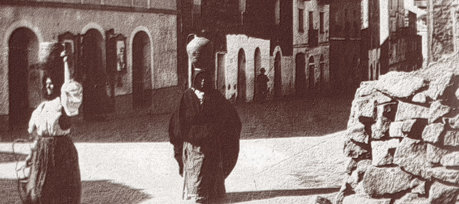Fu probabilmente zio Raffaele ad insinuare nella mente del ragazzo l'idea di emigrare, abbandonare quelle terre impervie e quel mestiere "sciagurato": "Così il seminatore che si vede rovinato abbandona il solco, vende la coppia dei buoi, lancia via il giubbotto di orbace, s'infagotta in una casacca di stoffa rude e se ne va alle miniere dell'iglesiente a lavorare entro pozzi e gallerie e qualcuno varca il mare e s'avventura perfino nell'Africa." Così dopo aver svolto il lavoro di servo pastore, nel 1896 all'età di 14 anni, quell'idea prese corpo e si fece proposito. Partì per Iglesias e lì lavorò come garzone di cantina, e più tardi andò in miniera. Fare il garzone significava lavorare di più, però era un lavoro che stancava meno.
La sera leggeva, leggeva di tutto e studiava pazzamente. Iniziò qui la sua raccolta di libri, di riviste, di giornali; libri, antologie e raccolte di passi dei "migliori" autori della letteratura del periodo: Satta, Carducci, Pascoli, D'Annunzio, Guerrini (in arte Lorenzo Stecchetti).
Letture spesso frettolose per la bramosia e la sete di sapere. Ad Iglesias visse alcuni anni, dal 1896 al 1902; fu non breve esperienza che tuttavia non lasciò traccia di rilievo nella sua opera. Passò quindi alle dipendenze di un'impresa di Livorno che importava legname dall'Africa, la ditta Lumbroso, e fu mandato in Tunisia, come rappresentante, procuratore e amministratore all'età di vent'anni: "Lasciai i monti di Fonni e Nuoro mia... Il mar varcai di notte. Alla mattina: apparì lungi, di una benda chiara ricoperta, la costa saracina". Andò in Africa nel 1902 e vi rimase fino al 1939 (trentasette anni!). La vista del mondo nuovo lo sedusse subito. Venne a contatto con l'ambiente arabo in una maniera impressionante, quasi "miracolosa".
Di quella stirpe assunse costumi, linguaggi, credenze, modi di vita; ne ricevette pene, aspirazioni, tormenti. Viaggiava continuamente, per città e per villaggi; conobbe popoli, usi e costumi diversi, li studiò con amore e ne assimilò la cultura al punto di essere considerato e trattato dagli arabi come uno di loro. Studiava molto ed alle "buone" letture dedicava non poche delle ore che riusciva a strappare al suo quotidiano lavoro. Con lo studio, da autodidatta, raggiunse una buona cultura, col lavoro una solida posizione economica.
Parlava e scriveva correttamente diverse lingue ed era informato sui più importanti avvenimenti letterari. In terra maghrebina comincia inoltre la sua produzione in prosa e in versi: I RACCONTI DEL GORBINO, editi da La Fiorita di Teramo nel 1909; le VEGLIE BEDUINE, raccolta di poesie con prefazione della poetessa Magalì Boisnard, edite ad Ancona dai fratelli Puccini nel 1912; le GALOPPATE NELL'ISLAM, tredici lunghi racconti di sapore africano, dell'editore luigi Alfieri di Milano, e il romanzo inedito MUNI ROSA DEL SUF.
Francesco CUCCA fu un uomo libero. In lui vi fu una continua, irresistibile quasi ossessionante voglia di libertà; una libertà totale per la quale e in virtù della quale egli modellò coerentemente un'intera esistenza. Un'aspirazione che del poeta stesso ne ha costituito la più importante ragion d'essere, la sua più squisita aspirazione di vita ma nello stesso tempo ne ha incarnato brillantemente l'eterna condizione di precarietà e di alterna vicissitudine. Aderì al socialismo rivoluzionario, o più profondamente all'anarchismo e a tutta un'ideologia che promuovesse idealisticamente e socialmente i diseredati e gli oppressi. Anticlericale, anticolonialista, antinterventista, preferì vivere da uomo libero: "Ancor bimbo esulò e navigò per mari battuti da corsari, e per deserti errò". La dicotomia, il conflitto lacerante, che abbiamo sentito nello spirito di Francesco Cucca, anche attraverso il reticolo della sua poesia, è stato proprio nient'altro che l'irridimediabile dualismo tra la tendenza a tuffarsi in un mondo nuovo che consente di liberarsi dai legami in cui costringono le origini, e la pulsione, invece, ad accettare i valori del gruppo sociale di appartenenza. E la sua maestria è stata forse nell'essere più volte riuscito a far vivere il tutto (mondo nuovo e cultura d'appartenenza) entro un rapporto di straordinaria simbiosi, compenetrazione, affinità; entro un rapporto di "magico" equilibrio. E tutto ciò senza complessi di sorta, senza atteggiamenti di subalternità o becero provincialismo, da uomo davvero libero, profondamente orgoglioso della sua sardità. II suo atto, sebbene collocabile (anche considerata l'età) tutto all'interno di un processo di innegabile emancipazione dal bisogno, fu tuttavia, e per la sua carica di rottura e per il suo comunque alto grado di consapevolezza, un atto di liberazione. Certo, probabilmente non del tutto compiuto, ma certamente diverso e originale rispetto per esempio ad altre esperienze, se vogliamo, di fuga "intellettuale" (Deledda e Deffenu per tutti). La sua originalità sta nell'essere stato in terra d'Africa.
Non la Roma umbertina; non la Pisa o la Livorno anarchico- intellettualistica; non la Milano dell'industrialismo nascente. Ma l'Africa maghrebina, quella povera, sfruttata, sottomessa, colonizzata, subalterna. Ma anche l'Africa esotica, islamica, certamente diversa dagli standard culturali tendenzialmente omogenei a quelli nazionali. Tutto si potrà dire a Francesco Cucca, non certo però che egli aderì a modelli, stili di vita, atteggiamenti mentali urbani e nazionali. Questo è il punto; e non c'è retorica, non c'è moralismo. II processo di differenziazione, rispetto a chi per esempio ricercò omologanti standard culturali, si volge tutto sul terreno ideologico e culturale. Non il salotto dannunziano, scintillante e raffinato, ma la povertà e la miseria del gorbino. E nonostante tutto seppe capire e dialogare anche di quella realtà "moderna, nazionale, italiana". Qui sta il suo cosmolpolitismo, il suo sentirsi coll'amico Sisto "cittadino del mondo" senza etnocentrismi o relativismi di sorta. Per il grosso pubblico Francesco Cucca rimane un "illustre sconosciuto". La storiografia letteraria lo ha etichettato e da lì non ha concesso che uno spazio esiguo; della sua opera non ci sono state riedizioni ed egli non ha avuto neanche il pregio di conservarsi per quello che nel linguaggio letterario si definisce "minore". Eppure nella sua esistenza il nostro godette una discretta fortuna, una gloria e attestazioni certamente lusinghiere. La sua presenza in differenti riviste d'avanguardia politica, in quotidiani e eddomedari testimonia una compattezza ideologica e il momento concreto di una coerente aspirazione a discutere, a promuovere movimento. eppure esistevano e rimangono ampissime tracce per ricostruire una trama biografica sufficientemente spessa: le vicende personali, cui egli stesso, volentieri e sovente, accenna; il voluminoso carteggio con personaggi, allora, molto conosciuti: il principale con Sebastiano Satta, poi via via quello con i fratelli Deffenu, con Grazia Deledda, con Giuseppe Lipparini, con Mario Puccini, con Ezio Bartalini, con tutto il movimento anarchico e socialista italiano negli anni dal 1906 in poi; la collaborazione a numerose riviste e giornali. Ma di tutto questo quel che rimane è solo la citazione indiretta, quasi a straforo, nelle biografie dei menzionati con la frase "l'amico Francesco Cucca, il poeta sardo arabo..." dimenticando tutto quanto era dietro, e cioè la grandissima umanità del personaggio, la sua opera di sostegno non solo morale ma anche tangibile di mecenate senza fondo, che elargiva in cambio di cambiali in bianco, retaggio di un'infanzia difficile. Cambiali spesso rimaste senza ritorno.
Vien da chiedersi quali fossero i limiti di un tale personaggio, e ancor più la domanda s'impone nel momento in cui si dovrà ricordarlo, non per una "celebrazione" che abbia lo spazio di una giornata, ma per valutare liberi da condizionamenti la figura di un intellettuale sardo intorno al quale è caduto il silenzio.