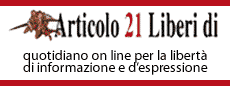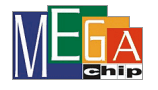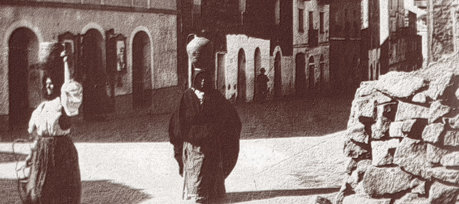Prima di allora avevo sempre pensato che le antiche costruzioni conservassero intatto il loro fascino solo se venivano lasciate nello stato di origine, in abbandono.Poi, una più attenta osservazione della realtà mi ha suggerito che senza un'adeguata manutenzione, o un radicale restauro, anche il racconto lapideo finisce per interrompersi.Ignominiosamente.
Ne scrissi, dopo quindici anni, su L'Unione Sarda(1), sperando che l'argomento non cadesse nel vuoto.Ma così non fu.
Voglio scriverne ancora, dopo altri quattordici anni, con la rinnovata speranza che qualcuno possa ancora interessarsi responsabilmente al problema.
L'originaria costruzione, come peraltro reso evidente dalla tipologia costruttiva, risale al XVII secolo. Sorse come convento dei frati Osservanti Minori, con l'annesso campo cimiteriale (tanca 'e prades); per divenire in seguito, dopo il rivolgimento napoleonico e, successivamente, dopo l'avvento dello Stato Unitario, di volta in volta carcere, ospedale, teatro, seggio elettorale, caserma, scuola(2). Il parziale rifacimento, quello relativo alla "facciata" verso la Piazza Mameli, risale presumibilmente (data la tipologia) agli anni Trenta del secolo scorso.
La "fama" dell'edificio, però, più che alla storia documentaria resta affidata alla letteratura; il che non deve meravigliare, trattandosi dell'unico (per decenni) edificio scolastico nel quale erano transitati, oltre gli anonimi ragazzi nuoresi, anche le celebrità (piuttosto rare) venute da fuori. Aveva, ad esempio, frequentato quelle scuole Indro Montanelli, come scolaro, nonché Attilio Momigliano, come insegnante (oltre le scuole elementari, infatti, vi erano anche alcune classi delle "normali"). Si aveva, inoltre, ricordo anche di un tal professore Maliandi che, pare, l'italiano lo sapesse insegnare; e, altresì, del professore di educazione fisica Luigi Laria, ben conosciuto personaggio nuorese.
Può essermi sfuggito, ma non ho affatto memoria di un'iconografia dell'edificio che sia anteriore all'illustrazione fattane da Francesco Congiu Pes(3) per il racconto di Menotti Gallisay Frate Sole e i sette fratelli(4).Nel quale racconto l'"ex convento" è descritto come luogo nelle cui "tane (...) il Comune di Nuoro aveva confinato la scuola elementare, condannando così e come nulla un migliaio di bambini a marcire là dentro".
Nel suggestivo racconto, il protagonista Frate Sole(5), insegnante di quella scuola, al termine delle lezioni serali guida una comitiva di colleghi (abbandonate, appunto, le "tane") verso un sancta sanctorum(6) per la celebrazione di una serata bacchica(7).Laddove la contrapposizione tra le inospitali "tane e l'ospitalissimo "scopile" ha riferimento non già alla funzionalità architettonica(8), quanto alla ragione dell'intrattenimento nei rispettivi locali.
Del Convento "che serve come caseggiato scolastico" parla Grazia Deledda nel postumo, autobiografico Cosima(9).
La Scrittrice ne parla come di un edifico che "ha due ingressi, uno per i maschi e l'altro per le femmine: a questo si sale per una breve scaletta esterna e si entra in un lungo corridoio chiaro e pulito sul quale si aprono le aule: piccole aule che sanno ancora di odore claustrale, con le finestre munite d'inferriata, dalle quali però si vede il verde degli orti e si sente il fruscio dei pioppi e delle canne della valle sottostante".
Oggi, palesemente, quel verde non si vede più; ma l'edificio è miracolosamente rimasto intatto, all'esterno come all'interno.Intatto è rimasto il fascino dell'antico, anche per merito del sacerdote Don Gavino Lai che, appunto in quell'edificio, aveva ubicato un'associazione benefica e lo aveva, così, preservato da una speculazione edilizia che negli anni Sessanta e Settanta del secolo appena passato aveva investito (anche) quella zona di Nuoro.
Crea una certa emozione, peraltro, pensare che proprio in quelle aule, ancora intatte (cosa rara, per Nuoro), aveva appreso i primi rudimenti del sapere Grazia Deledda, così come già, prima di lei, aveva appreso gli stessi rudimenti Sebastiano Satta.
Ma anche un altro grande nuorese, Salvatore Satta, era uscito da quella scuola; e così bene egli conosceva le aule di essa che con assoluta precisione le descrive ne Il giorno del giudizio: "Nell'interno, c'era ancora il grande atrio col pavimento di lavagna che si sbriciolava nell'umido, e su di esso si aprivano due stanzoni col soffitto a volta: quello a sinistra doveva essere stato la chiesa del convento, perché dal buco della serratura si intravedeva qualche nicchia vuota, in una persino un santo con la mano alzata, che insisteva a benedire in mezzo al ciarpame".
E ancora:
"Dall'atrio si scendeva per una breve scala in quello che doveva essere stato il vero convento.Era una specie di quadrato, con un cortile troppo piccolo per essere un chiostro, e da due lunghi e opposti corridoi si accedeva alle aule, che poi non erano che le celle dei frati.
E in quelle celle, illuminate più da una feritoia che da una finestra, e tanto alta che i frati potessero vedere Dio, ma non il mondo, si stipava un numero incredibile di ragazzi, quasi un nuovo miracolo avesse moltiplicato lo spazio.Le celle dell'opposto corridoio, a un piano rialzato, erano destinate alla scuola normale, cioè ai giovani, ormai adulti, che si avviavano a diventare maestri, secondo i nuovi ordinamenti, i quali volevano maestri colti, non povera gente, come maestro Mossa(10).
Anche il Convento, per Salvatore Satta, è emblema di quel microcosmo nuorese che inghiotte tutti e tutti riduce alla propria dimensione: e pur tuttavia lascia miracolosamente intatta la condizione individuale di ciascuno.Un irripetibile compromesso tra socialità e individualità che reclamizza efficacemente l'unica, possibile terapia all'angoscia di chi, altrimenti, si sentirebbe avvolto nelle spire di un determinismo sostanzialmente ineludibile.
Il Convento, quale raffigurazione dell'Ordine, è insomma il contraltare del Caos, del disordine intellettuale che vegeta nel Caffè Tettamanzi: due antitesi che finiscono per trovare illusoria sintesi nell'insieme microcosmico, nell'utopia che rende labile persino il confine tra la vita e la morte.
Utopia che, al di là di un fugace effetto placebo, non riesce tuttavia a placare l'angoscia, se non unito alla speranza. "Se la fede non ha su che basarsi effettualmente, praticabile è pur sempre la virtù della speranza, intesa come aspirazione a capire non rinunziando a supporre che vi sia, pur inattingibile, una giusta ragione del Tutto(11).
Ne Il Capoluogo di Franco Floris incontriamo il "vecchio convento" in apertura di romanzo, come terminus a quo di un percorso viario che induce alla stazione ferroviaria, a sua volta terminus ad quem di esso. Alla quale stazione arriva, preannunciato da un pretenzioso fischio, il microscopico trenino "con la rumorosa iattanza di un Orient Express", quale messaggero che introduce il filo della narrazione. Un antico trenino che richiama alla memoria - perché è lo stesso capolavoro di ancestrale ingegneria che aggira il colle di Monte Dionisi nel tortuoso viaggio verso Nuoro - il "trenino a buoi" che dà inizio al sattiano discorso sullo Spirito religioso dei Sardi(12).
Ma nel romanzo di Floris, il Convento ricompare poi, ammantato di ironica misteriosità(13), nella sua vocazione iperscolastica: come edificio dotato di un non so quali immaginari sotterranei che nella pantomima del maestro di turno fungono da deterrente, atto a ricondurre all'ordine gli indisciplinati scolari.
Infine, per il Sempre caro di Marcello Fois, anche per stare in linea con la generale impostazione del romanzo, accentuerei qui il paradosso.Il Convento aleggia, in esso, come il Colosseo in certi dipinti di scuola romana, in particolare in certe "vedute" di Scipione e Mafai: non si vede, eppure c'è. Così, nel romanzo di Fois, il Convento compare solo per dare nome a un certo terreno (il "terreno a Convento") "che era rimasto alla Curia anche dopo l'abolizione della mano morta".
Il Convento, perciò, è anche qui un indiretto elemento che fa parte integrante della monade nuorese, la quale sarebbe addirittura un'altra se quel frammento di vita collettiva, quel documento lapideo, non la rappresentasse con la sua statica storicità.
In conclusione, il breve excursus letterario qui accennato non ha e non può avere pretese se non quella di rappresentare che l'antico edificio, il Convento appunto, è parte non solo del paesaggio urbano ma anche, e con migliore fortuna, di una storia letteraria che abbondantemente lo trascende. Perché Nuoro non è solo giustapposizione di pietre capaci di narrare la storia, ma anche monumentum aere perennius, in quanto idea contenuta in messaggi artistici e letterari.
Ciò che di Nuoro raccontavano le sole pietre è oggi in parte scomparso; e non mi riferisco solo all'anonimo ambientale, ormai quasi interamente sostituito dal cemento, dall'alluminio anodizzato, dal PVC, dall'acrilico.Mi riferisco a edifici di rilievo, com'era il palazzo Mereu, il Carcere giudiziario, la "vecchia" caserma dei Carabinieri, un'ala del palazzo delle Poste, la stessa stazioncina ferroviaria(14).
Aggiungerei i due ottocenteschi palazzetti di Piazza Plebiscito, demoliti per allargare lo spazio dell'attuale Piazza Sebastiano Satta, nonché gli edifici che l'inerzia della Pubblica amministrazione sembra avere condannato al naturale crollo: il "mulino" Guiso Gallisai (unico esempio nuorese di archeologia industriale), la casa natale di Giampietro Chironi, la casa natale di Francesco Ciusa.Forse si salverà il cine-teatro Eliseo(15).
Ecco, allora, che la verità oraziana riemerge per ricordarci che la perennità letteraria non sostituisce interamente il racconto lapideo, ma lo integra.Più esatto, forse, sarebbe il dire che l'integrazione è reciproca: e proprio quella fattuale reciprocità ci offre l'esatta misura di quanto amiamo la nostra storia.
1) 20 febbraio 1989.L'articolo è stato poi, da me, trasfuso nel mio Corso Garibaldi (Nuoro, Il Maestrale, 1994, pag. 77), corredato da una foto risalente ai primi del Novecento, la quale mostra il presunto stato d'origine del fabbricato.
2) Le varie destinazioni sono dettagliatamente elencate, col preciso riferimento temporale, in Elettrio Corda, Storia di Nuoro, Milano, Rusconi, 1987, pag. 142. Il passaggio dell'edificio alla proprietà del Regno piemontese avvenne per effetto della legge 29 maggio 1855.Sulle conseguenze di essa, nell'ambito dell'intera Sardegna, cfr.Ottorino P.Alberti, I vescovi sardi al concilio Vaticano I, Roma, Ed.Pontif.Univ.Lateranense, 1963, pag. 23 s. (a pag. 25, nota 44, è fatta menzione della Casa dei Minori Osservanti di Nuoro). Quando l'edificio fu adibito a scuola, il cimitero dei frati ne divenne palestra all'aperto.
3) Illustrazione databile intorno al 1925 e riproducente l'edificio nello stesso stato in cui era al momento della foto ricordata nella nota 1.Dal che, appunto, si desume che il rifacimento della facciata risale agli anni Trenta del secolo scorso.
4) Stampato a Pola nel 1927, a opera del tipografo Francesco Rocco (poi ristampato a Nuoro, in anastatica).Non ho ricordo alcuno (ma se incorro in errore domando anticipatamente scusa al lettore) di una qualsiasi menzione del Convento fatta da Sebastiano Satta.
5) Il maestro Francesco Ganga, noto Predischedda (ne Il giorno del giudizio è ricordato come maestro Manca, noto Pedduzza).
Per chi, però, ha avuto (come me) la fortuna di esaminare l'originale manoscritto del capolavoro sattiano, la "trasformazione" non vale: il nome, il cognome e il soprannome sono in esso quelli autentici (così come i nomi e i soprannomi di tutti i personaggi del romanzo, protagonisti, deuteragonisti o semplici comparse che siano).Sull'occultamento (o trasformazione che dir si voglia) dei nomi predetti ho avuto occasione di scrivere ne L'Unione Sarda del 28 marzo 1989 e, successivamente, nel periodico Il Corriere di Roma del 27 gennaio 1991 (il relativo articolo ho, poi, trasfuso nel citato Corso Garibaldi, pag. 141 s.).Sull'argomento sono quindi tornato sul (sempre mio) Elogio del Microcosmo, Milano, Mondadori, 2001, nota 2 al cap. VI.Per incidens, dico che resto sempre del parere che sono quantomai maturi i tempi per l'integrale pubblicazione del capolavoro.
6) La cucina rustica ove si celebra la serata bacchica è in siffatto modo denominata dal Gallisay. Nel dialetto nuorese, i locali di tale tipo erano denominati scopiles (scope) per via della frasca che veniva solitamente appesa sull'uscio, al fine di attirare gli avventori. Tale usanza è ricordata dallo stesso Menotti Gallisay nel primo capitolo del suo racconto (pag. 13), nonché da Giovanni Pirodda nella Prefazione ai Canti di Sebastiano Satta, nell'edizione Mondadori del 1980 (pag. 11).
7) Su Menotti Gallisay come personaggio sattiano cfr. Gianni Pititu, Nuoro nella Belle Epoque, Cagliari, AM&D, 1998, pag. 133 s.; nonché il mio Il testimone Ricciotti Bellisai, in Corso Garibaldi, cit., pag. 127 s. e Su Menotti Gallisay come scrittore, uomo politico ed eminente personaggio nuorese, cfr. il mio Ricordo di Menotti Gallisay, in Corso Garibaldi, cit., pag. 153 s., nonché (sempre mio) Il socialismo microcosmico di Menotti Gallisay, in Elogio del microcosmo, cit., pag. 77 s.
8) La cucina rustica in questione, non credo più esistente (a Nuoro, l'antico è tragicamente effimero), faceva parte di un piccolo "complesso urbano" (un cortile interno sul quale si affacciavano sette minuscole abitazioni, collocato nella Via Lamarmora).Una memoria del quale è fissata nelle opere grafiche di Salvatore Pirisi e di Salvatore Zizi, nonché in un dipinto a olio di Gavino Pau, risalente agli anni Sessanta e riprodotto in fotocolor nella rivista Il Popolo Sardo, luglio-settembre 1998, pag. 17 (il dipinto appartiene a una collezione privata). 9) Pubblicato (postumo) nel 1937.
10) Per un'ampia biografia del Satta, che nel Convento di Nuoro aveva frequentato le classi elementari, v. Vanna Gazzola Stacchini, Come in un giudizio, Roma, Donzelli, 2001.
11) Vittorio Spinazzola, Itaca addio - Vittorini, Pavese, Meneghello, Satta: il romanzo del ritorno, Milano, Il Saggiatore, 2002.La frase riportata nel testo è tratta dalla pag. 244.Spinazzola individua la ragione dell'angoscia sattiana nell'ineludibile fatto del venire ad esistenza. Concezione, questa, di chiara derivazione esistenzialistica, di pretta marca dostoevskijana.
12) Pubblicato nella rivista Il Ponte, nel 1955.Efficacissima l'immagine della vetustà tecnica, ossia l'immagine di un veicolo lento quanto può essere lento quello trainato dai buoi, così come il carro agricolo sardo (il "carro a buoi").Quello stesso che, una volta staccate le bestie da tiro, diventa ne Il giorno del giudizio (cap. II) "un capolavoro di arte astratta".Eppure, quel trenino, benevolmente deriso da Satta e da Franco Floris, è oggi considerato valido "documento" di tecnica costruttiva industriale di fine Ottocento, tanto che alcuni esemplari di esso, debitamente restaurati, sono custoditi nel Museo ferroviario di Monserrato, oltre che negli scali ferroviari di Sassari e Macomer. Nuoro non ha neppure provato a proporsi come sede di quel Museo.
13) L'ironia è, a mio avviso, la nota dominante del romanzo di Franco Floris, quello che Francesco Loi, nel risvolto di copertina, definisce "viaggio di Franco Floris, fra uomini e cose di quel mitico paese che è la Memoria".
14) Delle loro demolizioni ho parlato nel mio Corso Garibaldi, cit.
15) Di quest'ultimo è iniziato il restauro, così come il Sindaco Mario Zidda aveva promesso; ma a Nuoro iniziare un restauro non significa necessariamente portarlo a termine (v. l'esempio della "vecchia" chiesa delle Grazie).Del restauro degli altri edifici, menzionati nel testo, nec audio nec video.