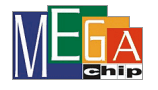“Mi lasci fare una premessa, che poi ci aiuterà a discorrere: non esiste un’unica società sarda. Non è dato pronunciare il nome Sardegna al singolare; se mai è il caso di dire “le Sardegne”. Propongo sempre questa distinzione: per evitare che gli interlocutori diano descrizioni diverse – tutte esatte – di quello che loro ritengono lo stesso oggetto, mentre invece si tratta di oggetti differenti. Per esempio, Olbia è una cosa, Mamoiada un’altra: non si può fingere che siano uguali.
“Ed è vero: un tempo le “zone interne” della Sardegna avevano una valenza di riferimento. Un po’ di questa valenza forse lo conservano: perché la cultura è vischiosa; e magari ogni sardo può ancora guardare a Nuoro come “alla sua seconda patria”, secondo l’espressione di Salvatore Satta. Là, nelle “zone interne”, resiste un quid della più antica e specifica identità sarda; un’ombra, residua ma difficile da cancellare, di quell’identità. E a molti di noi, se non a tutti, continua ancora a scorrere nelle vene qualche goccia di quel vecchio sangue: metaforico, s’intende.
“Ma se poi io lo dico a un giovane cagliaritano, magari, o anche sassarese, è probabile che non sia d’accordo. Che mi risponda: non nelle mie vene”.
Fatta la premessa, torniamo pure alla domanda: esiste una violenza specifica sarda? Magari in quelle “zone interne”.
“Credo che una violenza specifica sarda – una vis Sardiniae, se la parodia è consentita – continui a esistere.
“Mi sembra indispensabile partire da Antonio Pigliaru: dalla ricognizione che lui ha compiuto delle “zone interne”, del “noi pastori”, del “codice della vendetta”, come diceva. Non se ne può prescindere neppure oggi che le cose sono tremendamente cambiate. Ma già ai suoi tempi Pigliaru parlava di realtà in movimento rapido, di identità fortemente in crisi. Era in origine una società gelosa di sé, paga di sé e chiusa in sé, che aveva proprie regole e le contrapponeva a quelle dello stato: chiamandosi fuori, così, dagli assetti sociali della modernità. Perché dato peculiare d’ogni organizzazione sociale moderna è la solidarietà generale: l’impersonalità del vincolo che unisce i cittadini, anche quando non si conoscono gli uni con gli altri. In quella vecchia società sarda non esiste un debito di solidarietà nei confronti di tutti. Esistono forti debiti di solidarietà; però particolari: solo verso i parenti, gli amici, i vicini, i benefattori, eccetera. Nel caso della vittima di un crimine ci si rivolge sempre una domanda: “ Mi è parente? Mi è amico?” Questo non significa solidarizzare con gli aggressori (per esempio gli autori d’un sequestro di persona o i ladri d’un gregge). Significa che ogni volta che lo Stato cerca di fare giustizia, per conto di quelle vittime, chiedendo aiuto a chi non le conosce, la risposta è il silenzio, il rifiuto: un silenzio eloquente, un rifiuto drammatico anche quando non viene reso esplicito. E questo silenzio, questo rifiuto sono il contesto della violenza di cui stiamo parlando; e insieme ne rappresentano la prima caratteristica”.
Che ne è stato di quella antica società sarda, del “noi pastori” e del “codice della vendetta”?
“Ribadiamo che quell’antica società e quel codice possedevano dei valori: valori che noi possiamo non condividere, nel loro ordine complessivo, ma che non dobbiamo disconoscere. Per esempio la solidarietà prestata – quando veniva prestata, dove veniva prestata – era vera e profonda. Come erano tutti veri e profondi i vincoli che stringevano la vita del “noi pastori”, assegnandole un ubi consistam, addirittura un destino. Ma già all’epoca di Pigliaru – anni ’50 e ’60 – quell’antica società era entrata in crisi: e Pigliaru lo diceva, descrivendo i caratteri del modello originario. Era entrata in crisi, fin da allora: oggi però il codice dei suoi valori e dei suoi riferimenti è saltato in aria; è letteralmente scoppiato, impazzito.
“Perché è impazzito, come è impazzito? Credo che le risposte siano due, schematicamente (piuttosto schematicamente, sono argomenti che avrebbero bisogno di ben altro che di qualche chiacchiera). Due le risposte: entrambe da collocare dentro lo scenario d’una crisi globale di senso e d’identità. Da una parte c’è l’impatto della società dei consumi, le cui sirene arrivano fin dentro alla pinnetta più remota (ma esistono ancora le pinnette?). Non voglio solo parlare della televisione o del mondo della réclame, che è il mondo televisivo per eccellenza (anche se si tratta di telenovele e di telequiz); ma certo la televisione è il veicolo principe: diciamo la tribuna di tutto. Dall’altra parte (e magari è la parte che conta di più) c’è la mancanza di alternative, di sbocchi: non solo economici s’intende, anche sociali, culturali. La scommessa più alta, quella dell’industrializzazione, l’abbiamo persa, perfino simbolicamente. Le campagne e i paesi mandano via la gente, si svuotano secondo proprie logiche. Le aggregazioni politiche, sociali, culturali, quando non sono colate a picco, faticano a stare a galla, per usare un eufemismo: faticano parecchio. Il vecchio mondo è devastato, la terra trema sotto i nostri piedi: e non si vede – o almeno non si tocca, non è a portata di mani – un nuovo mondo credibile, nel quale valga la pena di abitare.
“Chi viveva dentro i vecchi codici oggi si trova affatto privo di riferimenti. Un tempo per regolarsi aveva in cielo delle stelle fisse, alle quali guardava: magari non servivano a capire il mondo come noi lo intendiamo; ma in quel piccolo mondo là erano utili: se non altro a dare a chi ci stava dentro un’identità; e attraverso quell’identità, degli orientamenti. Oggi le stelle fisse d’antan sono tramontate per sempre e nulla le sostituisce. Così anche la violenza, che nella vecchia società sarda seguiva sue logiche, razionali (la balentìa era un modello morale), ora che si pone fuori da quelle logiche, da ogni aggancio di valori, diventa gratuita; o quando non è gratuita, sproporzionata. Sì, è una violenza che scoppia gratuita e comunque sproporzionata: inedita nella sua essenza. Perché è la manifestazione d’uno spaesamento terribile: della terra che manca sotto i piedi, dello sbaraglio fra vecchi codici che non bastano più e nuovi codici che non passano. Per esempio, quanto spendono le amministrazioni comunali per sostituire le lampadine continuamente distrutte da fucilate o sassate? E crediamo si tratti solo di giochi, di peccati veniali, di modeste imprese “teppistiche” (virgolette d’obbligo, dato che di teppisti là non ce ne sono)? O invece si tratta di gesti che rappresentano la metafora di ben altro, rifiuti e solitudini, domande destinate a rimanere senza risposta?”.
È tutta questa la specificità della violenza di cui stiamo parlando?
“No. Il mio era solo il tentativo di trovare un’immagine: un luogo di rappresentazione, il più basso possibile. E la violenza insita in una simile immagine significa che la vita degli uomini non è più quella di prima; vale infinitamente di meno, la vita degli uomini: si può sopprimere per un piccolo motivo – o quasi senza motivo.
“Ma poi il cuore di questa stagione di violenza credo batta nella ragion fattasi. A torto o a ragione si mettono le bombe. Il conflitto fra i due codici (quello della vendetta, quello dello stato) diventa anarchia: continui scoppi di anarchia, fuori da ogni regola; “afferra afferra”, diceva il vecchio inno.
“Spesso (il più spesso?) le bombe si mettono contro i pubblici amministratori. Ho l’impressione che questa, nella sua statistica abnorme, sia una nostra specificità. Il reliquato del vecchio codice incapace di rivivere, o per meglio dire la memoria mistificata che se ne conserva, accresce l’insofferenza verso qualsiasi limite pubblico. All’insegna della nostalgia (ispirata anche da fonti culturali “alte”) di su connottu. La materia spesso è quella dei terreni pubblici: a proposito dei quali i vecchi codici consentivano, se non equità di fruizione, assestamenti di rapporti; assestamenti oggi sconvolti.
Ci sono anche intimidazioni di tipo mafioso?
“Credo che, se pure si verifica nelle “zone interne” qualcosa di simile (si parla per esempio di pretese non isolate di “pizzi”), non si tratti di fenomeni tali da rientrare in linee di tendenza prevalenti, fino a oggi. Manca a essi un consenso di massa, humus d’ogni mafia. La società sarda, più per la sua configurazione che per le sue virtù, non è facilmente disposta a diventare mafiosa”.
Di chi sono le responsabilità del malessere di cui stiamo parlando?
“Le responsabilità sono tante, a tutti i livelli. Noi sardi non facciamo altro che presentare conti a tutti: al governo nazionale, all’Europa... Sì, probabilmente i governi nazionali non hanno nemmeno impostato la questione sarda; come può ben darsi che il transito verso l’Europa non ci venga reso agevole quanto occorrerebbe. Ma le prime a essere chiamate in causa dovrebbero essere le istituzioni “nostre”, quelle dell’autonomia regionale.
“E poi davvero io non credo che la lista dei responsabili possa onestamente concludersi solo con i nomi della politica. Per esempio gli intellettuali – con le loro disattenzioni e le loro bubbole, i loro piagnistei e la loro facilità di consolarsi, le loro mitologie identitarie – dove li mettiamo in quella lista? Ma è l’intera collettività che è in gioco, se si vuole cambiare qualcosa: non solo perché i legislatori e i governanti, quelli nazionali e quelli dell’autonomia, li eleggiamo tutti noi. Sì, sono in gioco culture e valori, attività e inerzie, d’ognuno. Mea culpa: mea culpa, nessuno escluso, a cominciare dai due attori di questa simpatica conversazione.
“A proposito va detto che anche nelle “zone interne” esistono fasce collettive – non so quanto capaci d’averla vinta, finora, ma non irrilevanti – che spingono perché si esca dal malessere, perché si cambi. Anche se cambiare non è facile, giacché bisogna cambiare dal di dentro”.
Quali sono i percorsi per uscirne?
“Domanda da centomila dollari. Comunque, di percorsi non ce n’è uno solo. Chissà, se ognuno prova a fare la sua parte. Chi sta in politica cominciando a non raccontare, e a non raccontarsi, troppe bugie: cercando invece di capire e di scegliere, dentro la realtà; di scegliere secondo una – tutta di ritrovare – nozione di valori condivisi; e tentando, almeno un po’, di governare quel che succede, senza che precipiti interamente per suo conto, per mera e bruta forza di gravità.
“Ma s’intende non ci si può limitare a delegare: lo dicono tutti. Per esempio, se gli intellettuali sardi cercassero d’avvicinarsi un po’ di più al cuore delle cose; o almeno, modestamente, a qualche cosa...
“Però il livello che conta di più è sempre quello più basso: del corpo sociale. Prima c’erano là dentro dei tramiti collettivi, che oggi non ci sono più. La scommessa, per tutti, è ricostruirne altri; e insieme ricostruire le molecole della società: provando a rinominare le cose. Sì, forse è il caso che cominciamo a sbattere la faccia su quanto c’è più vicino, nei luoghi dove viviamo, trovandogli una definizione non dialettale: adoperando invece gli strumenti della cultura moderna per situare nel mondo – con tutta la terribile fatica che costa – quanto ci sta vicino”.