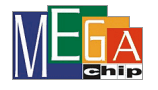Si diceva un tempo che una regola siffatta era meritevole di osservanza, a condizione però che l’esternazione extra chorum non consistesse “nel dir male di Garibaldi”. Oggi c’è maggiore libertà di espressione, sicché al limite si potrebbe anche, volendo, dir male di Garibaldi. Così come potrebbero fare, ad esempio, coloro che sono scarsamente convinti della bontà del capolavoro dell’Eroe, che è poi un semplice, se pur consistente, contributo alla formazione della mazziniana unità d’Italia. Oggi peraltro discussa.
Io, comunque, non intendo dir male qui di Garibaldi e neppure infrangere un totem. Intendo solo dire che, a me, un idolo degli intellettuali nostrani, la piazza Sebastiano Satta di Nuoro, non pare un capolavoro. E ne dirò brevemente le ragioni.
* * *
La prima ragione per la quale mi discosto dal coro osannante prende le mosse dal rilievo che qualora si fosse voluto, in fase progettuale, creare un quid conformato al canone estetico esprimibile con l’enunciazione del binomio “architettura-natura”, sarebbe occorso, quantomeno, che la “natura” fosse quella autentica, non una semplice imitatio naturae, cioè un’artefatta riproduzione di elementi naturali che, al limite, avrebbero potuto fungere da semplici ingredienti finalizzati a una banale decorazione. Laddove è chiaro che il ricordato binomio ha invece teorico fondamento nell’esigenza, peraltro non solo estetica, di conformare l’impostazione architettonica al preesistente stato naturale, quando questo abbia determinate caratteristiche atte a suscitare una piacevolezza sensoriale1. Regola, questa, che non pare osservata nel caso della piazza in questione, la cui impostazione sembra invece finalizzare una funzionale subordinazione dei manufatti (la pavimentazione e le decorazioni di granito lavorato che simulano scomode, irrazionali panche) all’inutilità dei massi di granito grezzo (in sé stessi bellissimi, peraltro, perché “modellati dal tempo”) strappati da non so quali campagne (non credo nuoresi, ma poco importa) e collocati qua e là, a mo’ di “monumenti alla natura”.
Ecco, allora: il punto è proprio questo. Difettando in concreto l’autenticità dell’elemento naturale, il programma realizzativo, così come disegnato da Costantino Nivola, andrebbe definito diversamente da come si è or ora ipotizzato. Non più attuazione del binomio “architettura-natura”, bensì un qualcos’altro (da individuare e decifrare) che aiuti nella non agevole lettura del manufatto. Perché è intuitivo che la lettura di un messaggio artistico comporti, in primis, la corretta individuazione della relativa chiave.
Si potrebbe, in questa direzione, prendere le mosse dalla constatazione che sulla piazza si affaccia la casa natale di Sebastiano Satta; e pare possibile che tanto la committenza, quanto lo scultore-architetto, abbiano inteso ricordare e celebrare il Poeta riproducendo un lembo dell’amata terra barbaricina, la cui asprezza si associa alla durezza dei graniti:
Se l’aurora arderà su’ tuoi graniti...
Il fatto è però che il granito neppure compare granché nelle immagini sattiane. Querce, lecci (elci), lentischi occupano uno spazio considerevolmente più ampio. Ma – è lecito domandarsi – sarebbe stato credibile impiantare un “giardinetto” riproducente un lembo dell’Ortobene o della Serra? Non credo proprio. oltrettutto, per avere a Nuoro una diretta visione della barbarica natura basta percorrere poche centinaia di metri, in qualunque direzione. L’artefatta riproduzione non ha senso.
È peraltro ovvio il rilievo che le vie e le piazze devono ricordare i personaggi unicamente con gli strumenti della toponomastica. Può in essi, al più, essere collocata un’opera scultorea (consona, s’intende, ai canoni artistici del momento e, perciò, nell’attualità, a quelli che negano validità alla tradizionale “statuaria”)2. Non credo, invece, si possa, con ragionevoli speranze di successo, conformare la tipologia costruttiva di una piazza alle “note caratteristiche” di un poeta, come dire all’oggetto dei messaggi che quell’artista utilizza in repertorio nel proporsi ai destinatari di essi. Sarebbe come se, per ricordare Carducci, si piantasse un melograno o, per ricordare Foscolo, si pavimentasse una piazza con lastre tombali (finte, s’intende).
Io credo che le vie e le piazze di un agglomerato urbano, se di nuovo impianto, devono sorgere con un’impronta di conformazione a quanto ad esse è circostante, foss’anche il c.d. “anonimo ambientale”, che è peraltro, in mancanza di cospicue opere architettoniche, un elemento meritevole di valorizzazione.
Ho ben conosciuto e ho un buon ricordo della vecchia piazza Plebiscito (così la piazza in questione era denominata prima della trasformazione): era una piazzetta minuscola, anche perché all’interno dell’attuale spazio sorgevano due palazzetti, ormai demoliti; ma fascinosa e piena di mistero, non foss’altro perché sorta sui ruderi del settecentesco carcere, una cella del quale, peraltro, ancora è visibile (con finestra ferrata) alla destra dei gradini che inducono alla più bassa via Angioy. Uno dei due palazzetti, antistante l’attuale scuola materna, era quello nel quale abitava Menotti Gallisay. Era dotato (al secondo piano) di un balcone con ringhiera di ferro, dal quale lo stesso Gallisay arringava la folla, così come narrato ne Il giorno del giudizio. L’altro, minuscolo nella struttura, fronteggiava il primo, chiudendo la piazzetta come la quinta di un teatro. La funesta ira demolitoria di certi amministratori nuoresi ha fatto scempio di essi.
Se la piazza fosse rimasta quella ch’era, in essa si sarebbe, oltrettutto, potuto ricostruire il monumento a Sebastiano Satta, scolpito da Francesco Ciusa, e improvvidamente collocato fuori dell’abitato, in cima al colle di S. Onofrio, alla mercé dei vandali.
Così però non è stato, ed è inutile recriminare.
* * *
La seconda ragione per la quale mi pare criticabile l’attuale impostazione della piazza è quella inerente al mio ragionato rifiuto di una cimiteriale colorazione delle facciate dei palazzi, bianche come il marmo di un obitorio; così volute da chi, evidentemente, ignorava che siffatta sorta di candeggio è assolutamente estranea alla cultura architettonica del centro storico nuorese.
Può darsi che il calimerico biancore sia stato suggerito (o imposto?) dallo stesso Nivola. Non lo so e non mi interessa saperlo. Certo è che tale prescrizione fu a suo tempo data da chi ignorava completamente una tradizione che andava invece rispettata3.
Le case del centro storico nuorese, con riferimento alle loro facciate, erano conformate alla seguente tipologia: o non erano intonacate, sicché esibivano un granitico “faccia a vista”; o esibivano il naturale color ocra di un grossolano intonaco sommariamente frattazzato; ovvero (e questi erano i palazzi dei prinzipales) esibivano un intonaco fine, finemente frattazzato, atto a ricevere la finale tinteggiatura che, poi, non sempre veniva applicata.
Quello del “faccia a vista” può essere considerato un tipico esempio di incompiutezza, di murazione rustica in perenne attesa dello spianamento di un intonaco che, vuoi per il non preventivato sopravvenire di una sgradita indigenza, vuoi per altre vicissitudini, non venne mai dato. La giustapposizione dei contones di granito non era però, allora, un qualcosa di per sé degno di essere esibito. Oggi, in fase di restauro, qualcuno salva quel “faccia a vista” rendendolo accettabile con una qualche rifinitura dei contorni (porte, finestre, balconi, cornicione). E ciò è sempre meglio di una qualsiasi snaturante trasformazione.
Quello dell’intonaco grezzo era, da sempre e fino agli anni della guerra, il caso più frequente. L’impasto, formato da un miscuglio sapientemente dosato di calce spenta e sabbione rosso di Nuoro (su sassu), veniva steso sulla muratura grezza, talvolta solo sommariamente spianato con la cazzuola, talaltra reso uniforme (ma non troppo) col frattazzo; il quale ultimo, data la grossolanità del sabbione, produceva un magnifico, irripetibile effetto di “graffiato”. La colorazione risultante era un indelebile giallo ocra; indelebile perché non era effetto di una tinteggiatura sovrapposta, ma era il colore intrinsecamente risultante dal miscuglio delle due componenti dell’impasto. L’effetto ocra perdura a tutt’oggi, anche dopo secoli, nei pochi esemplari ancora visibili a Santu Predu, a comprova di una indelebilità altrimenti irraggiungibile. Questo era il vero, tradizionale, autentico colore delle case di Nuoro: l’ocra nuorese.
Vi erano, infine, sos palattos rifiniti con l’intonaco “fine”, un composto di calce spenta e sabbia di fiume (finemente grigliata) che veniva applicata sullo strato di intonaco “grosso” (il c.d. arricciato) e uniformemente allisciato mediante accurata frattazzatura. Su di esso veniva poi dato il colore prescelto, la cui consistenza materica era un miscuglio di latte di calce e di “ossidi” o, se si voleva conferire maggiore pregio all’opera, di terre d’ocra (indubbiamente più pregiate). I colori prescelti erano prevalentemente il celeste o il rosa, ovvero il giallo ocra, ottenuti mediante dosaggio dell’ossido o della terra nel latte di calce.
Quando poi, per ragioni di bilancio familiare, la tinteggiatura veniva indefinitamente rimandata, restava il colore biancastro (non bianco) del descritto intonaco “fine”. Ma quel colore, sia ben chiaro, non era l’effetto di alcuna tinteggiatura. Sarebbe peraltro un errore ritenere, ad esempio, che il palazzo Nieddu al Corso fosse stato progettato per essere tinteggiato di bianco. Esso, semplicemente, esibiva una facciata sempre in attesa di colorazione.
Certo è, comunque, che l’avere dato retta a chi, per insipienza (e questo vuole essere un complimento, perché ben altra espressione dovrebbe essere adoperata se si scoprisse l’intenzionalità del dispregio della tradizione), ha creduto lecito suggerire l’impronta coloristica della piazza tenendo a parametro la funzionalità antisolare, necessitata dalle condizioni climatiche, tipica delle isole greche, induce a ritenere che i nostri amministratori hanno sbagliato tutto.
1) Cfr. PAOLO PORTOGHESI, Natura e architettura, Milano Skira, 1999, passim.
2) Per intenderci, non frutto di quell’impostazione della statuaria ottocentesca, pur pregevole (talvolta) se realizzata nell’Ottocento, orrenda se riesumata in ritardo, ossia dopo il proclama di ARTURO MARTINI (Scultura lingua morta?) che ha definitivamente sconfitto certa insulsa retorica, già priva di senso ai primi decenni del Novecento.
3) Sull’importanza “culturale” della colorazione dell’intonaco degli edifici, cfr. PAOLO MARCONI, Dal piccolo al grande restauro, Venezia, Marsilio, 1999 (2ˆ), pag. 107 seg.