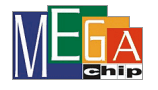La violenza, comunque indirizzata, è sempre una deteriore manifestazione di bestialità che suscita orrore e desta allarme sociale. Ma soprattutto la violenza assolutamente gratuita, la quale non ha altra motivazione che la sua stessa traduzione in atto, desta allarme maggiore perché è la più difficile a prevedere e quindi prevenire. Quando la violenza è motivata da scopi tipologicamente classificabili, quali ad esempio il fine di lucro, la diversità di professione ideologica, il proposito di vendetta, la patologica spinta sessuale, ecc., la prevenzione può ben essere attuata con successo, anche mediante strumenti giuridici. Ma allorché il movente dell’azione violenta si discosta da ogni possibile schematizzazione avente riferimento a “interessi” umani, per deteriori, in quanto non inquadrabile in una tipologia di spinte al compimento di azioni statisticamente prevedibili, ecco che la prevenzione presenta il massimo grado di problematicità.
Tipiche, in questo settore della vita giovanile, sono le azioni di “sballo” commesse dai componenti il cosiddetto “branco”; azioni che il più delle volte nessuno dei componenti il gruppo, singolarmente considerato (cioè fuori dal “branco”), mai compirebbe, anche se ne avesse l’occasione; soprattutto se - come purtroppo è più volte avvenuto - la violenza si consuma con un’azione omicida (si pensi, ad esempio, al “divertimento” dell’incendio degli scatoloni di cartone nel cui interno dormono i cosiddetti “barboni”; ovvero al “bingo” del lancio dei sassi dal cavalcavia sulle autostrade). Il “branco”, insomma, è un’entità capace di generare inaudita violenza, un moltiplicatore delle potenzialità di ciascuno dei suoi componenti. Ma esso non ha una visibile etichetta, o comunque una evidente targa di riconoscimento; sicché la prevenzione delle sue non prevedibili azioni violente riesce purtroppo impossibile. E, questo, proprio perché l’elevazione a potenza della capacità offensiva e la traduzione in atto di quest’ultima non hanno riscontro nella tipicità delle azioni umane, non hanno cioè un prevedibile movente proporzionato al fattuale risultato dell’azione.
La prevenzione di cui finora si è parlato è però quella attinente all’immediato. Ma se si parla, al contrario, di prevenzione a lungo termine, magari in chiave prettamente pedagogica, il discorso pessimistico può inclinare in altra direzione.
Se, infatti, l’azione violenta di che trattasi non ha un classificabile movente (classificabile, appunto, secondo una ripetitiva tipicità delle azioni umane) il quale assume il ruolo di “causa efficiente”, ciò non significa ch’essa azione non abbia una “causa remota”; ed è proprio questa che può, a lungo termine, essere individuata ed eliminata.
Quanto all’individuazione (di tale “causa remota”) il discorso può ben muovere in de distinte direzioni, anche se poi convergenti nel risultato.
Un recente sondaggio televisivo, di fronte allo “sballo” di un “branco”, ha posto agli ascoltatori il quesito se, in un caso di quel genere, la responsabilità maggiore fosse delle rispettive famiglie dei ragazzi, ovvero della “cultura” (cioè del cinema, televisione, giornali; dei mass media in genere che, informando sui fatti di violenza, se anche non l’esaltano direttamente, finiscono per diventarne cassa di risonanza). Il quaranta per cento degli ascoltatori ha indicato la famiglia; il sessanta per cento la “cultura”.
Io avevo pronosticato il contrario; ma, se interpellato, avrei detto che la “causa remota” va individuata nella totale mancanza di professione dei valori. Avrei detto, cioè, che anzitutto i mass media devono informare (e conseguentemente educare) i genitori alla professione dei valori e, quindi (e qui siamo in quel quaranta per cento), devono pedagogicamente condannare la violenza, in primis omettendo la trasmissione di quegli spettacoli che, invece, l’esaltano.
Ma oltre la famiglia e i mass media, il compito d’individuare l’origine della violenza spetta alla scuola, la quale (almeno in teoria) dispone di tutti gli strumenti per farlo, così da suggerire programmi pedagogici indirizzati alla giusta finalità.
La convergenza, insomma degli opportuni indirizzi dei mass media e l’elaborazione di appropriati programmi scolastici dovrebbe condurre alla prima individuazione precisa del fenomeno da combattere, così creando le premesse per impedire quella che, altrimenti, sarebbe un’espansione a macchia d’olio.
Quanto all’eliminazione della causa remota, cioè alla terapia che deve seguire alla diagnosi (quella, appunto, condotta dai mass media coordinati con la scuola), si dovrebbe anzitutto acquisire la convinzione che la sola repressione attuata con gli strumenti della giustizia non svolgerebbe, data anche l’immaturità dei giovani autori di quelle violenze, alcuna efficace azione deterrente. Come dire: non svolgerebbe alcuna efficace azione di prevenzione.
È chiaro allora che occorre muoversi in altra direzione; e, precisamente, in quella cui ho fatto prima breve cenno, ossia imboccare la strada della professione dei valori. I valori, ovviamente, inerenti alla persona umana, primo fra tutti il bene della vita.
Qui sopravviene un discorso d’impronta teoretica, perché affiora l’argomento della “filosofia della vita”; la quale non è una specifica “teoria”, ovvero “scuola filosofica”, ossia un quid caratterizzato da un organico pensiero improntato a una definibile specificità. Essa, invece, è piuttosto una tendenza a considerare la vita umana come valore primario anche in campo speculativo; tendenza che ben può essere ritenuta comune a filosofi di disparati orientamenti, come ad esempio Schopenhauer, Nietzsche, Dilthey, Simmel, Spengler, James, Ortega y Gasset, Unamuno, Bergson, Popper. Ma è proprio questa peculiarità di vasta comunanza che conferisce pregio a tale tendenza speculativa; la quale può, così, essere egregiamente adottata anche come parametro di civiltà, in particolare di questa civiltà occidentale che, a dispetto di Spengler, non sembra affatto destinata a concludersi nell’immediato.
S’intende che l’adesione a questa tendenza comporta al professione dei valori cui s’è fatto cenno. I quali valori, secondo la più accreditata dottrina, e in particolare quella che fa capo alla Scuola di Windelband e di Richter, sono quel dover essere che è idoneo a determinare una scelta, nell’ambito di realtà trascendenti, privilegiante ciò che può assicurare verità, bontà, bellezza.
Ecco, allora, che in quest’ambito la vita umana può trovare collocazione nel gradino più alto della scala dei valori. Ma anche gli altri predicati della vita e le molteplici attribuzioni di essi esigono una pur graduata collocazione, perché anch’essi sono da ascrivere alla scala dei valori.
È proprio il rispetto di questi ultimi, dei valori appunto, che dovrà essere impegnativamente insegnato, a genitori e figli. Altrimenti, teniamoci quello che abbiamo.