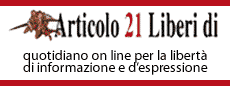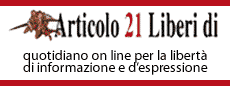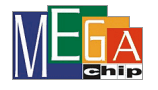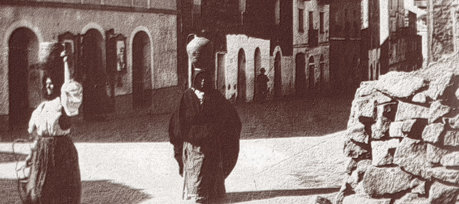Bacone sosteneva che gli uomini sono convinti di dominare la lingua, ma che in realtà avviene spesso il contrario, e cioè che sia la lingua a governare le loro menti. Se si riflette su questo concetto e si analizza, anche sommariamente e grossolanamente, il modificarsi del linguaggio, soprattutto in questi ultimi decenni, ci si rende conto dell'attualità di tale affermazione. La filosofia contemporanea d'altronde ha incentrato buona parte dei suoi studi e delle sue analisi proprio su questo tema. È necessario forse qualche esempio. Flessibile è un aggettivo dal suono dolce ed armonioso che, fino a non molto tempo fa, richiamava alla nostra mente visioni di ballerine che volteggiavano con eleganza, immagini d'atleti che, grazie alle loro notevoli capacità ginniche di stiramento e piegamento muscolare, si esibivano in figurazioni perfette agli anelli o agli altri attrezzi, evocavano insomma idee di elasticità, bellezza corporea ed armonia di movimento. Oggi invece, se sentiamo pronunciare la parola flessibile, immediatamente pensiamo alle capacità, richieste ad ognuno di noi nel proprio campo lavorativo, d'adattamento e passaggio da un incarico ad un altro, da un orario ad uno più funzionale alle esigenze dell'azienda (oramai tutti i luoghi di lavoro sono o aspirano ad essere aziende), di accettazione del cambiamento di comparto, di sede, di città e, perché no, di nazione, di assunzione del rischio rispetto a scelte di nuovi modelli operativi etc... La parola ha cambiato significato nella frequenza d'uso. Ciò rientra, evidentemente, nella dinamica evolutiva delle lingue, ma non mi pare che ci sia stato, in questo processo, un miglioramento di senso, né immaginativo né tantomeno nella qualità della vita. Prima che la flessibilità lavorativa divenisse per tutti un imperativo categorico, la coscienza di appartenere ad una classe, il senso della professione e del gruppo dei compagni con cui in linea di massima si supponeva di trascorrere il tempo di lavoro davano una connotazione alla propria identità individuale, perché ponevano in relazione gli uni con gli altri e disciplinavano la vita attraverso lo scambio, la solidarietà, la cooperazione e la partecipazione. Oggi che la flessibilità è diventata misura delle professionalità e discrimine di carriera, dominano in modo diffuso il disorientamento e la confusione nell'orizzonte prospettico, l'illeggibilità emotiva che allontana dai rapporti e dal senso d'appartenenza, l'indifferenza verso il luogo e gli stessi compagni di lavoro, la mancanza di solidarietà e cooperazione (vengono, addirittura, coniati nuovi termini per sintetizzare questo nuovo clima lavorativo, come ad esempio mobbing, di cui un dizionario aggiornato riporta già la definizione: " terrorismo psicologico attuato fra colleghi nei luoghi di lavoro e fatti di calunnie, sgambetti, pugnalate alle spalle, per la promozione e altri vantaggi di carriera"). Proviamo con un altro termine: fluttuazione. Fino a qualche tempo fa, questo vocabolo aveva come significato dominante il concetto d'ondeggiamento libero dall'attrazione di gravità. Si era portati ad immaginare, quindi, astronauti fluttuanti nella navicella spaziale, noi stessi, stesi in riva al mare, estasiati di fronte alle evoluzioni e alla leggerezza del movimento d'ali di un gabbiano che si lascia trasportare nel cielo dalle correnti d'aria, oppure sognare i nostri attori preferiti, persi dietro gli svolazzanti e fluttuanti panneggi di dame che con eleganza si aggirano nelle stanze o nelle terrazze del bel mondo, interpreti di storie con meravigliosi amori nei romantici film di cui avremmo voluto essere protagonisti. La parola aveva per noi quindi un significato amabile e immaginifico, faceva sognare, inventare, creare con la fantasia mondi personali. Oggi, molto più prosaicamente, il termine fluttuazione, perso ogni alone emozionale, richiama concetti economici e monetari, ricorda le paure vere o indotte di svalutazione del denaro e di perdita di valore del potere d'acquisto dei nostri stipendi, ci fa pensare ai listini di borsa con quei noiosissimi elenchi di azioni ora in salita ora in discesa, in fluttuazione appunto, tutte idee decisamente poco piacevoli, non solo per la intrinseca mancanza di poesia, ma anche per le nostre povere tasche. Proviamo ancora, cerchiamo una parola meno eterea: sommerso. Anche qui, il senso era quello che rimandava ai fondali marini abitati dai pesci più strani e multicolori, alle misteriose profondità degli abissi descritte nei romanzi, alle forse meno avventurose ma sempre suggestive nuotate con maschera e boccaglio nelle nostre bellissime acque. Ora invece, questo termine sgomenta proprio, non perché il mare sia più infestato di squali (o forse si?), ma perché richiama alla mente le tristi condizioni di centinaia di migliaia di lavoratori in nero, a domicilio, in scantinati o garage nascosti, in laboratori clandestini senza assicurazioni contributive etc...(si chiama eufemisticamente "sistema moderno di economia decentrata", si può negare che esista un legame tra linguaggio e lavoro?). L'elenco potrebbe certo continuare a lungo, basterebbe prendersi la briga di sfogliare un dizionario e confrontare la modificazione di significato nella frequenza d'uso dei termini anche più comuni. Sarebbe facile verificare quanto in quest'ultimo "banale ventennio", com'è stato definito dai linguisti, le parole abbiano slittato semanticamente verso discipline economiche e finanziarie, perdendo o mantenendo molto marginalmente i significati primari. Non esiste innocenza o neutralità della lingua. Una società, come la nostra, basata sul profitto e sull'utile ha la lingua che la rappresenta, che non può essere immaginifica perché deve tendere alla semplificazione massima, alla praticità e velocità della comunicazione. Chi parla non può permettersi di perdere troppo tempo a pensare, a riflettere sul giusto o sull'ingiusto e non può, a maggior ragione, perdersi dietro ai sogni o alle fantasie. Non deve neanche cercare di soffermarsi a fare minuziose analisi o riflessioni su quanto deve dire, sarebbe perdita di tempo ed operatività! Il problema, a questo punto, non è se ciò sia bene o male. È già purtroppo un dato oggettivo. È importante forse ripensare l'orizzonte prospettico, o perlomeno rendersi conto di quanto succede. Il predominio dello spazio tecnico prevale, lo sviluppo della razionalità economica limita sempre più la fantasia e l'immaginazione.
"L'analisi delle cose è la morte della bellezza o della grandezza loro, è la morte della poesia" dice Leopardi (Zibaldone 1234). Quanto più è limitato lo spazio di libertà espressiva e creatività individuale, tanto più si appiattisce la lingua e con essa si allenta il nostro dominio sulle cose e sui meccanismi ad esse sottesi. Non è funzionale, infatti, ad una società basata su una ristretta aristocrazia economica, che le persone siano in grado di usare linguaggi articolati, complessi e creativi, che esprimano, insomma, le loro energie individuali. È necessario invece che si approprino, quanto più in fretta possibile, di lessici specifici, predeterminati, funzionali alle esigenze lavorative (non importa di quali gruppi, culture o idee del mondo). La pienezza del possesso e l'originalità dell'uso della lingua restituiscono, infatti, pericolosamente, la capacità di lettura del mondo e delle sue dinamiche, eliminano la banalità degli stereotipi che come una crosta profonda tendono a soffocare l'unicità personale del pensiero, e consegnano capacità critica e di analisi. Lo sviluppo di un linguaggio immaginifico, creativo ed emozionale potenzia la dimensione pubblica della relazione, dello scambio reciproco di messaggi, idee ed esperienze, relega altrove l'individualismo e la solitudine. (Non sarà proprio questo che in realtà non si vuole, perché sia più facile il controllo?) La lingua è uno specchio dove le immagini riflesse possono essere la realtà o l'illusione della realtà, possono raccontare i pensieri ma sanno anche crearli. È importante rendersi conto di ciò. Le parole sono potenti: sanno plasmare il pensiero, sanno provocare sentimenti, sanno dirigere le coscienze. La lingua è un campo storicamente determinato, reca testimonianze. Le sue variazioni ed incrostazioni forniscono segni di identificazione della società e della cultura dominante. Sempre più diventiamo ostaggi e vittime inconsapevoli dell'uso di parole ed espressioni ambigue, di cui riteniamo di possedere a fondo il senso, e che invece utilizziamo spesso anche incoscienti del fatto che vadano in direzione contraria al nostro stesso interesse. Utilizziamo le parole, avvilite spesso e anche logorate dall'eccesso d'uso, divenute simbolo o feticcio propagandistico di interessi altri dai nostri, con l'euforia di un consenso assolutamente immotivato. Ci spinge il convincimento di poter così dimostrare d'essere al passo coi tempi, d'essere in grado di interpretare la modernità e di saperne esprimere con il linguaggio la relativa modifica in tutti i campi. In realtà il pensiero è pensato, manipolato dalle parole che hanno disegnato al posto nostro la realtà. Il risparmio di fatica che l'assenza di ricerca del termine pensato in autonomia di giudizio comporta, la sospensione di responsabilità consegnata dall'uso di parole o espressioni entrate nella quotidiana comunicazione di massa, la sicurezza del giudizio già collaudato (pregiudizio), consentono la tranquillità e la mancanza di turbamento, che l'elaborazione delle idee invece richiede. Comporta anche però, è bene ricordarlo, l'abdicazione a costruire un mondo secondo fini etici e di giustizia sociale, la possibilità di vivere in luoghi di lavoro alienanti e con relazioni costruite, secondo una scelta libera e consapevole, ma finalizzata al tornaconto.