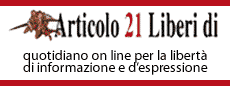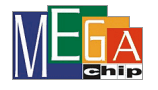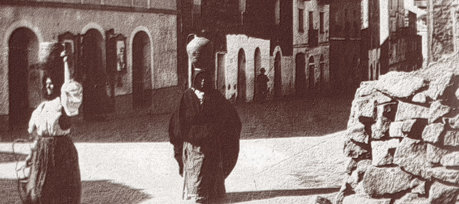La storia di Cala Gonone è raccontata principalmente dalle pietre; sicché la ricostruzione di tutto ciò che è ricostruibile, così come il restauro di tutto ciò che è restaurabile, assume il significato di una giustapposizione delle sparse tessere di un mosaico che aspira ad essere ricomposto. Il mosaico della storia di un agglomerato urbano calato in una meravigliosa, antica natura mediterranea che va aiutata a salvarsi dalla sempre incombente cementificazione.
È stato ipotizzato che la prima costruzione sorta a Gonone (questo è l'originario toponimo; l'aggiunta di "Cala" era, agli inizi del secolo XX, riservata al linguaggio burocratese) fosse la chiesetta della Madonna del Mare, dato che l'inizio dell'edificazione risalirebbe nientemeno che al Settecento (chiesetta già ubicata al centro della attuale piazza di Santa Maria del Mare e demolita, poi, negli anni Cinquanta). Non credo però sia attendibile tale risalente datazione.
L'edificazione fu, molto probabilmente, sponsorizzata dalle ottocentesche famiglie abbienti di Dorgali; le più facoltose delle quali, appunto nella metà dell'Ottocento, erano (variamente articolate) quelle dei Putzu, dei Secci e Secci - Gisellu, degli Spanu. Le quali edificarono, nel sito che oggi rappresenta il centro storico dell'abitato, tre gruppi di case: a destra (guardando verso il mare) quelle dei Putzu (case che in parte sono ancora esistenti, così come erano); al centro quelle dei Secci e Secci - Gisellu (case che hanno subito profonde modificazioni); a sinistra (zona de su Recreu) quella degli Spanu (1). Poco distante dal descritto centro sorsero la Villa Macallè (a sinistra) e la villa La Favorita (a destra). La chiesetta, presumibilmente, sorse in contemporanea a tali costruzioni: del resto, una chiesa campestre (senza alcun abitato intorno) non avrebbe svolto in concreto alcuna funzione per difetto di agevole collegamento col pur non distante agglomerato urbano di Dorgali. Prima del 1860 (anno in cui i minatori venuti dall'Iglesiente completarono l'apertura della vecchia galleria, iniziata nel 1838) la sola via di comunicazione con Dorgali era lo scavalcamento della impervia cresta rocciosa denominata Scala Homines. Una via, questa, assolutamente preclusa a chi non fosse dotato di notevoli qualità atletiche (Alberto Lamarmora, comunque, riuscì in tale impresa).
L'apertura di quella prima galleria - finalizzata a incrementare gli sporadici traffici commerciali consistenti principalmente nella esportazione via mare (i velieri approdavano a un pontile in legno il cui tratto iniziale ancora esisteva negli anni Cinquanta) dei prodotti locali (vino e formaggio, trasportati a dorso di cavallo) - segnò certamente una svolta. Ed è opinione diffusa che le ricordate costruzioni siano temporalmente ricollegabili a quell'avvenimento. Giuseppe Pisanu, storico della comunità dorgalese, fa risalire l'inizio della costruzione della chiesa addirittura al 1891. Non cita alcuna fonte, ma è da credere possa essere nel vero (2). Indica tuttavia una data inoppugnabile, quella della documentata inaugurazione, officiata quest'ultima dal Rettore Monni e solennizzata dall'allora giovanissimo sacerdote - storico Mauro Sale: agosto 1896.
Secondo Pisanu, la prima casa di Gonone, ossia la casa degli Spanu, sorse nel 1880; mentre la villa La Favorita fu eretta da Paolo Putzu (allora sindaco) nel 1888; e quest'ultima edificazione costituì per l'epoca un avvenimento culturale rilevante, se per il riconosciuto pregio estetico della costruzione l'edificante ricevette il premio ministeriale, al tempo cospicuo, di cinquecento lire (3).
Le case centrali, quelle dei Secci e Secci - Gisellu (due case gemelle, fra loro contigue) sono letterariamente ricordate dallo scrittore russo Michail Nikolaevich Semenov, nel suo libro di memorie (4); il quale scrittore fu ospitato a Dorgali, con visita a Gonone, da Peppe Secci - Gisellu, meglio ricordato come Peppe Tropea, sindaco dal 1911 al 1919 (5) e proprietario, appunto, di una di tali case sovrastanti la spiaggia di Gonone (quella che oggi è denominata "spiaggia centrale").
In un precedente scritto (6) ipotizzai, a causa peraltro di non precise informazioni circa la proprietà della casa in cui fu ospitato lo scrittore russo (a Gonone, appunto), che l'ospitalità fosse stata offerta da Billia Tropea, fratello di Peppe, il quale era stato sindaco di Dorgali (con interruzioni) dal 1900 al 1910. Oggi, assunte più precise informazioni, faccio di buon grado ammenda, affermando che il sindaco ospitante fu Peppe e non Billia Tropea.
Resta però ancora da domandarsi perché mai Semenov fu condotto a Gonone, per una sosta di poche ore. È difficile pensare che l'iniziativa sia partita da Peppe Tropea, posto che a quell'epoca non v'era alcunché di "turistico" da mostrare e considerato che il faticoso viaggio da Dorgali, a piedi naturalmente, attraverso la vecchia galleria (descritta peraltro dallo scrittore), tra l'andata e il ritorno poté durare non meno di quattro ore, cioè un tempo non inferiore a quello della sosta (Semenov racconta di essere partito la mattina e di essere ritornato la sera).
Molto probabilmente fu lo stesso Semenov a chiedere al Tropea di essere condotto in quella spiaggia, perché presumibilmente Grazia Deledda glielo aveva suggerito. Racconta lo scrittore che nel 1914 giunse a Nuoro con certe lettere "di raccomandazione" dategli da Grazia Deledda, con la quale evidentemente intratteneva un rapporto di amicizia e cordialità.
Grazia Deledda certamente conosceva Gonone, ove (si tramanda) la sua famiglia si recava "per i bagni", come peraltro usavano le numerose famiglie benestanti di Nuoro. In Cosima, però, di questo non si parla; e del resto (ma quest'affermazione affido solo alla memoria) la spiaggia di Gonone non è menzionata nei racconti e romanzi. Se ne parla solo, e per accenno, in Sangue Sardo (del 1888); ma il toponimo neppure compare, sostituito da un accenno a "scogli neri e solitari", a ridosso delle "macchie di lentischio", sotto una cerchia "di monti grigi e velati". Il riferimento a Gonone è palese.
*******
Ma di gratificante menzione letteraria, oltre la casa dei Secci - Gisellu, si giova anche la villa La Favorita. La quale, ne Il giorno del giudizio, è ricordata come il luogo meraviglioso, fatato, del quale erano proprietarie le zitelle Mariani, venute da Dorgali, a Nuoro per rendere omaggio a Don Ciriaco, insignito del prestigioso cordone rosso, simbolo del canonicato. Una "villa favolosa con un'altana proprio sul mare, che si chiamava La Favorita, dove una volta Gonaria era stata e ne aveva un ricordo di sogno" (7).
Una villa che nel romanzo è denominata "villa dei Mariani", allorché appare come un miraggio nella mente sconvolta di Gonaria. E come "villa Mariani" era denominata e conosciuta ai tempi in cui la famiglia Satta Galfrè la frequentava (i più anziani di Dorgali ricordano ancora che nel periodo estivo veniva ospitato non solo l'avvocato Filippo Satta Galfrè, il Ludovico del romanzo, ma anche il giovanissimo Salvatore che ivi trascorreva la maggior parte del tempo immerso nelle letture). Era denominata villa Mariani perché la proprietà era passata da Paolo Putzu alla sorella Giovanna, sposata con Vincenzo Mariani.
Nel capolavoro sattiano, dunque, la villa dei Mariani appare come un miraggio nella mente sconvolta di Gonaria, la quale ultima fugge "dalla vita e dalla morte" avviandosi a piedi (con i piedi sanguinanti) nell'improbabile viaggio verso Gonone e "Palma di seta" (8).
Ma leggendo attraverso le righe ben s'intuisce che nella memoria del Satta quella villa, con l'antistante spiaggia caratterizzata dalla finissima sabbia, rappresenta per lui un momento di evasione dalla plumbea quotidianità nuorese, rivissuta sul filo della memoria. La prima giovinezza del Satta, del resto, coincide più o meno col periodo in cui Semenov reiterava la fuga dalla realtà cercando il contatto diretto con la ruvida sabbia della vicinissima spiaggia di Gonone. Singolari e affascinanti coincidenze letterarie.
*******
È peraltro da ascrivere a fattualità coincidente anche l'appartenenza delle due abitazioni, la villa La Favorita e la casa dei Secci - Gisellu, a un'unica, ripetuta tipologia costruttiva, rivelatrice di una misteriosa etnia di remote origini orientaleggianti, a loro volta esprimenti il fascino di una misteriosa indecifrabilità. Entrambe a pianta quadrata in un unico piano terreno, partita in senso latitudinale, con due camere da letto nel rettangolo posteriore e due cucine fronteggiantesi lateralmente nel rettangolo anteriore, intercalate da un loggiato aperto, sorretto anteriormente da due archi. A sesto acuto, peraltro, gli archi delle porte e finestre de La Favorita, secondo una tipologia che sembra fondere un lontanissimo rigore gotico con una insolita deregulation orientaleggiante. Accentuata, per di più, da una esteriore tinteggiatura azzurra, con lesene gialle (9), che la rendeva specularmente partecipe di quella fusione di cielo e mare che è tipica delle visioni del Golfo di Orosei (10).
Ma in quella visione azzurra si stagliano, a soli pochi metri dalla villa e all'interno della sua più stretta pertinenza, i ruderi di uno sconosciutissimo nuraghe: il nuraghe Pramasera, distante dalla riva del mare non più di 100 metri.
Del nuraghe rimangono oggi soltanto le basilari strutture megalitiche, essendo peraltro pensabile (ma è solo una mia supposizione) che gran parte delle sovrastanti pietre siano finite, debitamente spezzettate, nei muri della villa. Era un nuraghe innalzato col basalto della zona, sicché i ruderi appaiono di colore nero; in contrapposizione, perciò, al bianco del preistorico insediamento denominato nuraghe Arvu (11) eretto con pietra calcarea, perciò simile nella colorazione al lontano nuraghe Mereu, nel Supramonte di Orgosolo, e al nuraghe Alvu in territorio di Baunei.
*******
La scoperta dei nuraghi nella conca di Gonone è relativamente recente. Della loro esistenza non v'è traccia negli studi del gesuita Padre Alberto Maria Centurione (12); ma la loro importanza non è certo sfuggita ad Antonio Taramelli (13), il quale analizza con dovizia di particolari il nuraghe Arvu, il nuraghe Mannu e il più discosto Nuragheddu.
Qualcosa, però, doveva pur sfuggire anche all'attento Taramelli. Il quale ricorda, bensì "la villa della Favorita" ma solo perché nei suoi pressi sbocca(va) "una fonte d'acqua medicinale, s'Abba meiga" (14), ma non fa menzione alcuna dell'adiacente nuraghe Pramasera. Quandoque bonus dormitat Homerus.
Quella dianzi descritta, originariamente tinteggiata d'azzurro (come detto), era la villa Putzu nel suo massimo splendore. Poi, inesorabilmente sopraggiunse la decadenza.
La proprietà passò, per atto di donazione al Seminario diocesano di Nuoro (per una metà) e alla Parrocchiale di Dorgali (per l'altra metà), cioè a due beneficiari concretamente disinteressati a ogni ipotetica utilizzazione. Tra gli anni Cinquanta e Sessanta avvenne il crollo del tetto e, perciò, la rovina dei muri.
Resta intatto, tuttavia, quanto serve per l'integrale, fedele ricostruzione. E proprio questa intende realizzare Don Salvatorangelo Nieddu a favore della Parrocchiale di Cala Gonone, per la destinazione a proficue attività culturali. Non ultima, si ha ragione di sperare, quella di centro direzionale per lo studio sistematico delle molteplicità archeologiche, in parte inesplorate.
1) Una visione fotografica (dal mare) che pone in evidenza le case Putzu (sulla sinistra) Secci e Secci - Gisellu è riportata (pur senza didascalia) nel saggio di G. PISANU, Dorgali - Storia e memorie della comunità (1340-1946), Della Torre, Cagliari 1997.
2) Op. cit.
3) Il relativo assegno è ancor oggi custodito, in ingrandita immagine riproduttiva, da Fulvio Pirari, discendente di Paolo Putzu.
4) M. N. SEMENOV, Bacco e Sirene, De Carlo, Roma 1950.
5) E. CORDA, Storia di Dorgali e della marina di Cala Gonone, Rusconi, Milano 1990; G. PISANU, op. cit.
6) M. CORDA, Corso Garibaldi, il Maestrale, Nuoro 1994.
7) S. SATTA, Il giorno del Giudizio, cap. XVIII.
8) Ai tempi del Satta, quella che oggi è italianamente denominata spiaggia di Palmasera era a Nuoro conosciuta come "Parma e seda"; sicché il Satta, traducendo letteralmente, la denomina (in italiano, appunto) "Palma di seta". A Dorgali e Gonone, invece, quell'italianizzato toponimo è sempre stato pronunziato come Pramasera.
9) F. DORE, Nel mare di Dorgali, Gallizzi, Sassari 1895.
10) Le ricordate abitazioni non erano peraltro le sole improntate a tale schema costruttivo, essendo lo stesso ripetuto, quantomeno, nella casa dell'orunese Maria Teresa Monni (moglie di Billia Tropea), oggi profondamente rimaneggiata, nonché nella villa Macallè.
11) I ruderi del nuraghe Arvu sono chiaramente visibili nella zona Nord - Ovest sovrastante l'abitato di Gonone, pur se ridotti ad un ammasso di pietre per mano di una furia vandalica che ha quasi vanificato la faticosa opera di riordino attuata dal Taramelli nel 1927.
12) A. M. CENTURIONE (S.J.), Studi recenti sopra i Nuraghi e loro importanza (saggi pubblicati nella Civiltà Cattolica e raccolti nel 1888 in unico volume; ora ristampato con Premessa critica di G. MANCA, Edizioni Solinas, Nuoro 1995.
13) A. TARAMELLI, Scavi e scoperte 1922-1939, vol. IV, C. Delfino, Sassari 1985, passim.
14) Nella riprodotta planimetria, però, la villa (che nella realtà è a cento metri dalla riva del mare) è ubicata in un punto errato, a duecento metri dalla riva.