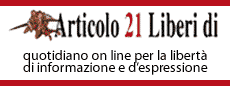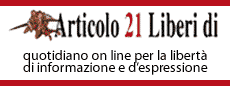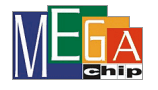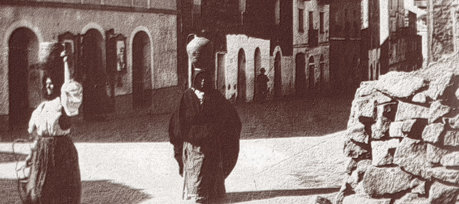Nuoro è come una nebulosa sospesa nell'aria di un paese globale che cambia. Un particolare inerte nel totale onnivoro? una città o un paese che sembra non voler cambiare, che afferma la sua infermità. Tiene ferme le sue colonne e cerca di guardarsi dentro guardandosi allo specchio, ma in realtà riesce solo a guardarsi alle spalle. Nutre le sue corone di fiori: Francesco Ciusa, Sebastiano Satta, Grazia Deledda, Salvatore Satta e altri appunti che fanno nota. Con questi esibisce la sua medaglia di "Atene Sarda", fregio di ben poca forza nell'epoca in cui i caratteri originali e autonomi di una cultura sono naufraganti nell'oceano flessibile della globalità. Ho vissuto dieci anni intorno a Nuoro - muovendomi dentro il suo cuore come un battitore cardiaco - e non sono mai riuscito a sentire niente più che un debolissimo rumore di fondo. Sì, va bene, è importante guardarsi allo specchio ogni tanto per osservare gli agenti alle spalle, ma oggi? Oggi il discorso è aggrappato al bisogno di "fare cultura" a tutti i costi, la qual cosa si rivela impresa non da poco, perché il trend - il costume delle municipalità - è votato alla magnitudo delle grandi imprese. E le grandi imprese, quelle che fanno delirare il villaggio globale e che orchestrano il coro dei grilli parlanti, non se le possono permettere tutti. Immaginiamoci allora l'entità della vera domanda come "quale cultura?". Parlando di Nuoro mi viene in mente una frase di Giorgio Caproni, "Una città lontana e sola", che mostrava il destino comune alle tante città di un "mezzogiorno" dimenticato a metà giornata, sospeso tra l'alba e la notte. Solitudine e isolamento: momenti che si denunciano come forme dell'autorappresentazione, tratti di un immobilismo che tende ad assumere un ruolo modellante e pervasivo. Eppure in quell'isolamento ho sentito agitarsi tensioni estroverse e forze centrifughe. Tra i monumentali corpi di pietra forse solo il silenzioso sguardo di Salvatore Satta sembra presentare tracce di un percorso che guarda più avanti. Ma le intelligenze di oggi in grado di raccogliere quello sguardo, o di aprire un varco, una ferita per potersi finalmente liberare di quella inutile separatezza, dove sono? Le intelligenze ci sono, ma restano a guardare. Ogni tanto qualcuno fa e gli altri subito lo uccidono con uno sguardo perché ha osato rompere il silenzio senza avvisare prima. Se la qualità della vita di questa città non è migliorata granché una ragione ci deve pure essere. Ma lasciamo pure perdere il discorso su ieri e avantieri e chiediamoci: in queste condizioni è ancora possibile fare cultura? Se la funzione della cultura è quella di muovere un cambiamento, di avanzare criticamente, di promuovere e proporre, di stimolare e arricchire, di contribuire ad una lettura contemporanea della contemporaneità, chi oggi a Nuoro si muove consapevolmente in questa direzione e soprattutto chi si adopera per creare le condizioni per una rinascita culturale che sia vissuta e sentita dalla intera comunità? L'imbarbarimento collettivo che segna il passo dell'incedere berlusconiano, avanguardia di una destra retriva e malfattrice, non ha ragioni addebitabili solo all'appiattimento dei contenuti culturali generato dalla scatola televisiva. È il silenzio colpevole, la muta rappresaglia contro tutti e contro nessuno, il narcisismo accattone di chi nuota nella tradizione convinto di galleggiare nell'identità, l'abdicazione davanti alla difficoltà della politica, la vertigine davanti al vuoto, il sogno davanti alla realtà, la forma contro i contenuti, l'astratto contro la figura, il mezzo anziché il fine? questi mutamenti paradigmatici hanno segnato come perdita della vista il fatto di essersi coperti gli occhi con robuste fette di prosciutto. In realtà ogni momento culturale è momento politico, perché (in esso si) disegna un modello d'uomo e un progetto di società. Chi a Nuoro ha lavorato nel senso del confronto culturale (idest multiculturalità) ha certamente operato in questa direzione politica. Ma chi ha lavorato in questa prospettiva è stato spesso ignorato, risarcito con l'indifferenza. È questa una condizione che ho vissuto personalmente come operatore culturale, cui non poteva essere perdonata la cagliaritanità. E io che pensavo che il confronto culturale assai poco avesse a che fare con l'agonismo municipale! I primi ad esercitare il mestiere dell'ignoranza (quasi per vocazione dell'amministratore medio) sono le istituzioni politiche, che si sono votate all'intrattenimento tout court, convinte così che transitare sull'effimero paghi immediatamente, senza guardarsi intorno e puntare le carte sulle energie diffuse che chiedono di fatto solo un coordinamento operativo, un sostegno che spesso non è monetarizzabile e che per questo incontra la diffidenza di solerti amministratori (abituati a quantificare il valore culturale in banconote). Poi le istituzioni sociali e culturali, ma anche - soprattutto - le scuole, le associazioni, le cooperative e così via: tutti presi nell'irrespirabile gorgo della sopravvivenza e che in nome di questa hanno pianto lacrime autolesioniste o si sono autocensurate o ancora annichilite a neutra vox clamantis. Io non so se Nuoro abbiamo mai giustamente meritato l'appellativo di "Atene sarda": questa è una domanda oziosa per frequentatori dei vari mauriziocostanzoshow. Credo invece che sia in discussione la consapevolezza nel cittadino nuorese di essere interprete della città, cioè di farsi partito della cittadinanza, di riconoscersi in un "noi" allargato. La violenza e l'arroganza che vieppiù si diffondono testimoniano di un verticale crollo del senso del "noi", perché i modelli culturali che le istituzioni - formali o informali che siano - gratificano, contribuiscono a costruire un cittadino cementificato nell'"io". Bisogna riconoscere ovviamente che la cultura nuorese di oggi - come ogni altra - non esprime niente altro che la sua realtà culturale. Chi si guarda indietro per darsi medaglie non sa guardare al presente. E il presente di Nuoro non ha medaglieri. Si sente il peso della fatica, ma è solo con la faticosa insistenza a guardare "oltre", col concepire la cultura come strumento che consente di partecipare di quell'"oltre", che si può vincere l'abulia dell'incoscienza e l'incomunicabilità dell'impossibile. È vero che il contesto è quello di un "noi" ereditato - perché la cultura è cultura dell'ambiente che si è storicamente determinato - ma la carta vincente è quella di pensarsi come un "noi" in fieri (cioè avanzato nel suo porsi criticamente rispetto alla tradizione normativa), il cui contesto dinamico è in quella cultura dell'ambiente che oggi non può che essere confronto, urto, conflitto, relazione con altre idee e altre culture. Non sarebbe il caso, allora, di cominciare a chiudere i cimiteri, di abbandonare l'orizzonte museale, di smettere gli occhiali dell'autopsia? Quando stavo a Nuoro sentivo spesso dire che bisogna ripartire dalle proprie radici, da quel che siamo stati per costruire quel che saremo. Di grazia: e cos'è che siamo stati? Di quale "noi" ci parlano costoro? Non ci si è accorti che qualunque "noi" prendiamo questo presenta già dei caratteri oltrepassanti? Si prenda la lingua: la pluralità linguistica è una forma dell'espansione e non della dispersione. La tensione centrifuga della comunicazione linguistica è incontenibile. Forse quel che siamo stati ha qualcosa a che fare con il parco deleddiano? Non sarà che "parco" è un'altra parola/maschera per non dire "cimitero"? Ho avuto spesso la netta sensazione che chi parlava di "ritorno alle radici" intendesse in realtà qualcosa di molto simile alla "imbalsamazione". Non c'è nulla di immorale nell'"imbalsamare" un osso di ieri, ma sarebbe da ciechi non vedere il rischio implicito di una vera e propria imbalsamazione della "carne" di oggi e soprattutto di domani. È evidente che il "noi" a cui ci riferiamo tutti giorni è il contesto di una comunità normativa (che nella forma della tradizione tramanda regole e valori). In filosofia politica è un terreno disegnato da John Rawls: il confronto culturale muove da un corposo situarsi culturale dell'osservatore, che in quanto tale sta sempre vincolato ad un punto di osservazione. E quel punto privilegiato è la cultura cui si partecipa, di cui si è parte. Tuttavia una prospettiva più esterna e interpretativa - per dirla con Michael Walzer - spinge ad un'ottica critica più ampia, in cui il "noi" non sia il doppio della comunità normativa, ma sia protagonista di un processo di valorizzazione universale. Perché l'importanza innegabile di una comunità particolare è definita in un suo "oltre", un orizzonte di partecipazione più vasto che renda ragione di una cultura particolare come cultura interpretante. In altre parole: il "noi" deve farsi - da ristretto - allargato. Aprirsi, cioè interpretare l'apertura.