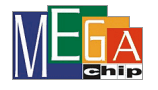Cominciò a costruirla un califfo, un certo Abd-Arahman I, nel 785 d.C., e i suoi successori continuarono ad ingrandirla e ad arricchirla fino alla fine del decimo secolo, con colonne di granito, diaspro verde e marmi preziosi, tant’è che diventò la moschea più grande del mondo dopo la Kaa’bah della Mecca.
Quando i cristiani cacciarono gli Arabi da Cordoba, s’impossessarono della moschea e la consacrarono all’Assunta. La lasciarono intatta fino al 1523, quando, chissà perché, venne loro l’idea di costruirci una cattedrale all’interno; terminarono i lavori che era già il 1766.
Tutto questo lo troviamo in una qualsiasi guida turistica. Quello che le guide non ci dicono è che in quelle pietre, in quei marmi preziosi ci stanno mille anni di storia.
E in questi 1000 anni ci stanno due modi diversissimi di vedere Dio: quello degli arabi, fatto di spazi vuoti e pieni, di geometrie e scacchiere nei pavimenti; quello dei cristiani, fatto di volte gotiche, vetrate colorate e facce di santi.
E il bello è che tutti quelli che ci vanno, dai poeti alla gente comune, hanno la chiara percezione di trovarsi di fronte non ad un cumulo di differenze che la storia a disposto a casaccio, ma ad una cosa sola, che esiste contemporaneamente e armonicamente nello stesso spazio, ed è bellissima.
Così, dopo le dichiarazioni di Silvio Berlusconi sull’Islam, ho pensato alla mezquita e al fatto che mi piacerebbe che la nostra civiltà superiore le assomigliasse almeno un po’.
Ma ho l’impressione che non ci siamo neanche lontanamente vicini, se qualche giorno fa la televisione ha trasmesso un’intervista al “Re dei rifugi antiatomici” (testuali parole del cronista), che pare siano tornati di moda, nel clima di terrore generale. Si tratta di un signore robusto, rubizzo, con pochi capelli sulla testa, ma accuratamente impomatati.
Il sovrano in questione ha elencato i pregi delle sue costruzioni, dotate di tutti i confort: un piccolo bagno, i letti, le tute antiradiazione e persino, meraviglia delle meraviglie, una cyclette collegata ad un generatore per produrre la corrente elettrica e, nello stesso tempo, tenersi in forma. Ci si può stare settimane lì dentro, un po’ strettini ma tutto sommato comodi se si pensa a quelli che friggono di fuori, e per la modica cifra di 60 milioni, trattabili.
E il signore, incalzato dal giornalista, dice che i suoi rifugi sono veramente resistenti, certo a meno che la bomba nucleare non ti centri in pieno, perché allora sarebbero necessari settanta metri di cemento armato sopra, sotto e di lato, e insomma in quel caso è proprio sfiga e lui non ci può fare proprio niente, rivolgersi al padreterno (quest’ultima cosa non l’ha detta ma si vedeva che lo pensava).
Comunque il re dei rifugi sosteneva la necessità, in un paese civile (di superiore civiltà, si direbbe oggi), di dotare tutti gli uffici pubblici e i condomini di rifugi antiatomici.
E mentre, con orrore, cerco di immaginare la mia vita dentro un bunker di cemento sotterraneo con tutti gli abitanti del mio condominio, ecco che la telecamera inquadra un orrendo palazzo di periferia, e la voce fuori campo ci dice che siamo a Brescia 2 (vicino a Brescia 1, presumo) e che quello che stiamo vedendo è il primo palazzo con rifugio antiatomico condominiale. Una signora che lavora nell’edificio dice che si, in effetti si sente più sicura con il rifugio là sotto, soprattutto dopo quello che è successo in America.
Comunque tutto il condominio sa come si usa, o meglio sa aprire e chiudere le pesanti porte, perché «vede», spiega imbarazzata la donna al giornalista «in realtà il rifugio è pieno di carte, documenti, raccoglitori».
Così ha spiegato che il rifugio viene usato come archivio, e anzi, a dirla tutta, è proprio un ottimo archivio, funzionante e pratico.
Zoommata del cameraman sul rifugio stipato di scaffali e poi ritorno in studio dove il conduttore, con voce compunta, si sente in dovere di aggiungere: «E tutti noi, naturalmente, vorremmo che rimanesse per sempre un archivio!».
E giù applausi.